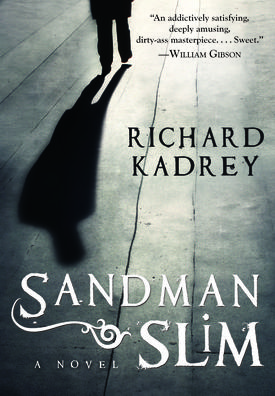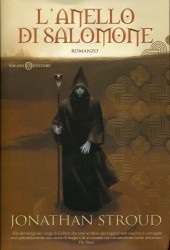È terminata da qualche settimana sulla rete televisiva statunitense HBO la prima stagione di Game of Thrones, serie televisiva tratta dalla saga A Song of Ice and Fire di George R. R. Martin. Per la precisione, questi primi episodi sono tratti dal primo libro della serie, A Game of Thrones (uscito in Italia sdoppiato in due titoli, Il trono di spade e Il grande inverno). A settembre gli episodi usciranno doppiati su Sky, ma io ho preferito guardarmeli subito in originale.
Vi dico subito che sono un fan sfegatato della serie libraria. È vero, Martin non ha inventato nulla di particolarmente nuovo, né dal punto di vista narrativo né da quello dell’invenzione fantastica. Però gli è riuscita un’impresa che moltissimi avevano tentato ma praticamente nessuno aveva portato a termine: emulare Tolkien nel creare un universo immaginario talmente coerente e dettagliato da prendere vita. E, per giunta, lo ha fatto non imitando pedissequamente il maestro, ma facendo tutto il contrario: a differenza della Terra di Mezzo, Westeros non è un luogo in cui si affrontano un Bene e un Male rigidamente definiti. Nell’universo di Martin gli dei sono presenze evanescenti, e persino la magia è in buona parte emarginata ai confini del mondo: al centro della scena ci sono gli uomini, con le loro debolezze e contraddizioni, con storie contrapposte in cui la ragione spesso sta da ambedue le parti o da nessuna. E che sono vittima dei capricci del caso, e muoiono in modi che non hanno nulla di eroico né di necessario. Un fantasy moderno, che non è fatto per mettere a tacere i dubbi, ma per suscitarne.
Sinceramente pensavo che rendere A Song of Ice and Fire in modo soddisfacente in un serial televisivo fosse quasi impossibile, ma mi sono dovuto ricredere in modo completo. Questa prima stagione, probabilmente anche grazie alla collaborazione dell’autore (che ha una lunga esperienza di sceneggiatore TV), ha una fedeltà assoluta alla lettera ma soprattutto allo spirito dell’originale.
Uno degli elementi maggiormente riusciti è stato il casting. Praticamente tutti i personaggi sono stati affidati ad attori molto bravi, molto somiglianti e molto ben calati nella parte. Anche gli attori-ragazzini, che sono spesso il punto debole di queste produzioni, funzionano benissimo (particolarmente bravi quelli nelle parti di Arya e Joffrey), ma in particolare due interpreti giganteggiano: Sean Bean, che è un Eddard Stark solenne e schiacciato dal peso delle responsabilità; e Peter Dinklage che incarna Tyrion Lannister. O meglio, il secondo non giganteggia, visto che è un nano, ma è riuscito nella difficilissima impresa di rendere Tyrion in tutte le sue sfumature, al tempo stesso carismatico e vulnerabile (senza ricadere nella sindrome del “nano comico” che aveva piagato, purtroppo, il Gimli de Il signore degli anelli di Peter Jackson).
Più in generale, la complicatissima trama è resa molto bene, tagliando grandi quantità di dialoghi ma senza eliminare elementi importanti, anzi, riuscendo nonostante tutto a trasmettere ogni singolo dettaglio che forma la storia. Insomma, difficile immaginare che la serie potesse essere fatta meglio e il successo che le ha arriso ne è la prova.
Certo, bisognerà vedere cosa succederà nelle prossime stagioni. I dubbi sono molteplici: riuscirà la serie a mantenere un’audience sufficiente per gli almeno sette anni (ma probabilmente di più) necessari per portare la storia alla sua conclusione? Riuscirà George R. R. Martin a scrivere i due volumi che ancora gli mancano per arrivare al termine prima che la serie TV lo raggiunga? Riusciranno i produttori a ottenere i finanziamenti per tutte quelle scene costose (battaglie campali e navali, draghi, giganteschi metalupi e così via) che nei libri successivi diventano indispensabili alla trama? E come affronteranno il fatto che i numerosi interpreti-ragazzini cresceranno molto più rapidamente dei loro personaggi? Staremo a vedere. Certo, se riusciranno a mantenersi coerenti con le premesse, Game of Thrones rimarrà nella storia della televisione.
 Ci sono altre due cose che vi voglio dire su questo argomento. La prima è che da oggi è finalmente disponibile per tutti (e non solo per gli utenti premium) il numero 6 di Players, che contiene anche un articolo del sottoscritto sulla suddetta serie. Non posso linkarvi direttamente l’articolo, ma lo trovate a pagina 44.
Ci sono altre due cose che vi voglio dire su questo argomento. La prima è che da oggi è finalmente disponibile per tutti (e non solo per gli utenti premium) il numero 6 di Players, che contiene anche un articolo del sottoscritto sulla suddetta serie. Non posso linkarvi direttamente l’articolo, ma lo trovate a pagina 44.
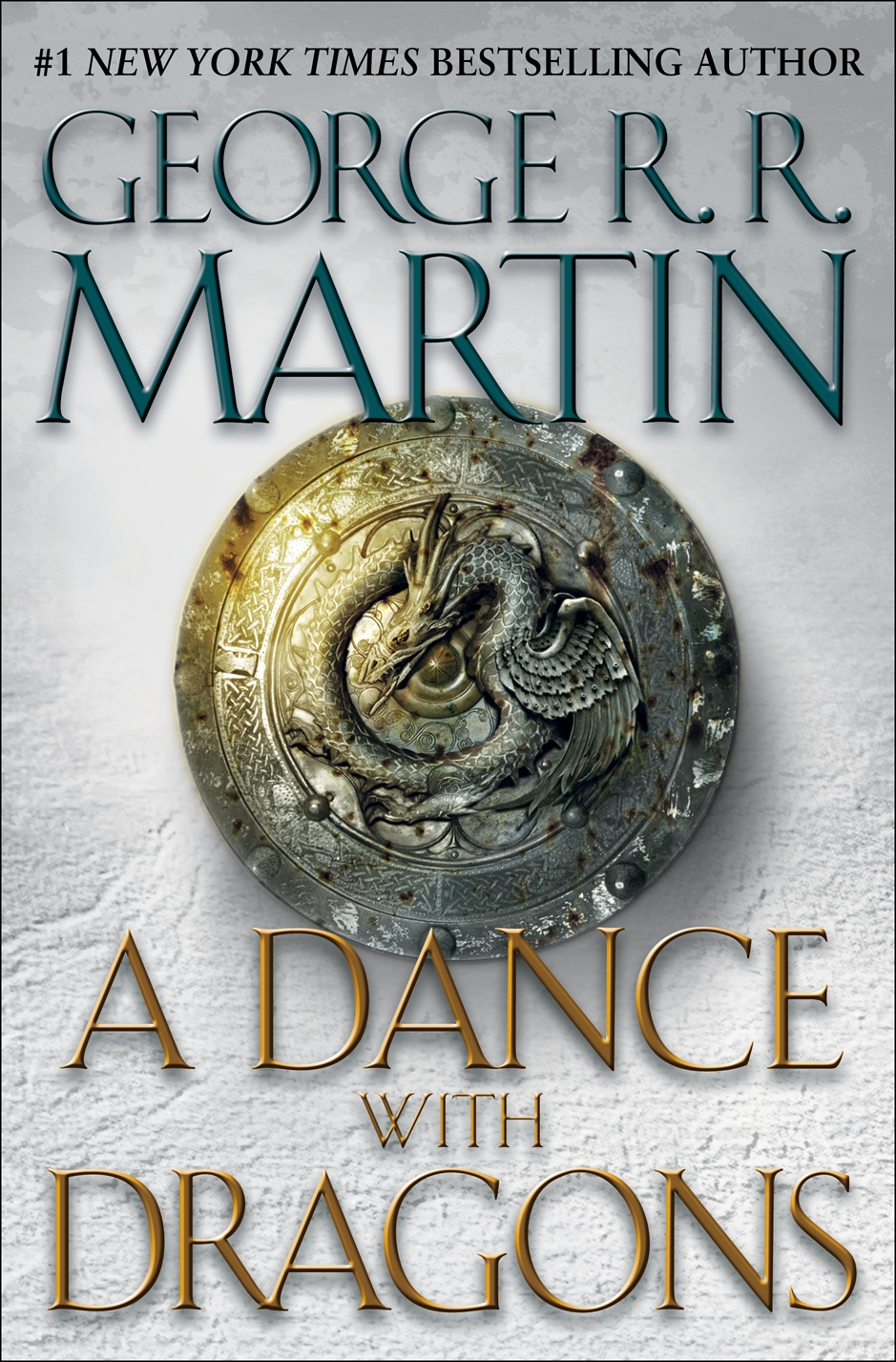
Categoria: Recensioni
Capitan America: Il Primo Vendicatore
 [Questa recensione appare in contemporanea su Fantasy Magazine. La versione che pubblico qui è alquanto diversa, un po’ per adattarla al format che adotto in questo blog, un po’ perché, dopo aver scritto in fretta e furia la versione per FM (che usciva a mezzanotte della notte scorsa!), mi sono venute in mente modifiche e aggiunte, un po’ perché non ho voglia di polemizzare col pubblico indifferenziato di FM.]
[Questa recensione appare in contemporanea su Fantasy Magazine. La versione che pubblico qui è alquanto diversa, un po’ per adattarla al format che adotto in questo blog, un po’ perché, dopo aver scritto in fretta e furia la versione per FM (che usciva a mezzanotte della notte scorsa!), mi sono venute in mente modifiche e aggiunte, un po’ perché non ho voglia di polemizzare col pubblico indifferenziato di FM.]
1941. Steve Rogers è un ragazzo piccolo, mingherlino e asmatico, ignorato dalle donne, vessato dai bulli e impossibilitato a realizzare il suo sogno: arruolarsi per combattere contro i nazisti. Finché il professor Erskine non lo sceglie come cavia per un esperimento destinato a realizzare il Super Soldato…
Non sono mai stato un grande fan di Capitan America. Sarò superficiale, ma è difficile non considerarlo la personificazione dell’arroganza statunitense. un supersoldato, vestito a stelle e strisce, che per giunta combatte per conto dello S.H.I.E.L.D., una specie di versione superpotenziata della C.I.A. Grazie, no.
Perciò sono andato al cinema con aspettative decisamente moderate. E invece Capitan America: Il primo vendicatore, nella sua prima parte, è riuscito a divertirmi e ad appassionarmi non poco, tirando fuori il lato umano del personaggio e persino buttando lì qualche spunto non banale sul significato degli eroi, della guerra e della propaganda. Peccato che poi, arrivati al dunque, il regista Joe Johnston preferisca andare sul sicuro, privilegiando battaglie e sparatorie e dimenticandosi buona parte della carne che aveva messo al fuoco.
La storia del piccolo uomo che improvvisamente trova un superpotere che lo mette in grado di realizzare i suoi sogni e sconfiggere i suoi nemici è l’essenza del genere supereroistico, e qui è stata realizzata in modo tale che è difficile non lasciarsene coinvolgere. È davvero stupefacente come Chris Evans sia stato rimpicciolito digitalmente in modo assolutamente credibile, tanto da far venire il dubbio che a interpretare Steve “prima e dopo la cura” siano due attori diversi. Ma il bello è che dopo la trasformazione Cap non diventa subito l’eroe che conosciamo, ma viene arruolato in un ridicolo spettacolo di propaganda. Mi è sembrato notevole da parte degli autori cominciare l’epopea di Cap con una serie di scene che mettono in ridicolo la sua calzamaglia rossabiancablu e sembrano denunciare la falsità e la retorica che si nasconde dietro ogni guerra. Tutto questo mentre il professor Erskine, tedesco espatriato, insegna a Cap a non odiare il proprio nemico.
Anche tecnicamente il film gioca le sue carte migliori all’inizio, allineando una serie di caratteristi eccezionali: Hugo Weaving come Teschio Rosso, assolutamente perfetto nella sua gelida malvagità; Tommy Lee Jones nella parte del burbero generale; Stanley Tucci come scienziato in lotta contro l’ottusità politico-militare; ma anche il meno conosciuto Dominic Cooper che tratteggia un ottimo Howard Stark (il padre di Tony Stark, alias Iron Man) che ricorda il personaggio storico di Howard Hughes. La ricostruzione storica (o meglio: pseudostorica) è riuscitissima, con apparecchiatura fantascientifiche dall’aspetto retrò che danno davvero la sensazione di qualcosa che i nazisti avrebbero potuto creare se ne avessero avuto la tecnologia a disposizione. Il tutto condito con una sana dose di ironia che rende il tutto sinceramente divertente.
Peccato che tutto questo gran lavoro di costruzione dell’atmosfera e dei personaggi vada poi in buona parte sprecato quando Capitan America trova finalmente la sua ragione d’essere e comincia a combattere sul serio con il Teschio Rosso. Intendiamoci: chi è di bocca buona e si accontenta di vedere un sacco di mazzate ed esplosioni spettacolari non rimarrà deluso: il dipartimento effetti speciali ha fatto il suo lavoro con diligenza. Tuttavia da questo momento in poi la trama diventa spietatamente lineare. Sembra di guardare un film di guerra al triplo della velocità: in teoria dovremmo appassionarci vedendo le diverse personalità dei commilitoni di Cap amalgamarsi fino a formare una squadra unita, e commuoverci di fronte alla morte eroica di qualcuno di loro, ma in realtà i personaggi rimangono sullo schermo talmente poco che di loro non ci importa molto.
Anche l’idea di avere un supereroe dentro la Seconda Guerra Mondiale non viene sfruttata bene, dato che non c’è alcuna relazione con gli eventi storici reali, e nemeno con l’idea generale di una guerra in corso (Cap e compagni entrano ed escono dalla Germania come se ci fosse una porta girevole). E anche l’idea potenzialmente interessante di un Teschio Rosso che si ribella a Hitler per continuare in proprio i suoi disegni viene appena accennata e poi lasciata cadere. Ma soprattutto è deludente il Teschio Rosso stesso che, dopo avere incontrato Cap la prima volta, si limita a perdere una battaglia dopo l’altra fino alla sconfitta definitiva, senza mai inventarsi uno straccio di trovata diabolica che possa non dico creare un colpo di scena, ma almeno impensierire un pochino il nostro eroe. Il finale non ve lo dico, ma ve lo potete immaginare, visto che tutti sanno che il personaggio di Capitan America parteciperà al prossimo film dedicato ai Vendicatori, ambientato ai giorni nostri.
In conclusione, questo Capitan America è un film riuscito solo a metà. Molto più curato della media del genere, con un cast di supporto eccezionale (ma anche Chris Evans fa una figura migliore che come Torcia Umana), a tratti molto divertente, ma che purtroppo non mantiene tutto quanto promette. Colpa anche della regia professionale ma non memorabile di Johnston. Ah, e comincio a essere stufo di questo 3D che aggiunge pochissimo alle scene e ne appiattisce i colori.
Fly from Here
 Un nuovo album degli Yes? Ancora?! Ebbene sì: la quarantatreenne band non si è ancora rassegnata alla pensione, e ha persino registrato un nuovo album in studio, il primo in dieci anni. E ovviamente io, da fan irredento quale sono, mi appresto a recensirlo per voi.
Un nuovo album degli Yes? Ancora?! Ebbene sì: la quarantatreenne band non si è ancora rassegnata alla pensione, e ha persino registrato un nuovo album in studio, il primo in dieci anni. E ovviamente io, da fan irredento quale sono, mi appresto a recensirlo per voi.
Prima di tutto credo che sia necessario un riepilogo delle ultime vicende di una band che, nonostante la sua longevità, può essere considerata una delle più litigiose mai esistite. Il 2008 ha visto l’uscita di due membri storici. Il tastierista Rick Wakeman ha lasciato amichevolmente per problemi di salute, cedendo il posto al figlio Oliver. Molto meno amichevolmente se n’è andato il cantante Jon Anderson, che, nonostante soffrisse di problemi respiratori al punto di dover rimanere per molti mesi in sanatorio, è rimasto oltraggiato quando la band lo ha sostituito con il canadese Benoît David, che gli somiglia non solo nella voce ma anche nel fisico: praticamente un suo clone con vent’anni di meno.
Doveva essere una sostituzione provvisoria, ma è diventata definitiva, e gli Yes sono entrati in studio con due nuove leve per registrare il loro primo album in dieci anni, con la produzione di Trevor Horn (anche lui ex-membro degli Yes). Ma poi è successo qualcosa, e durante le registrazioni Oliver Wakeman è stato silurato (anche se rimangono nel disco suoi contributi come autore e strumentista) e sostituito da Geoff Downes, che rientra nel gruppo 30 anni dopo esserne uscito. Seguendo la tradizione Yes, i motivi dell’avvicendamento non sono stati esplicitati. C’è chi dice che il povero Wakeman junior si sia reso colpevole di scarso rendimento, ma io sospetto invece che le ragioni siano essenzialmente economiche: buona parte del materiale di Fly from Here è firmata dal duo Horn/Downes, e costava meno avere l’autore all’interno della squadra piuttosto che fuori (per lo stesso motivo nel 1997 Billy Sherwood fu cooptato come “sesto membro” della band in quanto coautore di gran parte del materiale dell’album Open Your Eyes).
Con tutti questi cambi di formazione in corsa, ci si potrebbe aspettare un guazzabuglio. La verità è invece che il disco è piuttosto bello.
Per cominciare Downes è un signor tastierista, e si sente fin dalle prime note: Riesce a mettere molta personalità in quello che suona senza strafare. Poi David, che dal vivo mi aveva convinto solo a metà, in studio funziona bene, riesce a cantare nello stesso registro di Anderson ma con un po’ di sobrietà in più, il che non guasta. Più in generale, il disco è compositivamente e produttivamente solido, e riesce a farsi ascoltare per intero senza i riempitivi e le cadute di tono che avevano infestato gli ultimi dischi del gruppo. L’assenza di Anderson e la preminenza di Horn e Downes come autori fanno sì che la musica abbia l’atmosfera malinconica e nostalgica dei pezzi dei Buggles, una piacevole novità rispetto al romanticismo estatico e un po’ stucchevole dei brani andersoniani. Horn ha fatto tutto il contrario rispetto alla sua precedente produzione per gli Yes (90125), e ha abbandonato completamente gli effetti elettronici per dare la sensazione di un disco veramente cantato e suonato, con un sound molto simile a quello degli Yes anni ’70. In alcuni momenti, come per esempio l’overture in cui gli strumenti entrano ad uno ad uno, è davvero entusiasmante. Insomma, potrebbe essere il miglior disco degli Yes in un quarto di secolo.
Questo non significa che Fly from Here sia un capolavoro. A mio avviso ha tre grandi difetti. In primo luogo, se è vero che non ci sono brani da buttare via, è anche vero che non ci sono grandi picchi, e che si mantiene su un livello medio-alto ma senza mai toccare l’eccellenza. In secondo luogo, nulla da eccepire sulle atmosfere retrò, ma da un disco degli Yes mi sarei aspettato un po’ di creatività in più con i suoni. Forse non si poteva pretendere che un gruppo di ultrasessantenni facesse un album sperimentale, però qui hanno davvero evitato qualsiasi rischio. Infine, forse l’età ha influito anche su questo, ma è un disco troppo poco rock: quasi tutti i brani sono mid-tempo, la batteria è sempre molto tranquilla, Howe usa spesso l’acustica e ha suoni in generale poco aggressivi, solo nell’ultimo brano si sente un po’ di energia.
Venendo alle singole canzoni:
- We Can Fly è un brano già noto: Horn e Downes ne scrissero la prima parte nel 1981, quando ambedue facevano parte degli Yes, col titolo di We Can Fly from Here. Fu persino eseguita dal vivo (come testimoniato nell’album The Word Is Live) e già allora l’idea era di trasformarla in una lunga suite. Il progetto non andò in porto causa temporaneo scioglimento della band, ma esistevano già i demo delle parti successive (pubblicati di recente in appendice alla riedizione dell’album dei Buggles Adventures in Modern Recording). Come se niente fosse, gli Yes hanno ripreso in mano il progetto 30 anni dopo e l’hanno portato a termine, sotto forma di una suite di oltre 25 minuti di lunghezza. La musica è bella, emozionante e malinconica, e l’esecuzione magistrale (oltre alla già citata introduzione, ho ammirato le rifiniture davvero splendide di Howe alla slide guitar nella seconda parte, “Sad Night at the Airfield”). Ha però il difetto di suonare più come una sequenza di canzoni affini che come una suite coesa. In particolare lo strumentale “Bumpy Ride” (firmato da Howe a differenza del resto) ha un contrasto troppo netto con ciò che lo precede.
- The Man You Always Wanted Me to Be è un brano “rubato” alla produzione solistica di Chris Squire e ha le caratteristiche abituali dei brani firmati dal bassista: una melodia molto curata, belle armonie vocali, ma la tendenza a durare troppo a lungo senza svilupparsi ulteriormente.
- Life on a Film Set è un altro brano firmato dal duo Downes/Horn, e a mio avviso il migliore dell’album. Bella melodia, bell’arrangiamento, atmosfere malinconiche alla Buggles ma nel contempo la ricchezza di idee dei migliori Yes.
- Hour of Need è un brano firmato da Steve Howe, ed è un po’ una delusione: finisce dopo tre minuti dando la sensazione di essere la grandiosa introduzione a qualcosa che non è arrivato. Lascia perplessi il fatto che nell’edizione giapponese dell’album ci sia una versione del brano che dura il doppio…
- Solitaire è il ritorno a un’amatissima tradizione: il brano acustico solista di Steve Howe. Anche in questo caso però sono leggermente deluso: il pezzo è piacevole, molto classicheggiante, ma non spicca nella produzione del chitarrista.
- Into the Storm è firmata da tutta la band (incluso Wakeman junior), ed è un bel brano roccheggiante in cui fa da protagonista un altro grande redivivo, e cioè il basso con wah-wah di Chris Squire. Se questo è un’esempio di quello che avrebbe potuto essere il suono degli Yes con Wakeman Junior, direi che non è affatto male.
In conclusione, se gli Yes vi piacciono potete acquistare il disco a scatola chiusa: è una delle cose migliori che abbiano prodotto da tanto tempo, e ricrea molti degli elementi per cui gli Yes degli anni ’70 andavano giustamente famosi. Non è però un disco fondamentale. Se non conoscete la band e volete ascoltare una formazione molto simile a questa, consiglio piuttosto l’acquisto di Drama (1980).
I racconti dell'Ernesto
 Ecco un’altra delle cose che non ho avuto tempo di dirvi durante la pausa del vecchio blog. Un po’ di tempo da l’amico Stefano Massaron si è autopubblicato una breve antologia personale in formato PDF, liberamente scaricabile. Contiene cinque racconti che spaziano dall’horror al semplice flash di vita di periferia. Non lasciatevi ingannare dalla copertina bucolica (opera della sua ragazza, Paola Fumagalli): sono tutti racconti piuttosto estremi.
Ecco un’altra delle cose che non ho avuto tempo di dirvi durante la pausa del vecchio blog. Un po’ di tempo da l’amico Stefano Massaron si è autopubblicato una breve antologia personale in formato PDF, liberamente scaricabile. Contiene cinque racconti che spaziano dall’horror al semplice flash di vita di periferia. Non lasciatevi ingannare dalla copertina bucolica (opera della sua ragazza, Paola Fumagalli): sono tutti racconti piuttosto estremi.
Sono affezionato a questa raccolta anche per una ragione molto personale: come potete leggere nell’introduzione, l’idea di assemblarla e pubblicarla è venuta a Stefano mentre era ospite a casa mia per una cena. Mi ha fatto piacere l’avere involontariamente favorito la nascita di un libro.
Potete scaricare il file da questo link. Fatelo, così, quando uscirà nelle sale il film tratto dal suo romanzo Ruggine, potrete dire di aver letto dei suoi racconti che quasi nessuno conosce…
Sandman Slim
James pensava che far parte di una congrega di maghi nella Los Angeles di oggi fosse molto divertente. Finché i suoi compagni non l’hanno tradito e spedito con un trucco all’Inferno. Da vivo. Solo che, per qualche strano motivo, James non è morto. È sopravvissuto e si è indurito. Tanto da assumere il nome di Sandman Slim e diventare un assassino al servizio di un principe demone, di cui gli stessi demoni hanno paura. Ora però è fuggito dall’Inferno con un trucco, ed è tornato a Los Angeles. Per vendicarsi.
Richard Kadrey è stato uno dei fondatori del cyberpunk, nonché l’autore, a mio avviso, di uno dei racconti di fantascienza più originali e provocatori mai scritti (Addio, Houston Street, addio, pubblicato in Italia nell’antologia Cavalieri Elettrici). Stupisce un po’ trovarlo come autore di un romanzo di urban fantasy. Chiariamo subito: Sandman Slim è un romanzo di puro intrattenimento, lontanissimo dalle opere concettuali e politicamente impegnate cui Kadrey ci aveva abituati. Cionondimeno lo consiglio a tutti, perché fa alla perfezione quello che un romando di intrattenimento dovrebbe fare, cioè avvincere e divertire.
Senza inventare nulla di davvero nuovo, Sandman Slim è un frullato di tutti gli ingredienti più sfiziosi che la recente letteratura (ma, direi, soprattutto il fumetto) ha creato in merito ad angeli e demoni. Hellblazer, Preacher, Hellboy ma, per certi versi, anche Harry Potter, forniscono il necessario background che Kadrey non si preoccupa più di tanto di spiegare, lasciando che il lettore trovi da solo la sua strada in una Los Angeles parallela piena di creature soprannaturali. Il tutto con un protagonista che, pur avendo acquisito poteri soprannaturali, è rimasto nell’intimo poco più che un adolescente, e affronta le situazioni più disperate sparando battutine come un Bruce Willis al massimo della forma.
Volendo, critiche al libro se ne potrebbero fare molte. Per esempio, nonostante si parli di Inferno e di demoni e si alluda spesso a orrori innominabili, di fatto il vero orrore non si tocca mai, e persino l’Inferno appare come poco più di un penitenziario in cui chi è abbastanza duro può persino vivere discretamente. Il che rende il libro leggibile anche dagli adolescenti, ma un po’ meno credibile. Inoltre Kadrey fa un lavoro eccellente nello smitizzare angeli e demoni, mostrando che sono tutti parte di uno stesso sistema, né buoni né cattivi in modo assoluto, ma entrambi grigi. Però poi si contraddice vistosamente introducendo dei “veri cattivi” di una malvagità totale. Insomma, come visione metafisica è molto hollywoodiana.
Infine, appare evidente che Kadrey ha previsto il libro come primo di una serie (infatti negli USA ne è già uscito un secondo e sta per uscirne un terzo), e perciò evita di sviluppare del tutto alcuni personaggi (che tiene in serbo per il futuro) e soprattutto conclude con un finale meno “definitivo” di quanto la trama avrebbe implicato.
Comunque sia io mi sono divertito parecchio a leggere Sandman Slim, che trabocca di trovate esilaranti e la cui tensione non cala assolutamente mai. E, quando ci si diverte tanto, si passa sopra volentieri a qualche difetto di fondo.
Questo è uno dei tanti libri che non ho avuto tempo di recensire ai tempi del vecchio blog. Lo faccio ora, un po’ perché è un libro che merita. Ma soprattutto perché è stato tradotto in italiano ed esce in questi giorni in libreria.
Korolev
Nel 2084, una missione umana su Marte scopre i resti di un veicolo spaziale dall’aspetto antiquato, di cui nessuno conosce la provenienza. La spiegazione del mistero risale a più di un secolo prima, quando Sergei Korolev progettava le missioni spaziali dell’Unione Sovietica…
Ho sempre apprezzato lo stile di Paolo Aresi, che invariabilmente mi dà le stesse sensazioni della fantascienza di quando, bambino, ho cominciato ad apprezzare il genere. Quella fantascienza che non era inestricabilmente ibridata con thriller e noir, non richiedeva una laurea in fisica per essere compresa, non richiedeva personaggi complessi e non rivolgeva il suo sguardo verso lo spazio “interno”, ma aveva come protagonista assoluto l’universo extraterrestre e il senso di pericolo, mistero, meraviglia che questo può dare.
Non fraintendetemi: sono il primo ad apprezzare il fatto che la fantascienza non si sia ripiegata su se stessa e abbia trovato nuove strade. Ma certi temi non vanno dimenticati, e su di me hanno sempre un fascino particolare. E, quando leggo Aresi, rivivo le sensazioni che provavo quando leggevo per la prima volta Arthur C. Clarke.
L’effetto si è verificato anche leggendo Korolev. La prima parte, con la missione marziana che si ritrova di fronte all’oggetto misterioso, funziona alla perfezione nel rendere quel misto di eccitazione e angoscia che si prova di fronte all’inesplicabile. Ma anche la seconda parte, che introduce il personaggio storico di Korolev nella russia degli anni ’40, ’50 e ’60, è molto riuscita nel suo dare il senso di una vita e di un’epoca senza eccedere in lungaggini e didascalismi.
Non tutto però mi ha convinto in questo Urania. Comincio col dire che ho trovato stucchevole la trovata di dare a tutti i personaggi il cognome (e spesso anche il nome) di scrittori di fantascienza (o altri nomi celebri). Chiamare Clarke il comandante della base marziana ci poteva stare benissimo, ma quando si incontrano di continuo personaggi si chiamano Neil Gaiman, Hal Clement, Robert Heinlein o Edmond Hamilton, il tutto prende un’atmosfera surreale che allontana dalla storia.
Ma soprattutto, la terza parte, quella che dovrebbe risolvere ogni cosa e far prendere il volo al romanzo, sacrifica invece quasi tutto alla linearità dell’apologo morale. Ho trovato poco credibile e poco interessante il fatto che il mondo del 2084 sia politicamente diviso negli stessi blocchi rigidi degli anni ’50, con l’Europa totalmente succube degli USA e la Cina della Russia: il mondo multipolare che già oggi possiamo intravedere sarebbe stato uno scenario molto più ricco di spunti. Ma quello che mi ha lasciato più insoddisfatto come lettore è che, dopo averci fatto intravedere la possiiblità di epocali scoperte, il romanzo si concluda lasciando intatti tutti i misteri che aveva suscitato. È vero che Arthur C. Clarke ci ha insegnato che non è necessario spiegare tutto, però qui, dal punto di vista fantascientifico, nell’ultimo terzo del romanzo non succede più nulla di notevole. Solo un confronto politico-militare che si risolve senza sorprese.
Un peccato, perché la storia parte bene e avrebbe meritato uno sviluppo più approfondito. Comunque Korolev resta una piacevole lettura e un rinfrancante diversivo rispetto a tanta fantascienza di oggi che affatica il lettore senza dargli niente in cambio.
I guardiani del destino
Un giovane politico americano di successo incontra per caso quella che sembra essere la donna della sua vita. Ma dei misteriosi “Guardiani” gli ordinano di non rivederla più, in quanto non fa parte del “Piano”. Scopre così che le vite degli uomini sono costantemente monitorate e “corrette” e che il libero arbitrio è un’illusione…
The Adjustment Bureau (questo il titolo originale di I guardiani del destino) è tratto da un racconto di Philip K. Dick. Di per sé questo non è garanzia di buon risultato. Dick non è affatto uno scrittore facile da rendere al cinema: le sue trame o sono statiche o si muovono in troppe direzioni contemporaneamente, costringendo gli sceneggiatori a reinterpretarlo. Anche Blade Runner, ormai un archetipo cinematografico, riesce a essere un grande film proprio tradendo sottilmente in molti modi l’opera originale. Per il resto, nonostante Dick sia un autore saccheggiatissimo, c’è ben poco di cui gioire. I tentativi più ambiziosi, Atto di Forza di Verhoeven e Minority Report di Spielberg, cominciano bene ma gradamente perdono la carica eversiva dickiana per trasformarsi in banali film di genere. D’altra parte, A Scanner Darkly, nella sua eccessiva fedeltà al testo, risulta ingessato e poco significativo. Screamers a mio avviso ha una sceneggiatura imbarazzante, Impostor non l’ho visto ma se ne parla malissimo, e quanto a Paycheck è stato talmente esecrato che mi viene quasi voglia di difenderlo (ma me ne guardo bene!). Insomma, i successi sono ben pochi, specie a fronte di altri film che hanno sfruttato temi dickiani ma senza farlo in modo esplicito, come The Truman Show, Dark City o Vero come la finzione, per citare i primi tre che mi vengono in mente.
Tutto queso per dire che il regista George Nolfi (sceneggiatore al debutto nella regia), per convertire in film il breve racconto The Adjustment Team, aveva in qualche modo l’obbligo di tradirlo. Il modo che ha scelto, però, mi è rimasto sul gozzo.
I guardiani del destino è la storia di un uomo che, come tanti personaggi di racconti di Dick (uno tra tutti: l’eccezionale La formica elettrica) scopre per caso che la realtà è completamente diversa da come la conosceva, e che quelle che riteneva di essere sue libere scelte di vita sono in realtà state pianificate da forze al di fuori del suo controllo. Nella fattispecie, da una casta di grigi burocrati che lavorano “dietro le quinte ” del mondo e si preoccupano di far succedere cose apparentemente per caso, in modo che tutti continuino a seguire un misterioso “Piano” il cui scopo nessuno sembra conoscere.
Più che nell’interpretazione non particolarmente memorabile di Matt Damon, il film ha il suo maggior pregio nella rappresentazione dei Guardiani, grigi e annoiati, i cui sofisticatissimi strumenti di controllo hanno sempre un aspetto sorpassato e banale, come appropriato per una burocrazia opprimente e ottusa. E la parte migliore del film è indubbiamente quella in cui il protagonista lotta in modo sempre più disperato contro lo strapotere dei guardiani.
Purtroppo però Nolfi decide di risolvere il film con un lieto fine che stride terribilmente con tutto ciò che aveva costruito fino a quel momento. Io non sono contrario pregiudizialmente al romanticismo e ai finali positivi, tuttavia trovo insensato (oltre che un tradimento totale dello spirito dickiano) partire un racconto che parla della mancanza di libertà della condizione umana per poi alla fine rivoltare la frittata e dire: “abbiamo scherzato, l’Uomo è libero di fare ci che vuole se si impegna abbastanza”. Peccato, perché il film avrebbe meritato, ma questo finale proprio non sta in piedi.

Nota: Per uno strano scherzo delle leggi sul copyright, il racconto originale The Adjustment Team è oggi fuori diritti e di pubblico dominio. Chi volesse leggerlo lo può fare qui.
Boris – il film
Il regista René Ferretti, ormai in disgrazia, è costretto ad accettare lavori televisivi ancora più infami di quelli che girava in passato. Quando Sergio, il direttore di produzione, gli propone di dirigere un film tratto da La Casta, René pensa di avere finalmente l’occasione di riscattarsi dalla melma televisiva…
Con tutto l’affetto che posso portare agli autori e agli interpreti di quella che è stata una delle più grandi e rivoluzionarie serie televisive italiane di tutti i tempi, non c’è altro modo per dirlo: Boris – il film è una grandissima occasione perduta.
Il pregio maggiore di Boris serie TV era quello di costituire un perfetto controesempio di ciò che narrava. Tanto la telenovela Gli occhi del cuore che i personaggi realizzavano era becera, malfatta, noiosa, priva di qualità e di contenuti, tanto Boris risultava invece una serie raffinata, curatissima, divertente, originale e con un forte contenuto critico. Per cui si creava una tensione fortissima tra la TV “come potrebbe essere” e “com’è”, che amplificava sia il divertimento, sia l’efficacia del messaggio. Per replicare al cinema lo stesso meccanismo sarebbe stato perciò necessario realizzare un film che non fosse la semplice trasposizione al cinema di una serie TV, ma che fosse un prodotto cinematograficamente sensato da ogni punto di vista, e fruibile indipendentemente dalla conoscenza degli episodi precedenti.
In teoria gli autori della serie erano della stessa opinione. In pratica, però, hanno fatto il contrario. Il trio di sceneggiatori-promossi-registi Ciarrapico, Torre e Vendruscolo, infatti, non solo non ha inserito nel film idee di regia particolarmente ardite, ma ha imbastito una sceneggiatura che di cinematografico ha poco o nulla: in pratica una quarta stagione televisiva di Boris. Dove sarebbe stato necessario sfoltire senza pietà i personaggi per concentrarsi sulla vicenda di René, si è invece scelto di dare uno spazio praticamente a chiunque fosse apparso in precedenza. Per giunta, dato che in questo modo il materiale era di gran lunga sovrabbondante (pare siano state superate le tre ore), per ridurre il tutto a una durata ragionevole sono stati fatti dei tagli, come direbbe René, a cazzo di cane.
Risultato: molti dei personaggi principali sono sacrificati, altri sembrano messi lì ad aspettare un ruolo che non arriva (mi dite a cosa serve Itala in questo film, per esempio?), alcuni filoni narrativi si perdono nel nulla (come il ritorno di fiamma tra Alessandro e Arianna, che non si risolve e nemmeno contribuisce alla storia principale) e alcune scene sono addirittura incomprensibili (per esempio quella in cui Biascica sorprende Alessandro e gli pone una serie di domande che, senza alcuna ragione, sembrano implicare un interesse erotico nei suoi confronti: è evidente che lì alla storia manca un pezzo). A questo punto si spera che un giorno esca in DVD una versione con le scene tagliate che ci chiarisca i tanti punti oscuri. Però io sono tra coloro che si irritano quando pagano il biglietto per un film e si trovano di fronte un lungo trailer.
Sono troppo esigente? Forse. Ma Boris ci aveva autorizzato ad avere aspettative elevate. È tutto da buttare il film? Ovviamente no. Boris – il film resta comunque molto divertente e caustico. La satira del mondo cinematografico italiano è feroce e puntuale. Le rivisitazioni dei vecchi personaggi, come l’ennesimo stratagemma usato per neutralizzare la pessima recitazione di Corinna, sono spesso esilaranti. E c’è almeno un personaggio nuovo, quello della Migliore Attrice Italiana (intepretato in modo magistrale dalla praticamente sconosciuta Rosanna Gentili), che strappa l’applauso. Gli interpreti sono sempre bravi e Pannofino bravissimo. Insomma, non vi dico di non vederlo (cosa che peraltro sarebbe inutile, visto che è uscito dalle sale da una vita), al contrario, compratevi il DVD (se e quando uscirà) e riderete spesso di gusto, probabilmente molto più di quanto non fareste con una media commediola italiana. Solo che questo non era una commediola italiana, era Boris – il film, accidenti.
Le circostanze dell'amore
1898. La giovane Guglielmina, di nobile famiglia torinese, abbandona a malincuore i propri studi di botanica per seguire i genitori in Sicilia e presenziare al matrimonio del fratello. Qui si innamorerà di Angelica, l’altera e sensuale sorella della sposa, e dovrà lottare, oltre che contro le convenzioni che non prevedono che lei possa amare una donna, e nemmeno imboccare una carriera accademica, anche contro Elizabeth, l’amante inglese di Angelica.
Questo è un libro in cui sono coinvolto personalmente: l’autrice mi ha fatto l’onore di poterlo leggere in bozza, e anche di influire sul risultato finale dando qualche consiglio di editing. Quindi forse non sono un giudice imparziale. Tuttavia questo non mi esime dal consigliarvi di leggerlo, perché mi ha tenuto avvinto dalla prima all’ultima pagina.
L’amica Alessia Muroni ha sfruttato il suo background di storica dell’arte per ricostruire l’Italia di più di un secolo fa in maniera credibilissima, e lo ha fatto con una scrittura così attenta al dettaglio da far davvero percepire al lettore colori e profumi di un’altra epoca. Ma quello che fa di Le circostanze dell’amore un romanzo riuscito sono le due protagoniste, l’introversa e testarda Guglielmina e l’esuberante Angelica, personaggi a tutto tondo alla cui storia d’amore è impossibile non appassionarsi. Intorno a loro orbita una gran massa di personaggi, tutti cesellati con arguzia e ironia e rifuggendo da didascalismi e stereotipi.
Devo dire altro? Credo di avere incontrato pochi romanzi d’esordio italiani che mostrassero altrettanta cura nella documentazione e sapienza nella costruzione della storia e dei personaggi. Se aggiungiamo che si tratta di un’opera che riesce a trattare un tema impegnato senza essere noiosa, mescolando con equilibrio dramma e umorismo, direi che non avete alcuna ragione per non correre a leggerlo.
L'anello di Salomone
La giovanissima Asmira viene inviata dalla regina di Saba a uccidere re Salomone, che le minaccia guerra se non pagherà un pesante tributo. L’impresa è disperata, poiché Salomone possiede un anello magico di eccezionale potenza, che pone decine di maghi e centinaia di geni al suo servizio. Ma, quando uno di quei geni è Bartimeus, si può star certi che le cose non andranno come previsto.
La trilogia di Bartimeus è una delle serie fantasy più originali e divertenti sul mercato. Una buona parte del merito va al personaggio del genio Bartimeus, vanaglorioso e cialtrone ma pieno di risorse, dispensatore di velenosi sarcasmi in prolisse note a pié di pagina. Ma bisogna dire che Stroud riesce anche nel difficile compito di servire un prodotto accessibile ai ragazzi evitando, e spesso ribaltando, ogni possibile cliché, cosa che rende i suoi romanzi perfettamente leggibili anche da un adulto. I maghi di Stroud sono tutti personaggi perlomeno discutibili, perché la magia è potere, e il potere corrompe. Se qualcuno fa del bene, di solito lo fa al di là delle proprie intenzioni. E non di rado i suoi finali hanno un gusto amaro del tutto incompatibile con la tradizione del lieto fine di tanta paccottiglia fantasy contemporanea.
In L’Anello di Salomone Stroud riprende in mano il personaggio di Bartimeus per un prequel ambientato millenni prima della trilogia originale. Una scelta probabilmente inevitabile, dato che il finale della trilogia lasciava poco spazio a seguiti, ma che pone però dei limiti all’evoluzione del genio, che non può essere diverso da quello che già conosciamo. Il risultato è un romanzo avvincente, esilarante al punto da farti scoppiare a ridere mentre lo leggi, ma che alla fine lascia un filo di delusione, perché aggiunge ben poco alla trilogia preesistente. L’ambientazione (un Israele mitologico purgato da ogni riferimento religioso) non ha il fascino e l’originalità della Londra popolata da maghi dei volumi precedenti. Anche il personaggio di Asmira è un po’ troppo monodimensionale, e l’intrigo che sta alla base della vicenda è facilmente intuibile. Questo non vuol dire che chi ha nostalgia di Bartimeus non debba correre in libreria, dato che il romanzo è comunque pieno di trovate pirotecniche e si legge d’un fiato. Ma da Stroud ci si poteva legittimamente aspettare di più.