
È il caso di inviare messaggi agli alieni per fargli sapere che siamo qui? Può sembrare una questione confinata ai romanzi di fantascienza, ma invece in questo momento ci sono persone serissime che la stano dibattendo animatamente.
Messaggi agli alieni in realtà ne abbiamo già mandati, però le probabilità che qualcuno possa riceverli sono piuttosto scarse. Abbiamo incluso messaggi sulle sonde spaziali destinate a lasciare il Sistema Solare: delle targhe sui Pioneer, dei dischi con codifica digitale sui Voyager. Tuttavia il loro viaggio è lentissimo: è ancora oggetto di discussione se siano uscite o meno dalla sfera di influenza del Sole, e passeranno decine di migliaia d’anni prima che transitino vicino a un’altra stella. Anche ammesso che esistano altri sistemi stellari abitati, potrebbero passare milioni di anni prima che ne incontrino uno, e anche in quel caso non è affatto detto che qualcuno si accorga del loro passaggio.
Quarant’anni fa, utilizzando il radiotelescopio di Arecibo in modalità trasmittente, abbiamo anche trasmesso un messaggio radio in direzione dell’ammasso globulare di Ercole M13, codificando alcune basilari informazioni sulla natura della vita sulla Terra. A prima vista potrebbe sembrare che questo messaggio abbia maggiori possibilità di essere ricevuto, dato che M13 contiene circa 350.000 stelle, e quindi si potrebbe sperare che almeno una di esse abbia un pianeta abitato. A ben guardare, però, le cose stanno diversamente. Per cominciare, gli ammassi globulari sono un ambiente molto poco favorevole alla formazione di pianeti. Ma soprattutto, il messaggio impiegherà 25.000 anni ad arrivare fin laggiù,e nel frattempo M13 si sarà spostato da tutt’altra parte. Salvo l’evento altamente improbabile che un alieno passi proprio sulla sua traiettoria al momento giusto, il messaggio si perderà nel nulla.
Ora però si sta pensando di cominciare a fare sul serio, a causa della frustrazione dei partecipanti a SETI. La sigla sta per Search of Extra Terrestrial Intelligence (ricerca di intelligenza extraterrestre), e indica un programma di ricerca privato che da più di 40 anni scandaglia in vari modi le frequenze radio per trovare i segni della presenza di alieni da qualche parte nell’Universo. Personalmente ho sempre pensato che l’approccio di SETI abbia dei limiti, dato che si basa sulla presenza di radiazioni elettromagnetiche per individuare le civiltà aliene. Non è detto che questo sia un buon metodo: la civiltà umana ha scoperto l’elettromagnetismo da meno di un secolo e mezzo. Magari tra cinquant’anni scoprirà qualcosa che renderà obsolete le comunicazioni basate sulle onde radio, che ci sembreranno antiquate come usare un eliografo invece che spedire una e-mail.
In ogni caso SETI non ha finora cavato un ragno dal buco, e perciò molti dei suoi adepti stanno pensando di passare a qualcosa che chiamano Active SETI (ricerca attiva di intelligenza extraterrestre) o METI (invio di messaggi verso l’intelligenza extraterrestre). Si tratterebbe in pratica di sistematizzare l’invio di messaggi verso l’esterno, nella speranza di farci sentire sul serio da qualcuno. Tuttavia c’è chi obietta fortemente a questo sviluppo. Farci notare da alieni di cui non sappiamo assolutamente nulla, dicono, è un salto nel buio. Guardando alla storia umana, dove spesso intere civiltà sono state completamente annichilite dall’incontro con un’altra tecnologicamente più avanzata, il contatto con gli extraterrestri comporterebbe grossi rischi. Soprattutto, si tratta di un’iniziativa che non dovrebbe essere presa per iniziativa di un singolo gruppo, ma andrebbe decisa dall’umanità nel suo insieme.
Su questo temo si è tenuta in questi giorni una serissima discussione presso l’AAAS (l’associazione americana per il progresso della scienza). A difendere la tesi per cui da un contatto con gli extraterrestri può venire solo del bene c’era l’attuale direttore della composizione dei messaggi interstellari di SETI, Douglas A. Vakoch. Curiosamente, a sostenere la tesi opposta c’era uno scrittore di fantascienza, cioè il tipo di persona che ci aspetteremmo più incline a voler incontrare gli alieni. In effetti David Brin è un bravissimo autore (il suo Thor Meets Captain America è uno dei miei racconti preferiti di sempre), ma è anche un astrofisico, ed è uno dei più convinti oppositori della ricerca attiva di intelligenze aliene.
Difficile dire di primo acchito chi abbia ragione. Da un lato, potremmo pensare che la nostra paura degli alieni sia solo un fatto culturale, un mero riflesso della nostra natura aggressiva e diffidente. Tuttavia è vero che non sappiamo assolutamente nulla di loro, nemmeno se esistano o no. Chi può dire se andando incontro agli extraterrestri non ci comporteremmo come i dodo che accoglievano fiduciosi gli spagnoli pronti a metterli in pentola? Proveremo a parlarne più in dettaglio in futuro.
Mese: Febbraio 2015
L'ultima colonia
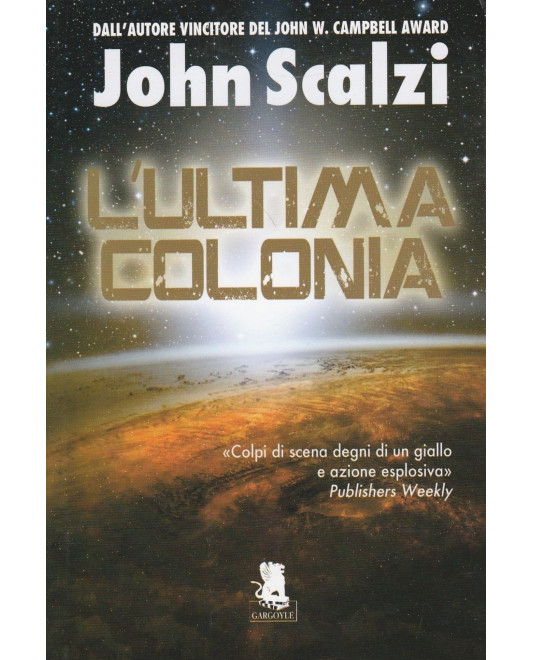
Dopo gli eventi visti in Morire per Vivere e Le Brigate Fantasma, John e Jane si sono sposati, hanno avuto nuovi corpi più adatti alla vita civile, e vivono una pacifica vita da agricoltori insieme alla figlia Zoe. Ma l’Esercito ha ancora qualcosa in serbo per loro, e li convince a guidare una spedizione per colonizzare il pianeta Roanoke. Presto si renderanno conto che le cose non stanno esattamente come gli è stato detto, e che i civili loro affidati vengono usati come pedine in una partita diplomatica dove potrebbero tranquillamente essere sacrificati…
Questo è il terzo volume della serie Old Man’s War, per ora l’ultimo pubblicato in Italia, mentre negli USA sono già usciti anche Zoe’s Tale, che racconta gli stessi eventi di questo romanzo ma dal punto di vista di Zoe, e il successivo The Human Division, e sta per uscire The End of All Things.
Recensendo i due volumi precedenti avevo espresso le mie forti riserve verso l’impostazione politica dei romanzi di Scalzi, totalmente orientata verso un acritico militarismo. Tuttavia, nel corso di un’intervista che mi aveva rilasciato per Players, lo stesso autore mi aveva ammonito a non scambiare le posizioni dei personaggi per le sue, e a prendere in considerazione l’intera serie prima di giudicare. Devo riconoscere che in questo terzo episodio l’Esercito perde la sua immagine di istituzione totalmente positiva e viene descritto come fallibile, accentratore e manipolatore. Una brusca correzione di rotta (che peraltro non inficia le mie critiche agli episodi precedenti). Questa apertura progressista non è però bastata a farmi piacere il romanzo, che a mio avviso fa fare alla serie un passo indietro.
Attenzione: parlo seguendo i miei gusti personali. Dal punto di vista tecnico, L’Ultima Colonia è scritto piuttosto bene, con una trama piena di ritmo e di colpi di scena, personaggi ben caratterizzati, e continue variazioni di atmosfera che permettono di arrivare fino in fondo senza annoiarsi. E l’intreccio politico-diplomatico-militare è ben studiato.
Tuttavia io non riesco proprio ad appassionarmi alla visione retrò della fantascienza di Scalzi. Perlomeno nei due volumi precedenti c’era una tecnologia militare interessante, originale e moderna. Ma quando si esce dall’ambito strettamente guerresco l’autore perde tutta la sua inventiva. La società che descrive non solo non è futuribile, ma nemmeno contemporanea, e sembra essere stata concepita negli anni Cinquanta. Si direbbe che l’unico motivo per cui i personaggi colonizzano pianeti è trovare nuovi territori dove piantare patate e allevare maiali, e che il principale obiettivo strategico sia quello di moltiplicare la consistenza della propria popolazione. Concezioni decisamente fuori dal tempo.
Il punto più debole di tutta l’opera è però quello che sarebbe dovuto essere il suo centro, e cioè il pianeta Roanoke. Data la sua importanza nell’economia del romanzo mi sarei aspettato un buon livello di dettaglio e di originalità. Invece, tutto quello Scalzi ci dice di Roanoke si può riassumere in due righe: ci sono roditori simili a topi con quattro occhi, predatori simili a lupi con quattro occhi, abitanti primitivi ma intelligenti che somigliano a lupi mannari, e bellissimi tramonti, ma l’atmosfera puzza di ascelle. Stop. Un fondale di cartapesta sarebbe stato più interessante.
Mi sono reso conto che una fascia importante, e forse addirittura maggioritaria del pubblico della fantascienza ama molto i romanzi avventurosi, senza eccessive complicazioni scientifiche e ispirati a opere del passato. Per costoro L’Ultima Colonia contiene tutto quello che serve, confezionato in modo professionalmente valido. A me però è sembrato affrettato e privo di vero interesse.
Distopie
 Come dicevo qualche tempo fa, ultimamente ho preso l’abitudine di leggere anche testi di narrativa autopubblicati, che in precedenza ignoravo. Questo dopo aver constatato che la crisi spinge a ricorrere all’autopubblicazione anche autori validissimi che però non trovano spazio in un mercato librario nazionale sempre più asfittico e, di conseguenza, pavido e miope.
Come dicevo qualche tempo fa, ultimamente ho preso l’abitudine di leggere anche testi di narrativa autopubblicati, che in precedenza ignoravo. Questo dopo aver constatato che la crisi spinge a ricorrere all’autopubblicazione anche autori validissimi che però non trovano spazio in un mercato librario nazionale sempre più asfittico e, di conseguenza, pavido e miope.
Tra questi autori c’è anche Stefano Massaron, scrittore pubblicato da Einaudi e dal cui ultimo libro è stato tratto anche un film, ma che ha scelto, a titolo di esperimento, di pubblicare in proprio una serie di ebook intitolata I racconti dell’Ernesto.
Confesso di non sentirmi imparziale nel giudicare la raccolta in questione. Non solo Stefano è un amico, ma è stato proprio a casa mia, durante una cena, che il comune amico Ernesto gli ha estorto la promessa di non limitarsi a scrivere romanzi, ma anche qualche racconto. Questo secondo volume della serie si intitola Distopie ed è dedicato alla fantascienza, anzi, alla particolare branca della fantascienza nota come distopia. Impossibile perciò evitare di parlarne qui (colpevolmente, a un anno dalla sua uscita).
Il pezzo forte di Distopie è il romanzo breve Lo schianto delle caramelle. Ambientato nella più classica delle distopie, uno stato di polizia con fortissime differenze sociali, parla di due sorelle clandestine che affrontano un pericoloso pellegrinaggio per consultare un oracolo, che per divinare il futuro usa uno strumento antichissimo: una copia del videogioco Candy Crush.
Sulla carta Lo schianto delle caramelle non sembra avere molti elementi che lo rendano interessante; ed ha pure l’aggravante di utilizzare come principale motore della trama i poteri mentali, un cliché che ha ancora cittadinanza nel cinema e nel fumetto, ma che dalla fantascienza scritta è quasi scomparso. E tuttavia basta iniziare a leggere per ricredersi completamente ed essere trascinati nella storia. Perché la buona fantascienza è fatta di dettagli, e qui sono tutti al posto giusto: personaggi credibili e che è impossibile non amare o odiare, tecnologie sorprendenti ma plausibili, e soprattutto una realistica ambientazione in un suk in cui si parla un bizzarro linguaggio italo turco. Alla fine spiace soltanto che l’avventura finisca troppo presto. Stefano nella postfazione promette di espanderla in un romanzo vero e proprio. Io, se fossi un editore, correrei a prenotarlo. Ma si sa, siamo in Italia.
Completano l’ebook due racconti inquietanti e dai temi fortemente simbolici. Mi è piaciuto molto Il vetro, tutto condotto sul filo della canzone di Lou Reed Magic and Loss, in cui Milano è cinta da una soffocante barriera trasparente che allude alle barriere meno tangibili, ma altrettanto difficili da valicare, tra le persone. Un po’ più convenzionale Fallen Feather, in cui Stefano accentua il suo lato più romantico contrastandolo con un’ambientazione violenta e sanguinosa.
Nel complesso, ottima fantascienza, più riuscita e originale di molta di quella che si trova in giro. La mia speranza è che Stefano continui a battere queste strade.
Sonetti spaziali

Qualche mese fa, in occasione dell’approdo sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko del lander Philae sganciatosi dalla sonda Rosetta, fu molto sbeffeggiato in rete il relativo servizio del TG4 a firma Mauro Buffa. In esso l’autore deprecava la spesa “francamente eccessiva” della missione, dando voce a un sordo antiscientismo purtroppo molto diffuso nel nostro paese.
Non è però per questo che lo cito, bensì per il fatto che il servizio accusava la sonda non solo di essere inutile, qualcosa che eccita “solo gli scienziati” (evidentemente gente strana e da non prendere a esempio), ma anche di danneggiare le persone comuni, rovinando per sempre l’immagine dell’astro natalizio e sostituendola con quella di un “grosso sasso polveroso”, del tutto privo di mistero e di interesse.
Se fosse solo il TG4 a sostenere che l’esplorazione spaziale distrugge la poesia, non darei molto peso a questa tesi. Tuttavia lo stesso concetto è stato espresso anche altrove con maggiore autorevolezza. Per esempio su Il Sole -24 Ore, poco prima dell’episodio che ho citato, è apparso un interessante articolo di Massimo Bucciantini che, prendendo a prestito le parole di Primo Levi, esprime un dubbio simile.
All’indomani dello sbarco sulla Luna, Levi si chiedeva se l’impresa sarebbe stata ancora in grado di farci meravigliare. “Il volo di Collins, Armstrong e Aldrin è troppo programmato, troppo poco ‘folle’, perché un poeta vi trovi alimento”, scriveva su La Stampa. Da qui prende le mosse il professor Bucciantini, che traccia un’interessante storia del rapporto degli uomini con la Luna mano a mano che la conoscenza è progredita, concludendo però con il dubbio che con le missioni lunari “quella continuità si sia spezzata”.
Sono rimasto sorpreso scoprendo che Levi avesse questo dubbio, lui che riusciva a rendere poetica la tavola periodica di Mendeleev, o a scrivere un racconto struggente intorno a dei barattoli di vernice che fa grumi quando non dovrebbe. Ma sarà poi un dubbio fondato? Io ho la sensazione che l’esplorazione dello spazio apra tanti varchi all’immaginazione quanti sono quelli che chiude. Forse è un po’ presto perché appaia un Grande Poeta a cantare il mistero dello spazio come lo vede la scienza moderna (in fondo è da poco più di mezzo secolo che l’uomo è in grado di lasciare il pianeta, e tuttora con forti difficoltà). Ma non vedo perché non dovrebbe prima o poi apparire.
Facendo queste considerazioni, mi ha confortato scoprire che l’ultima poesia di Edoardo Sanguineti, ancora una volta riportata da La Stampa, riguardava quasar, pulsar e altre entità misteriose che sono recentissime scoperte della scienza moderna. Ve la trascrivo qui:
Sonetto astrale
pulsano pulsar con forti pulsioni:
ecco a voi quasar, quasi stelle vive:
collassano assai dense, per pressioni
che imbucano per sempre, in nere rive:
così forse è: facelle in evezioni,
sciami di nebulose fuggitive,
supergiganti, code in librazioni,
variabili cefeidi recidive:
protuberanze, e getti, e radiazioni
corpuscolari, eclissi comprensive
di pieni pianetini e pianetoni,
aurore ipercompresse in somme stive:
oh, chiare notti gravitazionali,
mie fragili scintille zodiacali!
Se conoscete altre poesie dedicate allo spazio visto con occhi moderni, vi prego di segnalarmele al mio account Twitter (@Vanamonde65). Se le segnalazioni saranno abbastanza, potremmo fare della poesia spaziale un appuntamento fisso di questo blog. Alla prossima!
La lingua della scienza

Da quando il Politecnico di Milano ha deciso che terrà i propri corsi esclusivamente in lingua inglese, è sorta una polemica infinita tra i sostenitori e gli oppositori di questa decisione, sfociata anche in una battaglia legale approdata addirittura alla Corte Costituzionale.
Le motivazioni che hanno spinto il Politecnico a fare questa scelta sono sicuramente ragionevoli. È vero che oggi l’inglese è la lingua della scienza e della tecnologia, e pertanto non si può pensare che qualcuno si laurei in ingegneria senza conoscerla bene. Ed è probabilmente vero che l’insegnamento in inglese aiuterebbe ad attirare studenti stranieri, il che sarebbe positivo non solo per l’ateneo ma per tutto il Paese.
Ho sentito alcuni paventare che costringere i professori a esprimersi in inglese farebbe scadere la qualità dell’insegnamento. Ammetto che, pensando ad alcuni professori che ho avuto io, mi è venuto lo stesso dubbio. Ma credo che sia un problema superabile. Di recente mi è capitato di assistere a un convegno scientifico a Verona in cui la lingua ufficiale era l’inglese. Uno dei partecipanti espose una slide con la scritta “si ricorda che la lingua ufficiale di questo convegno è il Bad English!”. Però, battute a parte, la qualità dell’inglese parlato risultò accettabile, forse sconsigliabile a chi volesse prenderla come base per lo studio della grammatica, ma più che comprensibile.
Nonostante tutto questo, però, io continuo a considerare con un po’ di apprensione l’idea di un’Università in Italia dove si studi solo in inglese, anche se si tratta di una facoltà scientifica o tecnologica. Io mi sono laureato in ingegneria aeronautica proprio al Politecnico di Milano. Pur non avendolo studiato a scuola, quando ero matricola conoscevo già discretamente l’inglese, avendolo appreso da canzoni, videogiochi, giochi di ruolo, qualche lezione privata e un mese di soggiorno all’estero. Ma durante la mia permanenza all’università la mia conoscenza della lingua migliorò molto, in buona parte per la necessità continua di utilizzarlo. Dopo il biennio non c’era praticamente corso i cui testi principali non fossero in inglese, per non parlare degli gli articoli che mi servirono per la tesi di laurea. Quindi a mio avviso, anche senza lezioni in lingua straniera, l’inglese lo si impara comunque.
D’altra parte, al Politecnico ho imparato anche un bel po’ di gergo specialistico italiano. Ho appreso, per esempio, che la componente della forza aerodinamica perpendicolare al vento relativo, e che perciò tiene l’aereo in volo (in inglese lift), in italiano si chiama portanza. Ho imparato che un veicolo che sfrutta la portanza per volare viene detto velivolo, un termine che in inglese neppure ha il corrispondente, e che è stato inventato nientemeno che da Gabriele D’Annunzio. Ho scoperto che l’azione di un corpo che gira su se stesso poggiando su un unico punto, come fa una trottola, si chiama prillare (in inglese to spin), una parola che al di fuori dei testi tecnici ho trovato solo nel Pasticciaccio di Gadda (che non a caso al Politecnico aveva studiato).
Potrei andare avanti a lungo. Certo, bisogna notare che si tratta di un gergo ottocentesco o del primo Novecento. Oggi l’evoluzione di scienza e tecnologia è talmente rapida, e le comunicazioni talmente immediate, che quasi mai la traduzione italiana di un neologismo inglese riesce ad imporsi. Oggi usiamo il computer, nonostante sia sempre esistito l’analogo italiano calcolatore. Nessuno ha mai pensato di usare un topo al posto del mouse, e anche nei rarissimi casi in cui si adotta una parola italiana, diventa subito obsoleta: chi mai oggigiorno usa più un masterizzatore? E tuttavia quel gergo scientifico di base della lingua italiana non è inutile: permette di parlare di scienza e di tecnologia in una lingua che è ancora la nostra. È quello che permette a me, che di mestiere scrivo di tecnologia e di scienza, di farmi capire. Ed è evidente che, se lo studio della scienza avverrà solo in inglese, nel giro di un paio di generazioni quel gergo sparirà del tutto.
Non voglio fare il catastrofista. Sono convinto che le modifiche della lingua siano ineluttabili, e che dove qualcosa va perso qualcos’altro viene guadagnato. La lingua italiana che oggi tanto amiamo è il risultato di una corruzione del latino da parte di barbari e ignoranti. Se una parola sparisce vuol dire che ha perduto la sua funzione, ed è inutile piangerci sopra. E tuttavia la prospettiva non mi rallegra. Ho sempre pensato che uno dei grossi problemi del nostro Paese risiedesse nel fatto che le persone cosiddette di cultura considerano spesso la scienza come una cosa estranea o superflua. È una frattura che tuttora si fa molta fatica a colmare. E sarà ancora più difficile colmarla se per parlare di scienza occorrerà abbandonare l’italiano.