 Siamo abituati alle stranezze di Fripp e compagni, ma questo disco è giunto del tutto inaspettato. Proprio mentre lo scorbutico chitarrista inglese ribadiva sul proprio blog che al momento non ha alcuna voglia di rimettersi a lavorare con i King Crimson, esce un album con la dicitura “a King Crimson ProjeKct” che, se considerato un disco “ufficiale” della band, rappresenterebbe un radicale cambiamento di direzione musicale: prevalenza di canzoni invece che di strumentali, atmosfere soft e acustiche al posto del metal e dell’elettronica degli ultimi vent’anni.
Siamo abituati alle stranezze di Fripp e compagni, ma questo disco è giunto del tutto inaspettato. Proprio mentre lo scorbutico chitarrista inglese ribadiva sul proprio blog che al momento non ha alcuna voglia di rimettersi a lavorare con i King Crimson, esce un album con la dicitura “a King Crimson ProjeKct” che, se considerato un disco “ufficiale” della band, rappresenterebbe un radicale cambiamento di direzione musicale: prevalenza di canzoni invece che di strumentali, atmosfere soft e acustiche al posto del metal e dell’elettronica degli ultimi vent’anni.
Cos’è successo in realtà? Il disco è nato come album solista di Jakko Jakszyk, musicista inglese non molto noto ma con un impressionante curriculum (ha collaborato, tra gli altri, con Level 42, Jansen Barbieri & Karn, Dave Stewart). Costui ha chiamato ad aiutarlo qualche musicista di area crimsoniana, poi ne sono arrivati altri, e alla fine 4 partecipanti su 5 sono risultati essere membri o ex-membri dei King Crimson: Robert Fripp, Mel Collins (sassofonista della band negli anni ’70), Tony Levin, e Gavin Harrison (batterista dei Porcupine Tree e anche dei King Crimson attuali, sebbene non abbia ancora partecipato ad alcun album). Anzi, possiamo dire 4 e ½ su 5, dato che Jakszyk è il cantante e chitarrista della 21st Century Schizoid band, gruppo dedito alla rievocazione del vecchio repertorio crimsoniano. È stato naturale, perciò, mettere il bollino KC a disco completato.
Il risultato è un disco d’atmosfera, che può ricordare i momenti più sognanti dei dischi di Fripp con David Sylvian. La chitarra di Fripp serve soprattutto a generare soundscape, che vanno a fondersi coi suoni altrettanto eterei di Jakszyk (che suona chitarra, tastiere e una specie di cetra cinese denominata guzheng). Su tutto svetta il sax di Collins, che è la vera colonna portante di questo album: il suo sound è perfetto ed entusiasmante, e i suoi continui assoli donano energia e interesse a una musica che altrimenti rischierebbe di essere monocorde. Tony Levin al basso e Stick dà il suo solito impeccabile contributo, mentre devo dire di non avere apprezzato molto il drumming di Gavin Harrison: è bravissimo, ma il suo stile troppo roccheggiante mi è parso fuori posto. Qui ci sarebbe voluto un rifinitore come Michael Giles (che tra l’altro è il suocero di Jakszyk…).
Quello che non funziona molto in A Scarcity of Miracles, a mio avviso, sono proprio le composizioni di Jakszyk, che sono garbate e fungono da ottimo spunto per le improvvisazioni strumentali dei suoi compagni, ma non riescono a imporsi per il loro valore intrinseco. Avrò ascoltato l’album almeno una dozzina di volte, ma nessuna delle melodie mi è ancora rimasta nella memoria. Se mi consentite una metafora culinaria, l’effetto è quello di un intingolo delizioso versato su una pietanza di per sé insapore. Il piatto è mangiabile, anche buono, ma il peccato originale resta.
In definitiva, gli appassionati prog dovrebbero comprare l’album soprattutto se hanno voglia di ascoltare un Mel Collins al massimo della forma. Ma se quello che cercate è un nuovo disco dei King Crimson, dovrete aspettare ancora.
L’album viene venduto a prezzo normale in una confezione che, oltre al CD-Audio, include un DVD che ripropone il contenuto del CD in una varietà di formati di qualità superiore (DVD-Audio stereo, DVD-Audio surround, LPCM stereo e DTS Surround), oltre a offrire un paio di bonus track. Che pacchia! Unico neo: i menu del DVD sul mio computer non sembrano funzionare (ma si può comunque accedere ai contenuti).
Mese: Luglio 2011
La pesatura dell'anima
In un Egitto alternativo interamente basato sulle biotecnologie, la poliziotta Naïma viene chiamata a far parte della squadra dei Sette, un gruppo eterogeneo che investiga su casi di omicidio. Usa metodi violenti e discutibili, ma c’è una ragione: se riesce a portare il colpevole al cospetto di Iside entro 24 ore, si può scambiare la sua anima con quella della vittima, riportandola in vita…
Clelia Farris è, a mio avviso, tra i migliori autori di fantascienza che abbiamo in Italia. I suoi romanzi hanno tutte le caratteristiche che vorrei trovare in una buona opera del genere. In primo luogo, l’originalità: i tre titoli che ha pubblicato finora non fanno il verso a nessun filone della fantascienza anglosassone, e non si assomigliano nemmeno molto tra di loro: ogni libro è un’esperienza a sé. In secondo luogo, le idee: quella della Farris è una fantascienza che, pur senza addentrarsi in minuzie scientifiche o tecnologiche, non si limita a creare delle atmosfere, ma inventa situazioni realmente nuove e interessanti e le affronta in modo problematico, come accade nei capolavori del genere. Infine, la densità: non si accontenta certamente di una sola idea per romanzo, ma ce ne mette tante e le fa interagire tra loro in modo imprevedibile, dando davvero al lettore la sensazione di trovarsi in un mondo del tutto nuovo.
La pesatura dell’anima non fa eccezione. Già il tema principale, quello di una polizia in grado di far risorgere le vittime, è decisamente potente e pieno di implicazioni. Ma l’idea vincente è quello di ambientare il tutto in un mondo totalmente diverso dal nostro, un Egitto alternativo in un Universo alternativo, in cui l’uso dei metalli è proibito, le case e i mobili sono alberi modificati, mentre animali modificati fungono da mezzi di trasporto e di comunicazione. Un luogo tanto più affascinante in quanto viene dato per scontato: non c’è nessun personaggio che si prenda la briga di spiegarlo al lettore, che deve costruirselo nella sua mente decifrando frasi sibilline e neologismi. C’è persino un personaggio che parla uno slang malavitoso, che viene reso con un linguaggio del tutto campato in aria e pure perfettamente comprensibile, con un autentico virtuosismo letterario.
Dopo tanti elogi, però, devo dire che purtroppo La pesatura dell’anima non riesce a raggiungere i vertici di quello che finora è il capolavoro della Farris, Nessun uomo è mio fratello. Il libro diventa sempre più avvincente fino a circa metà; poi però è come se l’autrice ne perdesse il controllo. Troppi personaggi, con troppi cambi di punti di vista, che impediscono al lettore di immedesimarsi. Ma soprattutto, gradatamente il punto focale del romanzo cambia, passando dall’etica alla politica. Che sarebbe anche molto interessante, se non fosse che il sistema politico di questo Egitto inventato è descritto in modo troppo frammentario, e il lettore rimane spiazzato nel cercare di capire cosa stia realmente succedendo.
Nonostante questo, consiglio comunque la lettura di La pesatura dell’anima, un libro sorprendente che, anche se non perfettamente riuscito, rimane comunque parecchio sopra la media della fantascienza italiana,
Game of Thrones – prima stagione

È terminata da qualche settimana sulla rete televisiva statunitense HBO la prima stagione di Game of Thrones, serie televisiva tratta dalla saga A Song of Ice and Fire di George R. R. Martin. Per la precisione, questi primi episodi sono tratti dal primo libro della serie, A Game of Thrones (uscito in Italia sdoppiato in due titoli, Il trono di spade e Il grande inverno). A settembre gli episodi usciranno doppiati su Sky, ma io ho preferito guardarmeli subito in originale.
Vi dico subito che sono un fan sfegatato della serie libraria. È vero, Martin non ha inventato nulla di particolarmente nuovo, né dal punto di vista narrativo né da quello dell’invenzione fantastica. Però gli è riuscita un’impresa che moltissimi avevano tentato ma praticamente nessuno aveva portato a termine: emulare Tolkien nel creare un universo immaginario talmente coerente e dettagliato da prendere vita. E, per giunta, lo ha fatto non imitando pedissequamente il maestro, ma facendo tutto il contrario: a differenza della Terra di Mezzo, Westeros non è un luogo in cui si affrontano un Bene e un Male rigidamente definiti. Nell’universo di Martin gli dei sono presenze evanescenti, e persino la magia è in buona parte emarginata ai confini del mondo: al centro della scena ci sono gli uomini, con le loro debolezze e contraddizioni, con storie contrapposte in cui la ragione spesso sta da ambedue le parti o da nessuna. E che sono vittima dei capricci del caso, e muoiono in modi che non hanno nulla di eroico né di necessario. Un fantasy moderno, che non è fatto per mettere a tacere i dubbi, ma per suscitarne.
Sinceramente pensavo che rendere A Song of Ice and Fire in modo soddisfacente in un serial televisivo fosse quasi impossibile, ma mi sono dovuto ricredere in modo completo. Questa prima stagione, probabilmente anche grazie alla collaborazione dell’autore (che ha una lunga esperienza di sceneggiatore TV), ha una fedeltà assoluta alla lettera ma soprattutto allo spirito dell’originale.
Uno degli elementi maggiormente riusciti è stato il casting. Praticamente tutti i personaggi sono stati affidati ad attori molto bravi, molto somiglianti e molto ben calati nella parte. Anche gli attori-ragazzini, che sono spesso il punto debole di queste produzioni, funzionano benissimo (particolarmente bravi quelli nelle parti di Arya e Joffrey), ma in particolare due interpreti giganteggiano: Sean Bean, che è un Eddard Stark solenne e schiacciato dal peso delle responsabilità; e Peter Dinklage che incarna Tyrion Lannister. O meglio, il secondo non giganteggia, visto che è un nano, ma è riuscito nella difficilissima impresa di rendere Tyrion in tutte le sue sfumature, al tempo stesso carismatico e vulnerabile (senza ricadere nella sindrome del “nano comico” che aveva piagato, purtroppo, il Gimli de Il signore degli anelli di Peter Jackson).
Più in generale, la complicatissima trama è resa molto bene, tagliando grandi quantità di dialoghi ma senza eliminare elementi importanti, anzi, riuscendo nonostante tutto a trasmettere ogni singolo dettaglio che forma la storia. Insomma, difficile immaginare che la serie potesse essere fatta meglio e il successo che le ha arriso ne è la prova.
Certo, bisognerà vedere cosa succederà nelle prossime stagioni. I dubbi sono molteplici: riuscirà la serie a mantenere un’audience sufficiente per gli almeno sette anni (ma probabilmente di più) necessari per portare la storia alla sua conclusione? Riuscirà George R. R. Martin a scrivere i due volumi che ancora gli mancano per arrivare al termine prima che la serie TV lo raggiunga? Riusciranno i produttori a ottenere i finanziamenti per tutte quelle scene costose (battaglie campali e navali, draghi, giganteschi metalupi e così via) che nei libri successivi diventano indispensabili alla trama? E come affronteranno il fatto che i numerosi interpreti-ragazzini cresceranno molto più rapidamente dei loro personaggi? Staremo a vedere. Certo, se riusciranno a mantenersi coerenti con le premesse, Game of Thrones rimarrà nella storia della televisione.
 Ci sono altre due cose che vi voglio dire su questo argomento. La prima è che da oggi è finalmente disponibile per tutti (e non solo per gli utenti premium) il numero 6 di Players, che contiene anche un articolo del sottoscritto sulla suddetta serie. Non posso linkarvi direttamente l’articolo, ma lo trovate a pagina 44.
Ci sono altre due cose che vi voglio dire su questo argomento. La prima è che da oggi è finalmente disponibile per tutti (e non solo per gli utenti premium) il numero 6 di Players, che contiene anche un articolo del sottoscritto sulla suddetta serie. Non posso linkarvi direttamente l’articolo, ma lo trovate a pagina 44.
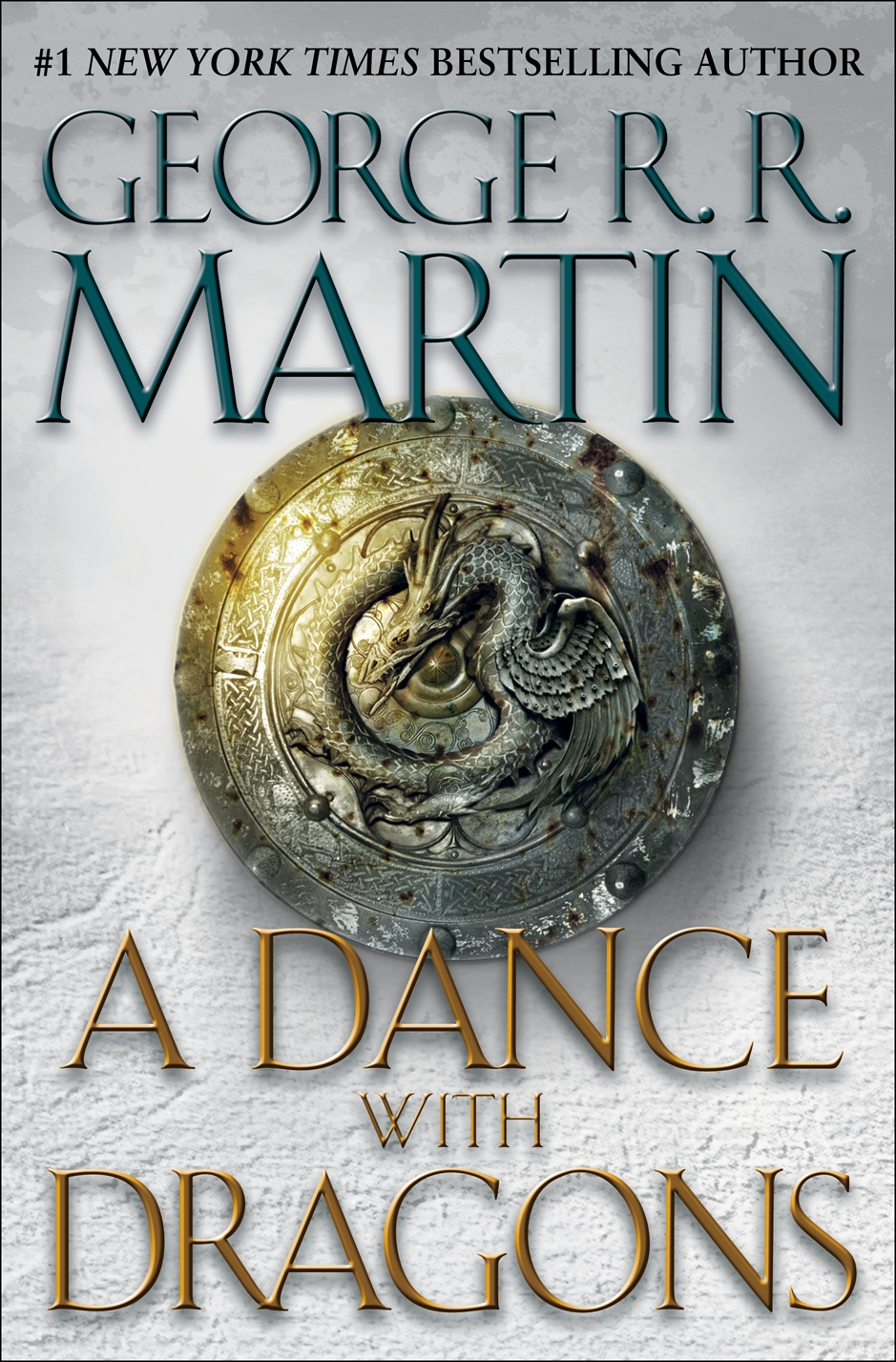
Avviso ai commentatori

Più di una persona mi ha segnalato di non riuscire a commentare su questo blog, perché il tentativo porta a un errore 503 (“Service temporarily unavailable”). I tentativi di rimediare per ora sono falliti, ma perlomeno abbiamo fatto una scoperta: il problema sembra manifestarsi solo quando nel firmare il commento si specifica anche un’URL. Quindi, se incontrate l’errore, evitate di citare il vostro sito, e dovreste riuscire a commentare. Questo almeno finché non avrò risolto il problema.
Ogni aiuto, ovviamente, è benissimo accetto.
Per difendersi dai cigni neri

Dopo l’uscita del libro di Nassim Nicholas Taleb, il cigno nero è diventato simbolo dell’imprevedibilità. Secondo Taleb, i disastri economici (ma non solo quelli) derivano dal fatto che ci fidiamo troppo della nostra capacitàdi prevedere il futuro mediante modelli. Quando il modello all’improvviso si distacca dalla realtà, siamo del tutto indifesi.
C’è un’azienda italiana, Ontonix, che si occupa di valutare la vulnerabilità delle aziende, valutandone la complessità e gli effetti di possibili variazioni impreviste sul suo stato di salute. Per farlo non si serve di modelli, ma di una valutazione di tipo topologico che misura le mutue influenze (anche non evidenti) delle parti del sistema-azienda tra loro. E non solo di un’azienda: una branca di Ontonix, Ontomed, si occupa invece di valutare il rischio di crisi di pazienti in rianimazione!
Ho scritto un articolo in proposito (non lungo quanto avrei voluto) su Nòva 24. Potrete leggerlo facendo clic qui sotto:
We have met the enemy, and he is us
Capitan America: Il Primo Vendicatore
 [Questa recensione appare in contemporanea su Fantasy Magazine. La versione che pubblico qui è alquanto diversa, un po’ per adattarla al format che adotto in questo blog, un po’ perché, dopo aver scritto in fretta e furia la versione per FM (che usciva a mezzanotte della notte scorsa!), mi sono venute in mente modifiche e aggiunte, un po’ perché non ho voglia di polemizzare col pubblico indifferenziato di FM.]
[Questa recensione appare in contemporanea su Fantasy Magazine. La versione che pubblico qui è alquanto diversa, un po’ per adattarla al format che adotto in questo blog, un po’ perché, dopo aver scritto in fretta e furia la versione per FM (che usciva a mezzanotte della notte scorsa!), mi sono venute in mente modifiche e aggiunte, un po’ perché non ho voglia di polemizzare col pubblico indifferenziato di FM.]
1941. Steve Rogers è un ragazzo piccolo, mingherlino e asmatico, ignorato dalle donne, vessato dai bulli e impossibilitato a realizzare il suo sogno: arruolarsi per combattere contro i nazisti. Finché il professor Erskine non lo sceglie come cavia per un esperimento destinato a realizzare il Super Soldato…
Non sono mai stato un grande fan di Capitan America. Sarò superficiale, ma è difficile non considerarlo la personificazione dell’arroganza statunitense. un supersoldato, vestito a stelle e strisce, che per giunta combatte per conto dello S.H.I.E.L.D., una specie di versione superpotenziata della C.I.A. Grazie, no.
Perciò sono andato al cinema con aspettative decisamente moderate. E invece Capitan America: Il primo vendicatore, nella sua prima parte, è riuscito a divertirmi e ad appassionarmi non poco, tirando fuori il lato umano del personaggio e persino buttando lì qualche spunto non banale sul significato degli eroi, della guerra e della propaganda. Peccato che poi, arrivati al dunque, il regista Joe Johnston preferisca andare sul sicuro, privilegiando battaglie e sparatorie e dimenticandosi buona parte della carne che aveva messo al fuoco.
La storia del piccolo uomo che improvvisamente trova un superpotere che lo mette in grado di realizzare i suoi sogni e sconfiggere i suoi nemici è l’essenza del genere supereroistico, e qui è stata realizzata in modo tale che è difficile non lasciarsene coinvolgere. È davvero stupefacente come Chris Evans sia stato rimpicciolito digitalmente in modo assolutamente credibile, tanto da far venire il dubbio che a interpretare Steve “prima e dopo la cura” siano due attori diversi. Ma il bello è che dopo la trasformazione Cap non diventa subito l’eroe che conosciamo, ma viene arruolato in un ridicolo spettacolo di propaganda. Mi è sembrato notevole da parte degli autori cominciare l’epopea di Cap con una serie di scene che mettono in ridicolo la sua calzamaglia rossabiancablu e sembrano denunciare la falsità e la retorica che si nasconde dietro ogni guerra. Tutto questo mentre il professor Erskine, tedesco espatriato, insegna a Cap a non odiare il proprio nemico.
Anche tecnicamente il film gioca le sue carte migliori all’inizio, allineando una serie di caratteristi eccezionali: Hugo Weaving come Teschio Rosso, assolutamente perfetto nella sua gelida malvagità; Tommy Lee Jones nella parte del burbero generale; Stanley Tucci come scienziato in lotta contro l’ottusità politico-militare; ma anche il meno conosciuto Dominic Cooper che tratteggia un ottimo Howard Stark (il padre di Tony Stark, alias Iron Man) che ricorda il personaggio storico di Howard Hughes. La ricostruzione storica (o meglio: pseudostorica) è riuscitissima, con apparecchiatura fantascientifiche dall’aspetto retrò che danno davvero la sensazione di qualcosa che i nazisti avrebbero potuto creare se ne avessero avuto la tecnologia a disposizione. Il tutto condito con una sana dose di ironia che rende il tutto sinceramente divertente.
Peccato che tutto questo gran lavoro di costruzione dell’atmosfera e dei personaggi vada poi in buona parte sprecato quando Capitan America trova finalmente la sua ragione d’essere e comincia a combattere sul serio con il Teschio Rosso. Intendiamoci: chi è di bocca buona e si accontenta di vedere un sacco di mazzate ed esplosioni spettacolari non rimarrà deluso: il dipartimento effetti speciali ha fatto il suo lavoro con diligenza. Tuttavia da questo momento in poi la trama diventa spietatamente lineare. Sembra di guardare un film di guerra al triplo della velocità: in teoria dovremmo appassionarci vedendo le diverse personalità dei commilitoni di Cap amalgamarsi fino a formare una squadra unita, e commuoverci di fronte alla morte eroica di qualcuno di loro, ma in realtà i personaggi rimangono sullo schermo talmente poco che di loro non ci importa molto.
Anche l’idea di avere un supereroe dentro la Seconda Guerra Mondiale non viene sfruttata bene, dato che non c’è alcuna relazione con gli eventi storici reali, e nemeno con l’idea generale di una guerra in corso (Cap e compagni entrano ed escono dalla Germania come se ci fosse una porta girevole). E anche l’idea potenzialmente interessante di un Teschio Rosso che si ribella a Hitler per continuare in proprio i suoi disegni viene appena accennata e poi lasciata cadere. Ma soprattutto è deludente il Teschio Rosso stesso che, dopo avere incontrato Cap la prima volta, si limita a perdere una battaglia dopo l’altra fino alla sconfitta definitiva, senza mai inventarsi uno straccio di trovata diabolica che possa non dico creare un colpo di scena, ma almeno impensierire un pochino il nostro eroe. Il finale non ve lo dico, ma ve lo potete immaginare, visto che tutti sanno che il personaggio di Capitan America parteciperà al prossimo film dedicato ai Vendicatori, ambientato ai giorni nostri.
In conclusione, questo Capitan America è un film riuscito solo a metà. Molto più curato della media del genere, con un cast di supporto eccezionale (ma anche Chris Evans fa una figura migliore che come Torcia Umana), a tratti molto divertente, ma che purtroppo non mantiene tutto quanto promette. Colpa anche della regia professionale ma non memorabile di Johnston. Ah, e comincio a essere stufo di questo 3D che aggiunge pochissimo alle scene e ne appiattisce i colori.
Fly from Here
 Un nuovo album degli Yes? Ancora?! Ebbene sì: la quarantatreenne band non si è ancora rassegnata alla pensione, e ha persino registrato un nuovo album in studio, il primo in dieci anni. E ovviamente io, da fan irredento quale sono, mi appresto a recensirlo per voi.
Un nuovo album degli Yes? Ancora?! Ebbene sì: la quarantatreenne band non si è ancora rassegnata alla pensione, e ha persino registrato un nuovo album in studio, il primo in dieci anni. E ovviamente io, da fan irredento quale sono, mi appresto a recensirlo per voi.
Prima di tutto credo che sia necessario un riepilogo delle ultime vicende di una band che, nonostante la sua longevità, può essere considerata una delle più litigiose mai esistite. Il 2008 ha visto l’uscita di due membri storici. Il tastierista Rick Wakeman ha lasciato amichevolmente per problemi di salute, cedendo il posto al figlio Oliver. Molto meno amichevolmente se n’è andato il cantante Jon Anderson, che, nonostante soffrisse di problemi respiratori al punto di dover rimanere per molti mesi in sanatorio, è rimasto oltraggiato quando la band lo ha sostituito con il canadese Benoît David, che gli somiglia non solo nella voce ma anche nel fisico: praticamente un suo clone con vent’anni di meno.
Doveva essere una sostituzione provvisoria, ma è diventata definitiva, e gli Yes sono entrati in studio con due nuove leve per registrare il loro primo album in dieci anni, con la produzione di Trevor Horn (anche lui ex-membro degli Yes). Ma poi è successo qualcosa, e durante le registrazioni Oliver Wakeman è stato silurato (anche se rimangono nel disco suoi contributi come autore e strumentista) e sostituito da Geoff Downes, che rientra nel gruppo 30 anni dopo esserne uscito. Seguendo la tradizione Yes, i motivi dell’avvicendamento non sono stati esplicitati. C’è chi dice che il povero Wakeman junior si sia reso colpevole di scarso rendimento, ma io sospetto invece che le ragioni siano essenzialmente economiche: buona parte del materiale di Fly from Here è firmata dal duo Horn/Downes, e costava meno avere l’autore all’interno della squadra piuttosto che fuori (per lo stesso motivo nel 1997 Billy Sherwood fu cooptato come “sesto membro” della band in quanto coautore di gran parte del materiale dell’album Open Your Eyes).
Con tutti questi cambi di formazione in corsa, ci si potrebbe aspettare un guazzabuglio. La verità è invece che il disco è piuttosto bello.
Per cominciare Downes è un signor tastierista, e si sente fin dalle prime note: Riesce a mettere molta personalità in quello che suona senza strafare. Poi David, che dal vivo mi aveva convinto solo a metà, in studio funziona bene, riesce a cantare nello stesso registro di Anderson ma con un po’ di sobrietà in più, il che non guasta. Più in generale, il disco è compositivamente e produttivamente solido, e riesce a farsi ascoltare per intero senza i riempitivi e le cadute di tono che avevano infestato gli ultimi dischi del gruppo. L’assenza di Anderson e la preminenza di Horn e Downes come autori fanno sì che la musica abbia l’atmosfera malinconica e nostalgica dei pezzi dei Buggles, una piacevole novità rispetto al romanticismo estatico e un po’ stucchevole dei brani andersoniani. Horn ha fatto tutto il contrario rispetto alla sua precedente produzione per gli Yes (90125), e ha abbandonato completamente gli effetti elettronici per dare la sensazione di un disco veramente cantato e suonato, con un sound molto simile a quello degli Yes anni ’70. In alcuni momenti, come per esempio l’overture in cui gli strumenti entrano ad uno ad uno, è davvero entusiasmante. Insomma, potrebbe essere il miglior disco degli Yes in un quarto di secolo.
Questo non significa che Fly from Here sia un capolavoro. A mio avviso ha tre grandi difetti. In primo luogo, se è vero che non ci sono brani da buttare via, è anche vero che non ci sono grandi picchi, e che si mantiene su un livello medio-alto ma senza mai toccare l’eccellenza. In secondo luogo, nulla da eccepire sulle atmosfere retrò, ma da un disco degli Yes mi sarei aspettato un po’ di creatività in più con i suoni. Forse non si poteva pretendere che un gruppo di ultrasessantenni facesse un album sperimentale, però qui hanno davvero evitato qualsiasi rischio. Infine, forse l’età ha influito anche su questo, ma è un disco troppo poco rock: quasi tutti i brani sono mid-tempo, la batteria è sempre molto tranquilla, Howe usa spesso l’acustica e ha suoni in generale poco aggressivi, solo nell’ultimo brano si sente un po’ di energia.
Venendo alle singole canzoni:
- We Can Fly è un brano già noto: Horn e Downes ne scrissero la prima parte nel 1981, quando ambedue facevano parte degli Yes, col titolo di We Can Fly from Here. Fu persino eseguita dal vivo (come testimoniato nell’album The Word Is Live) e già allora l’idea era di trasformarla in una lunga suite. Il progetto non andò in porto causa temporaneo scioglimento della band, ma esistevano già i demo delle parti successive (pubblicati di recente in appendice alla riedizione dell’album dei Buggles Adventures in Modern Recording). Come se niente fosse, gli Yes hanno ripreso in mano il progetto 30 anni dopo e l’hanno portato a termine, sotto forma di una suite di oltre 25 minuti di lunghezza. La musica è bella, emozionante e malinconica, e l’esecuzione magistrale (oltre alla già citata introduzione, ho ammirato le rifiniture davvero splendide di Howe alla slide guitar nella seconda parte, “Sad Night at the Airfield”). Ha però il difetto di suonare più come una sequenza di canzoni affini che come una suite coesa. In particolare lo strumentale “Bumpy Ride” (firmato da Howe a differenza del resto) ha un contrasto troppo netto con ciò che lo precede.
- The Man You Always Wanted Me to Be è un brano “rubato” alla produzione solistica di Chris Squire e ha le caratteristiche abituali dei brani firmati dal bassista: una melodia molto curata, belle armonie vocali, ma la tendenza a durare troppo a lungo senza svilupparsi ulteriormente.
- Life on a Film Set è un altro brano firmato dal duo Downes/Horn, e a mio avviso il migliore dell’album. Bella melodia, bell’arrangiamento, atmosfere malinconiche alla Buggles ma nel contempo la ricchezza di idee dei migliori Yes.
- Hour of Need è un brano firmato da Steve Howe, ed è un po’ una delusione: finisce dopo tre minuti dando la sensazione di essere la grandiosa introduzione a qualcosa che non è arrivato. Lascia perplessi il fatto che nell’edizione giapponese dell’album ci sia una versione del brano che dura il doppio…
- Solitaire è il ritorno a un’amatissima tradizione: il brano acustico solista di Steve Howe. Anche in questo caso però sono leggermente deluso: il pezzo è piacevole, molto classicheggiante, ma non spicca nella produzione del chitarrista.
- Into the Storm è firmata da tutta la band (incluso Wakeman junior), ed è un bel brano roccheggiante in cui fa da protagonista un altro grande redivivo, e cioè il basso con wah-wah di Chris Squire. Se questo è un’esempio di quello che avrebbe potuto essere il suono degli Yes con Wakeman Junior, direi che non è affatto male.
In conclusione, se gli Yes vi piacciono potete acquistare il disco a scatola chiusa: è una delle cose migliori che abbiano prodotto da tanto tempo, e ricrea molti degli elementi per cui gli Yes degli anni ’70 andavano giustamente famosi. Non è però un disco fondamentale. Se non conoscete la band e volete ascoltare una formazione molto simile a questa, consiglio piuttosto l’acquisto di Drama (1980).
I racconti dell'Ernesto
 Ecco un’altra delle cose che non ho avuto tempo di dirvi durante la pausa del vecchio blog. Un po’ di tempo da l’amico Stefano Massaron si è autopubblicato una breve antologia personale in formato PDF, liberamente scaricabile. Contiene cinque racconti che spaziano dall’horror al semplice flash di vita di periferia. Non lasciatevi ingannare dalla copertina bucolica (opera della sua ragazza, Paola Fumagalli): sono tutti racconti piuttosto estremi.
Ecco un’altra delle cose che non ho avuto tempo di dirvi durante la pausa del vecchio blog. Un po’ di tempo da l’amico Stefano Massaron si è autopubblicato una breve antologia personale in formato PDF, liberamente scaricabile. Contiene cinque racconti che spaziano dall’horror al semplice flash di vita di periferia. Non lasciatevi ingannare dalla copertina bucolica (opera della sua ragazza, Paola Fumagalli): sono tutti racconti piuttosto estremi.
Sono affezionato a questa raccolta anche per una ragione molto personale: come potete leggere nell’introduzione, l’idea di assemblarla e pubblicarla è venuta a Stefano mentre era ospite a casa mia per una cena. Mi ha fatto piacere l’avere involontariamente favorito la nascita di un libro.
Potete scaricare il file da questo link. Fatelo, così, quando uscirà nelle sale il film tratto dal suo romanzo Ruggine, potrete dire di aver letto dei suoi racconti che quasi nessuno conosce…
Delos nights
Poco più di un mese fa ho partecipato a una notturna di Radio Popolare che seguiva di poco la convention di fantascienza Italcon nell’ambito dei Delos Days. Qui sotto trovate l’audio della trasmissione. Oltre al sottoscritto e a Renato Scuffietti partecipavano Emanuele Manco, Luca Tarenzi e, telefonicamente, Alberto Cola.
Mi scuso per aver messo il tutto online così tardi. Purtroppo ho avuto qualche problema tecnico. Devo rinunciare a usare SoundCloud: il lettore online è bellissimo, ma lo spazio dell’account gratuito è troppo limitato, e quello a pagamento costa troppo. Quindi tutto è diviso in spezzoni di una decina di minuti in formato MP3.
Buon ascolto!
Notturna Delos Days 1
Notturna Delos Days 2
Notturna Delos Days 3
Notturna Delos Days 4
Notturna Delos Days 5
Notturna Delos Days 6
Notturna Delos Days 7
Notturna Delos Days 8
Notturna Delos Days 9








