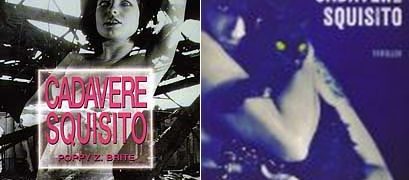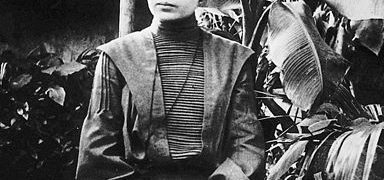Un paio di mesi fa, sul suo blog, Loredana Lipperini dedicava un post indignato all’uscita di un libro Mondadori: un’opera di Jane Nickerson ispirata alla fiaba di Barbablù che ruba il titolo (solo nella versione italiana) alla celebre raccolta di racconti di Angela Carter, La camera di sangue.
L’ira di Lipperini è del tutto giustificata, e me ne sono reso conto tempo dopo, quando mi è venuta l’idea di regalare il libro di Carter a una persona. Ho scoperto che oggi è impossibile in Italia acquistare il vero La camera di sangue, se non sulle bancarelle o su eBay a caro prezzo. Si tratta di un libro importante, che ha ispirato saggi, da un cui racconto è stato tratto un film, un riconosciuto capolavoro che ha influenzato molti autori, ma non viene ristampato da tempo. Ho provato a chiedere in una libreria Feltrinelli (l’editore del libro originale!) e il commesso, del tutto ignaro dell’esistenza di Carter, mi ha proposto il libro di Nickerson. Non bastava che l’originale fosse morto e sepolto, ora tentano pure di farne sparire il ricordo usurpandone il nome.
Questa questione mi è tornata in mente oggi in libreria quando ho visto spuntare da uno scaffale un libro intitolato Cadavere squisito. Era da molto che speravo fosse ristampato in Italia il libro di Poppy Z. Brite, un agghiacciante capolavoro noir che è tuttora il più bel romanzo che abbia mai letto sul tema del serial killer. Un altro libro da tempo introvabile in libreria, edito in origine da Frassinelli. Ho afferrato subito la copia, ma poi ho visto che non c’entrava nulla col romanzo che pensavo: era invece un thriller italiano di Luigi Carletti.Tra l’altro con una copertina che ha pure qualche somiglianza con il libro di Brite.
Ora, manca ancora un indizio per fare una prova, ma due esempi di questo genere a così breve distanza fanno pensare che ci sia del dolo, e che qualcuno in Mondadori abbia pensato che fosse una buona idea appropriarsi di titoli di romanzi di altre case, letterariamente importanti ma assenti dalle librerie, applicandoli su mediocri novità. Non so se si tratti semplicemente della sciatteria di chi non vuole arrischiarsi a inventare un titolo nuovo, o se ci sia dietro il cinismo di chi spera di approfittarsi dei lettori in cerca dei titoli originali, fuorviandoli e inducendoli a comprare un libro che nulla ha a che fare. Ma, se la tendenza dovesse continuare, non ho parole per dire quanto sia culturalmente deleteria.
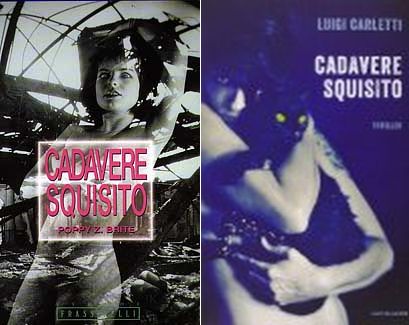
Autore: Marco Passarello
Civati ed io

Credo che il politico Pippo Civati si possa descrivere raccontando della prima volta in cui l’ho visto di persona. Era il 6 marzo 2010, Berlusconi aveva appena presentato un decreto che sanava una serie di irregolarità, consentendo di presentarsi alle elezioni regionali anche a liste che palesemente non ne avevano titolo. Dilagò la consueta indignazione, ma a Milano furono indette due manifestazioni distinte, una dal PD e l’altra dal Popolo Viola.
La manifestazione del Popolo Viola cominciava prima, di fronte al Palazzo di Giustizia, quindi raggiunsi lì alcuni amici, con l’intenzione però di spostarmi dopo alla manifestazione del PD, in largo Cairoli. Solo che poi arrivò Civati. Che parlò con gli organizzatori e disse: “Ha senso che facciamo due manifestazioni separate contro la stessa cosa? Perché non raggiungiamo tutti l’altra manifestazione?”
Non so come, ma convinse tutti: ci mettemmo in marcia, e raggiungemmo la manifestazione del PD. In testa al corteo, come si vede nella foto, sentii Civati ridacchiare come un bambino che ha commesso una marachella, e bisbigliare a Carlo Monguzzi: “Sai la faccia di Penati quando gli portiamo le bandiere del Popolo Viola sotto il palco!”
Ecco, questo è Pippo Civati: una persona di buon senso, che guarda alle idee e non alle appartenenze politiche, e riesce a ottenere risultati inaspettati, anche e soprattutto a dispetto dei dirigenti del suo stesso partito.
Da allora ho seguito Pippo da vicino, e non mi ha mai deluso. Ogni volta che ho avuto la tentazione di pensare che in Italia non esistono politici decenti, c’è stato lui a dimostrarmi il contrario, sostenendo coerentemente le posizioni che avrei voluto che il PD sostenesse, su qualunque argomento (i referendum sull’acqua, gli F-35, i matrimoni omosessuali, la politica economica, quello che preferite). Io penso che, se Civati fosse stato segretario in questi ultimi anni, il boom del M5S non ci sarebbe stato, e quei voti li avrebbe legittimamente presi il PD.
Ma quello che mi piace di più di Pippo è la sua coerenza. Che ha fatto sì che in questi tre anni non lo abbia mai sentito affermare qualcosa per poi fare marcia indietro, a differenza di tanti altri suoi colleghi. Non va avanti a sparate che poi è costretto a rettificare, non va a cercare i titoli dei giornali a ogni costo, non lancia frasi ad effetto per avere l’apertura del TG (anche se è capace di grandissima ironia, come quando si è costruito da solo l’intervista che Fazio non gli ha voluto fare). Ha fatto una campagna elettorale senza l’appoggio di alcun giornale (vergognoso come Repubblica lo ignora) e senza grandi finanziatori alle spalle, eppure ha convinto molta gente, e tutti hanno detto che ha vinto il confronto TV su Sky.
Vi ricordate di tutte le volte che avete detto che avreste voluto dei politici seri, coerenti, capaci, moderni, che portassero avanti delle idee invece di difendere solo la poltrona? Adesso avete la possibilità di votarne uno, e non dovete lasciarvela sfuggire. Il vostro voto conta, ed è tanto più importante in quanto Civati non ha giornali che lo danno da mesi come il sicuro vincitore. Le cose si possono cambiare, a patto di crederci: è questo il senso dello slogan “le cose cambiano, cambiandole”. Io proverò a cambiarle domani, votando per Pippo.

Detto questo, siccome immagino che questo post susciterà prevedibili obiezioni, mi sono preparato anche qualche risposta preventiva:
Ancora il PD? Basta, non lo voterò mai più.
Sono piuttosto solidale con questa posizione, dato che anche per me votare PD in questo momento sarebbe molto difficile, se non impossibile. Il PD ha tradito i suoi elettori, facendo esattamente il contrario di ciò che aveva promesso in campagna elettorale. Per questo motivo, dopo cinque anni nel partito quest’anno non ho rinnovato la tessera. E tuttavia, non credo che felicitarsi della rovina del PD sia la soluzione. A noi elettori delusi servirebbe un PD che funzionasse e portasse avanti le idee per cui lo abbiamo inutilmente votato in passato. Quindi mi sembra sensato votare l’unico candidato che vuole fare sul serio quello che il PD non ha mai fatto. Secondo me vale la pena di scommetterci due euro. Poi non si è obbligati a votare il PD, se Civati non dovesse essere eletto, o se fosse eletto ma non risultasse convincente.
Non voto per Civati, parla tanto ma poi vota come gli altri.
Questa è l’obiezione che mi sento rivolgere più spesso, e sinceramente mi rattrista, perché la trovo totalmente ingenerosa e fuori dalla realtà. Civati non ha votato la fiducia al governo Letta, un atto di ribellione che poteva costargli l’espulsione. Da allora si è battuto ogni volta in assemblea per portare allo scoperto le contraddizioni del PD, a differenza di suoi colleghi che rilasciano dichiarazioni ai giornali ma in assemblea si guardano bene dal sostenere le stesse posizioni. Prendersela con lui perché alla fine vota con i suoi significa non capire quello che sta facendo, e cioè mostrare agli elettori che esiste un’alternativa e che il PD può essere diverso. Se votasse ogni volta in dissenso, sarebbe messo fuori dal PD, e l’alternativa non ci sarebbe più.
Non ci si rende conto che è molto più difficile cercare di convincere i propri compagni di partito rispetto a rompere i ponti. Lo so per esperienza: dopo le scorse elezioni ho partecipato a una riunione di un circolo PD, mi sono alzato e ho detto che il PD appoggiando la TAV aveva sbagliato tutto. Ho proseguito il mio discorso tra grida, fischi e mormorii, consapevole che in sala c’era probabilmente solo una mezza dozzina di persone che la pensava come me. Non credo di aver convinto nessuno. Ma credo di essere stato più utile allora che ero dentro, piuttosto che ora, che per esasperazione e stanchezza sono fuori. Rispetto Civati perché ha la forza di rimanere dentro e lottare, in un partito in cui per ora è come un corpo estraneo.
Che senso ha votare Civati? Tanto vince Renzi!
Per cominciare, questo è un discorso che si morde la coda. Ovvio che Civati non può vincere se la gente non lo vota, quindi per farlo vincere bisogna in primo luogo votarlo. Ma poi, anche se non dovesse arrivare primo, più voti prenderà, più sarà difficile al futuro segretario del PD ignorare le sue posizioni. Non ci si può lamentare che le cose non cambiano, se poi non si colgono le opportunità per cambiarle.
Io voto Renzi! Solo Renzi può cambiare l’Italia!
Mah, cosa vuoi che ti dica, non sono d’accordo. Per cominciare, Civati ha idee molto più chiare e nette su quasi tutto, mentre Renzi spara grandi frasi, ma poi nel concreto non si capisce cosa vuole fare (esempio principe: dice di essere contrario alle larghe intese, però dice anche che vuol lasciare proseguire Letta fino al 2015; come stanno insieme queste due cose?).
Gli argomenti che usano i renziani, poi, non mi convincono per nulla. “Renzi è un vincente, Renzi ha carisma”, mi dicono, e a me cadono le braccia. A sentirli sembrerebbe che per un politico la dote principale sia essere telegenico, piacere per la propria immagine invece che per quello che dice. Secondo me chi la pensa così è avvelenato dal berlusconismo. Ed è tipico, ahimè, di una sinistra succube cercare di riprodurre le ricette della destra quando sono ormai scadute. Come Renzi che dice di ispirarsi a Blair, che nel mondo ormai è schifato da chiunque. E comunque vorrei far notare che il vincente Renzi nelle scorse primarie ha perso, e contro Bersani.
Mi dicono: “Renzi è l’unico che può prendere il voto degli elettori di destra”, e a me cadono le braccia due volte. Sono più di vent’anni che si segue questa teoria per cui in Italia la sinistra è minoritaria e non può vincere, e perciò è necessario compiacere i cosiddetti “moderati”. Risultato: la sinistra ha continuato a perdere voti, si è dissanguata inseguendo alleati che non contavano nulla (Casini, Fini, Monti, adesso Alfano), mentre il M5S dal nulla si prendeva il 25% dei voti. Ora vorreste farmi credere che con Renzi sarà diverso? Non vedo perché. La sinistra non vincerà mai inseguendo i voti della destra. Vincerà quando saprà convincere i suoi, che ora in gran parte si astengono, a votarla.
Inseguire gli elettori era l’idea di partito di Veltroni, quello del “ma anche”, che voleva essere il partito di tutti e non era il partito di nessuno. Si è visto come è andata. Un partito che vuole cambiare le cose non deve inseguire gli elettori. Deve prendere una posizione, e convincere gli elettori che è giusta. È più difficile, ma è l’unico metodo che funziona davvero.

L'uomo a un grado Kelvin
2060. Dopo essersi assentato misteriosamente, il professor De Ruiters, direttore di un importante centro di ricerca europeo, viene ritrovato congelato a bassissima temperatura all’interno di un macchinario, durante un esperimento pubblico di teletrasporto al Palazzo delle Stelline di Milano. Contemporaneamente, altri tre suoi colleghi si rendono irreperibili. Il detective Dick Watson della Polizia Europea viene inviato a indagare sul caso, scontrandosi subito con la Polizia Lombarda che preferirebbe non averlo tra i piedi. Il caso si rivelerà molto più complicato del previsto, coinvolgendo spie, criminali, hacker, e i segretissimi computer quantistici nel sottosuolo di Parigi…
Da molti anni ormai collaboro alle selezioni per il premio Urania. Di solito evito di parlarne pubblicamente, sapendo come il premio sia una macchina generatrice di polemiche per cui meno si dice e meglio è. Quest’anno però sono molto più coinvolto del solito: non solo la prima lettura dell’opera vincitrice è stata assegnata a me, ma mi sono occupato anche dell’editing e ho realizzato l’intervista all’autore inclusa in appendice. Non riesco perciò a trattenermi dall’esprimere un giudizio, ovviamente del tutto parziale, visto che questo romanzo lo sento anche un po’ “mio”.
E allora vi dico che questo libro, senza nulla togliere ai suoi predecessori, mi è piaciuto in modo particolare. Per tanti motivi. Per esempio:
- È un ottimo giallo: ha una trama intricatissima e solida, che procede in modo consequenziale senza affidarsi a coincidenze e colpi di fortuna. Niente a che vedere con certi libri in cui la trama investigativa è solo un pretesto per parlar d’altro.
- Tuttavia gli appassionati di fantascienza non devono storcere il naso: non si tratta di un giallo tradizionale cucinato in salsa futuribile. Tutt’altro: l’ambientazione fantascientifica è originale, coerente e saldamente ancorata alla trama investigativa.
- Ma il motivo per cui L’uomo a un grado Kelvin mi ha colpito particolarmente è un altro: la competenza scientifica con cui è scritto. Oserei dire che questo è il singolo libro di fantascienza italiana in cui il lato scientifico è trattato meglio, senza alcuna pedanteria ma con mano sicura e senza rifarsi a modelli anglosassoni.
Insomma, senza voler esagerare con gli elogi, è il tipo di romanzo di fantascienza italiana che mi piacerebbe leggere molto più spesso: avvincente, professionale, interessante senza rinunciare a essere divertente. Fatemi sapere se siete d’accordo con me.
Dodici
Un’epidemia ha trasformato in zombie quasi tutti gli abitanti di Rebibbia. Mentre i pochi superstiti si organizzano per tentare la fuga, Calcare è stato misteriosamente ridotto in fin di vita. Tocca ai suoi amici, Secco e Cinghiale, e a Katja, una ragazza rimasta bloccata con loro nel quartiere, trovare il modo di portarlo via prima che sia troppo tardi.
Non sono potuto andare alla presentazione milanese di Dodici, ma probabilmente è stata una fortuna: pare che fossero necessarie ore di coda per poterne ottenere una copia. Nel giro di un paio d’anni Zerocalcare (pseudonimo di Michele Rech) è passato da figura di culto a fumettista più ricercato di Italia, con spazi fissi su Internazionale e Wired e i suoi libri che si vendono come il pane. Tanto di cappello: per una volta il successo tocca a qualcuno che se lo merita.
Se già in Un polpo alla gola Zerocalcare si era allontanato in parte dallo stile delle storie che pubblica sul proprio blog, proponendo una trama articolata che prevale sulle pur numerose gag, qui fa un passo ulteriore mettendo in disparte il proprio alter ego e lasciando la scena ai comprimari Secco e Cinghiale e alla nuova arrivata Katja. Questi diventano protagonisti di una trama fantastica che sembra quasi un crossover con Safe Inside, il fumetto incompiuto di zombie che aveva realizzato per la DC Comics.
Mi riesce un po’ difficile dare un giudizio netto sul risultato. Da un lato, è evidente che l’autore non si è seduto sugli allori ed è in continua evoluzione: dal punto di vista grafico questa è una delle sue storie migliori. Riesce ad avere il ritmo di un fumetto d’azione senza perdere per strada il consueto umorismo, ed è particolarmente azzeccato il modo in cui le varie linee narrative sono rese con stili differenti e riconoscibili.
Sulla storia, però, sono più dubbioso: pur essendoci gag esilaranti e trovate geniali, e pur avendo apprezzato molto il personaggio di Katja (spero che in futuro riappaia!), trovo che in qualche punto il respiro sia un po’ affannoso, e che gli spunti proposti non siano sempre approfonditi come meriterebbero. Soprattutto, mi pare che la struttura narrativa completamente frammentata sia un virtuosismo un po’ fine a se stesso, che finisce per rendere la trama difficoltosa da seguire invece che moltiplicare la tensione.
Tirando le somme, non è probabilmente la miglior storia di Zerocalcare, come mi aspettavo che fosse. Ma restano comunque soldi ottimamente spesi.
In memoria: Luigi Bernardi
 Non posso dire di avere conosciuto bene Luigi Bernardi. Ci siamo sempre visti di sfuggita. Ma quel poco mi è stato sufficiente per capire che persona stimabile fosse.
Non posso dire di avere conosciuto bene Luigi Bernardi. Ci siamo sempre visti di sfuggita. Ma quel poco mi è stato sufficiente per capire che persona stimabile fosse.
L’ho incontrato per la prima volta negli anno ’90, sulla mailing list letteraria di Fabula. Si comportava come un utente come tanti, addirittura scrisse un raccontino per la nostra piccola antologia di testi brevissimi (di cui parlo nella pagina dedicata ai miei racconti). Allora non sapevo che era già un editore all’avanguardia, che con la sua Granata Press aveva portato per primo i manga in Italia, e stava facendo esordire scrittori come Giuseppe Ferrandino, Stefano Massaron, Nicoletta Vallorani, Paolo Aresi…
Devo dire la verità: un po’ mi intimidiva. Credo fosse per quel suo umorismo caustico, che ti sapeva demolire con una parola (peraltro con me è sempre stato molto gentile). Il tipo di umorismo che solo le persone che la sanno lunga possono permettersi. E lui la sapeva lunga: aveva fiuto. Sapeva riconoscere a prima vista le potenzialità di uno scritto, di un autore. Quasi una maledizione, visto che arrivava sempre prima, e poi altri coglievano i frutti.
Qualche anno fa gli proposi alcune idee per un romanzo breve da pubblicare nella collana che dirigeva, Perdisa Pop. Nonostante fossi meno di un conoscente, si prese la briga di valutare attentamente le mie proposte e mi disse di portarne avanti una. Ovviamente la più difficile, quella che mi lasciava più incerto, ma anche quella che mi avrebbe probabilmente portato a dare il meglio. Ci lottai per più di un anno senza portarla a termine, poi lui annunciò che avrebbe lasciato la direzione della collana per dedicarsi solo a scrivere.
Allora mi sembrò quasi una defezione: c’era bisogno di uno come lui nell’editoria. Uno per cui mestiere e passione formavano un’unità inscindibile. Immagino che in realtà già sapesse di avere poco tempo: ci ha lasciato l’altro ieri, a soli 60 anni. Mancherà a tantissimi.
Lise Meitner

Oggi è l’Ada Lovelace Day. Si tratta di una ricorrenza simpatica, anche se non gestita benissimo (la data ha fluttuato di anno in anno). La sua funzione è quella di sensibilizzare il pubblico riguardo al ruolo delle donne nella scienza. La si festeggia scrivendo sul proprio blog un post per ricordare una figura di scienziata donna. Prende il nome da Ada Lovelace, figlia di Lord Byron, matematica e considerata da molti la prima programmatrice della storia.
Ho sempre voluto partecipare a questa iniziativa, ma ogni anno o me ne sono dimenticato, o avevo tanta roba da fare che non sono riuscito a trovare il tempo di scrivere un post. Quest’anno però mi sono preparato in anticipo, e vi parlerò di una scienziata austriaca di nome Lise Meitner.
Il motivo per cui l’ho scelta deriva dai miei ricordi d’infanzia. Quand’ero ragazzino la mia passione per lo spazio, non essendoci Internet, si nutriva soprattutto di libri. C’era per esempio Verso lo spazio, un testo fatto benissimo che ripercorreva la storia dei viaggi spaziali attraverso i francobolli. C’era l’Atlante dell’Universo della DeAgostini. E altri che non ricordo. Passavo ore a sfogliarli, a guardare le illustrazioni e a immaginare storie ambientate sui pianeti.
In uno di questi libri (non ricordo quale) c’era una mappa della Luna con indicati i principali crateri e il motivo per cui si chiamavano così. In mezzo a una serie di luoghi chiamati con nomi di divinità greche e romane, ce n’era uno chiamato Lise Meitner, accanto al quale uno spiritoso redattore aveva scritto “fisica austriaca, priva di attributi divini”. Questo ricordo mi è tornato fuori dagli abissi della memoria in occasione dello scorso Ada Lovelace Day, e sono andato a indagare su chi fosse stata veramente questa donna.
Ho così scoperto che fu veramente un personaggio notevole, davvero perfetto per questa ricorrenza. Non starò a raccontarvi nei dettagli la sua biografia (se siete interessati, andate su Wikipedia). Vi dirò solo che:
- Nacque a Vienna nel 1878, e nel 1906 fu la seconda donna a laurearsi in fisica presso l’università di Vienna, studiando con Ludwig Boltzmann.
- L’anno successivo si trasferì a Berlino per proseguire gli studi. Lavorò con Max Planck, fu in contatto con Albert Einstein e Marie Curie, stabilì un sodalizio di ricerca col chimico Otto Hahn. Ma per molti anni la sua attività scientifica rimase non ufficiale, a causa di leggi, regolamenti e tradizioni che non permettevano alle donne di lavorare nei laboratori scientifici.
- Dalle sue ricerche derivò la scoperta del protoattinio.
- Nel 1926 divenne professoressa di fisica nucleare sperimentale.
- Essendo ebrea, nel 1933 le fu revocato il permesso di insegnamento, e nel 1938 fu costretta a fuggire in Svezia, Paese di cui divenne cittadina.
- Nel 1939 pubblicò un articolo in cui per la prima volta veniva descritto il meccanismo della fissione nucleare, che Otto Hahn aveva realizzato l’anno prima ma senza comprenderne la dinamica.
- Pacifista convinta, si rifiutò di partecipare alle ricerche per la costruzione della bomba atomica.
- Nel 1945 Otto Hahn vinse il premio Nobel per la chimica per la scoperta della fissione nucleare. Il lavoro di Meitner, che era stato interrotto dalla fuga in Svezia, venne ignorato, ma i più ritengono che il premio sarebbe dovuto toccare anche a lei.
- Morì nel 1968. Sulla sua lapide c’è scritto: “Lise Meitner, fisica che non perse mai la propria umanità”.
Il prefetto
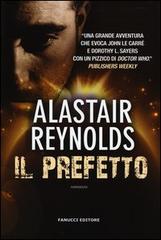
Quando uno dei più piccoli habitat viene distrutto con tutti i suoi 960 abitanti, e la colpa sembra ricadere sugli Ultra, la comunità di cyborg che si occupa dei viaggi interstellari, il prefetto supremo Aumonier decide di affidare l’indagine, politicamente delicatissima, al suo protetto Dreyfus. I due sono legati dall’aver subito entrambi delle ferite durante la lotta contro l’intelligenza artificiale assassina nota come l’Orologiaio. Dreyfus ha perso la moglie, mentre Aumonier si ritrova tuttora con un artefatto piantato nel collo, che da 11 anni le impedisce di dormire e minaccia di ucciderla se chiunque si avvicinerà a meno di sette metri da lei.
Ma nessuno dei due sa che dai risultati dell’indagine dipenderà la sopravvivenza dell’intera Fascia Splendente…
Lo dico subito: erano anni che un romanzo di fantascienza non mi conquistava quanto Il prefetto. Mi ha avvinto fin dalle prime pagine e mi ha tenuto fino alla fine senza un momento di noia e insoddisfazione.
Ritengo che nel romanzo di genere moderno il problema più importante che un autore deve affrontare sia la somministrazione dell’informazione: come e quando si passano dati al lettore. Da questo punto di vista, Il prefetto è semplicemente da manuale: gestisce alla perfezione la trama apparente che vivono i protagonisti, la trama nascosta che devono scoprire, e la trama del passato che sembra messa lì solo per fare background, e invece diventa sempre più importante col procedere della storia. Il tutto senza mai dare informazioni fuori contesto, senza che le azioni dei personaggi perdano una logica, e soprattutto senza mai far calare la tensione, procedendo con un grosso colpo di scena a capitolo per 700 pagine, senza mai far calare il ritmo, con un mix perfettamente equilibrato tra azione, mistero, politica e introspezione. Da applauso.
Non si tratta di un romanzo costruito intorno a concetti scientifici, come potrebbe essere uno di Greg Egan o di Ted Chiang: la struttura della trama è quella di una tradizionale investigazione, la cui posta in gioco è un’umanissima lotta per il potere. Nondimeno, si tratta di un’opera profondamente fantascientifica, nel cui contesto vengono trattati (senza fare lezioncine e senza pretesa di volerli esaurire o risolvere) temi interessanti come lo status di umanità delle intelligenze artificiali, i sistemi elettorali per una democrazia diretta in rete e molti altri, e vengono descritte varie tecnologie insolite e bizzarre. Il background di Reynolds, astrofisico prima di diventare scrittore, si vede nel modo in cui lascia correre la fantasia senza mai cadere nell’implausibile.
(Per vostra informazione: il romanzo è il quinto di una serie, detta Revelation Space dal nome dell’opera iniziale, anche se cronologicamente dovrebbe porsi prima di tutti gli altri. Non ho incontrato però alcuna difficoltà a seguirlo, e credo che ogni opera del ciclo sia leggibile a sé.)
Se dovessi fare un paragone, direi che questo romanzo mi ha dato le stesse sensazioni del capolavoro di Dan Simmons, Hyperion: ci ho trovato la stessa vertigine di complessità che gradatamente si ricompone in un’immagine coerente, e la stessa solidità nel rappresentare una società futura completamente diversa dalla nostra eppure profondamente umana. Nel confronto Simmons vince probabilmente ai punti per avere osato ispirarsi alla struttura dei Racconti di Canterbury, mentre il meno ardito Reynolds prende spunto, semmai, da Il silenzio degli innocenti.
Ciò non toglie che Il prefetto sia di gran lunga tra i migliori è più avvincenti romanzi letti negli ultimi anni. A questo punto non vedo l’ora di leggere qualcos’altro di Alastair Reynolds. Mi giunge voce che molto probabilmente Urania pubblicherà il prossimo anno un altro suo romanzo. Sarebbe bello che arrivassero in Italia prima o poi tutti gli altri dodici che ha scritto…
Elysium
La Terra è ormai un pianeta in decadenza, la cui popolazione è sfruttata e vessata: povertà, polizia opprimente, lavori insicuri, sanità insufficiente. Solo i superricchi se la passano bene, nella stazione orbitante di Elysium, dove vivono in grandi ville e hanno a disposizione macchine che guariscono qualunque malattia.
Max, scontata una condanna per furto d’auto, non cerca più di arricchirsi per pagarsi il viaggio verso Elysium, e vorrebbe solo condurre una vita tranquilla. Ma quando un incidente sul lavoro gli lascia solo pochi giorni da vivere, per lui raggiungere la stazione diventa letteralmente una questione di vita o di morte.
Esordire con un film originale e significativo come District 9 è probabilmente il sogno di ogni regista. Ma comporta anche il problema che, qualunque film farai dopo, ci si aspetterà che sia all’altezza del tuo folgorante debutto. Se Elysium fosse stato realizzato da un esordiente, senza attori famosi e con qualche soldo in meno, saremmo qui a parlare di un promettente talento. Invece è firmato Neill Blomkamp, e dall’autore di District 9 ci aspettiamo non che faccia promesse, ma che le mantenga. Cosa che non gli è riuscita del tutto.
L’idea alla base del film non è delle più originali: il tema dei ricchi che si costruiscono un rifugio paradisiaco mentre il resto del mondo precipita verso la barbarie è stato declinato dalla letteratura e del cinema in svariate versioni: (la prima che mi viene in mente: il film Zardoz di John Boorman; ma sappiate che anche la trama del romanzo Più che umani di Paolo Lo Giudice, finalista più di una volta al Premio Urania ma purtroppo mai arrivato alla pubblicazione, ha diversi punti di contatto con quella di Elysium). Ma si può fare un buon film anche partendo da dei clichè. E nella prima parte di Elysium Blomkamp fa un ottimo lavoro nel descrivere una società in cui sovrappopolazione, scarsità di risorse, inquinamento, capitalismo sfrenato e uno stato di polizia dagli onnipresenti controlli informatici collaborano per rendere difficile la vita delle persone.
Il mondo dei ricchi è rappresentato in modo meno dettagliato, ed è una delle pecche del film. Va detto però che il design della stazione spaziale è veramente spettacolare: rivisita il modello a ruota di 2001: Odissea nello Spazio, ma in modo più ardito (è senza soffitto, dato che l’atmosfera è tenuta al suo posto dalla gravità artificiale¹), e desta nello spettatore (perlomeno quello sensibile al fascino dei viaggi spaziali) una meraviglia che è raro incontrare nei film di oggi.
Fino a metà il film è di qualità superiore: un ritmo invidiabile, un’atmosfera fantascientifica ben costruita, e anche un divertente cattivo un po’ fuori dagli schemi (interpretato dal protagonista di District 9, Sharlto Copley), e culmina con una lunga scena di combattimento davvero ben diretta ed efficace.
Nella seconda parte, però, il film si ammoscia completamente. In gran parte a causa di una sceneggiatura pasticciata, che tratta le questioni informatiche con un semplicismo e un’approssimazione non giustificabili nell’era di Internet. Per esempio, perché salvare un file nel cervello di una persona e non su una comune memoria? (D’accordo, lo facevano in Johnny Mnemonic, ma era per mantenere la segretezza, qui sembra una cosa scontata.) Perché ci si sorprende che un file segreto sia criptato? Perché da un certo punto in poi il file risulta leggibile, nonostante nessuno lo abbia decrittato? A che serve una protezione che uccide chi trasporta il file, ma lo lascia leggibile? Ma soprattutto: possibile che basti hackerare un computer per consegnare permanentemente il potere a qualcuno?
Tra tanta confusione, il film si sbarazza in fretta e furia del personaggio di Jodie Foster senza dargli una possibilità di svilupparsi, abbandona i temi politici, e si trasforma in un action movie risolto con il più banale inseguimento con scazzottata finale. Va aggiunto che la vicenda è racchiusa in una cornice ambientata quando il protagonista era ancora un bambino, che vorrebbe dare profondità al personaggio e fornire un appiglio per giustificare la sua redenzione finale, ma risulta sdolcinata e superflua.
In definitiva, il film resta vedibile, grazie all’ottima regia di Blomkamp che ne fa comunque un’altra cosa rispetto ai tanti e malriusciti film di fantascienza di medio budget che abbiamo visto in questi anni (Looper, Codice 46, Il mondo dei replicanti… e così via). Ma è comunque ben lontano dall’essere memorabile.
¹A onor del vero ho qualche dubbio che un sistema del genere non lascerebbe sfuggire presto tutta l’aria, ma sorvoliamo.
Monsters University
Come è cominciata l’amicizia tra Mike e Sulley, i due mostri protagonisti di Monsters & Co.? A quanto pare, già all’università, dove Mike si reca entusiasta, pronto a impegnarsi al massimo per realizzare il suo sogno di diventare uno spaventatore di professione. Il suo primo incontro con il futuro amico non è dei più felici, dal momento che il giovane Sulley è un fannullone che pensa di non aver bisogno di studiare, dato che la sua famiglia e il suo aspetto gli apriranno comunque tutte le porte. Dovranno succedere parecchie cose perché l’amicizia tra i due nasca davvero…
Monsters University è stato accolto dai più come un film divertente ma poco interessante, un altro segno della “normalizzazione” di Pixar che, dopo aver prodotto una quantità notevole di capolavori, avrebbe tirato i remi in barca in occasione della fusione con Disney, sacrificando la creatività a favore degli incassi. Maldisposto dalla visione del pasticciato e deludente Brave stavo quasi per prendere per buono questo giudizio e non andare neppure a vederlo. Ma avrei fatto male, perché invece si tratta di un film davvero molto riuscito, che nel curriculum della grande casa d’animazione non sfigura affatto.
Intendiamoci, Monsters University non è un Up o un Wall-E, e forse nemmeno un Ratatouille: non è un film che tenta di essere in qualche modo innovativo. Però non sta scritto da nessuna parte che un film per essere bello debba per forza essere innovativo. E Monsters University è un bel film proprio perché riesce a essere efficace pur muovendosi in un territorio collaudato.
La grafica è splendida. Pixar ci ha abituato così bene che non ci meravigliamo più, ma questo film mi pare aver segnato un ulteriore progresso, con enormi ambienti occupati da masse di personaggi in movimento tutti diversi tra loro, perfettamente illuminati. Anche gli esseri umani sono animati in modo perfettamente credibile (abissale la distanza coi bambolotti del primo Toy Story). Ma soprattutto, è eccezionale la cura e la fantasia con cui è stato animato ogni mostro: ce ne sono decine, e anche i personaggi assolutamente minori hanno una personalità e un aspetto caratteristico che si ricorda. E Sulley manifesta talmente tante espressioni ed emozioni nel film che bisognerebbe dargli l’Oscar.
Più che nel film originale, in questo caso la regia è riuscita a inserire nel film qualche tocco horror, più che opportuno, visto che in fondo è di mostri che si parla. Non solo il personaggio dell’Orrendo Rettore Tritamarmo è genuinamente inquietante, ma anche le scene ambientate nel mondo degli umani fanno paura. In particolare, uno dei momenti più alti del film è la scena in cui Mike si trova intrappolato in una stanza piena di bambini che non hanno paura di lui, con un rovesciamento di ruoli da capogiro tra mostro e vittime. (Ultimamente Pixar, da Brave a Toy Story 3, sta dimostrando un’abilità nelle scene horror che sarebbe bellissimo vedere applicata a un intero film, ma temo sia chiedere troppo.)
Quello che mi ha però conquistato è la sceneggiatura, che oserei definire perfetta. Il film non ha mai un attimo di stanca, e riesce non solo a essere divertente dal principio alla fine, ma anche ad avvincere con una storia non banale e che nel finale riserva parecchi colpi di scena. Paradossalmente Monsters University è una commedia studentesca molto migliore di quelle che vorrebbe parodiare, e ha il considerevole pregio di offrire anche una morale molto più realistica di quella offerta in modo martellante da tutto il cinema hollywoodiano. Non è vero che basta impegnarsi a sufficienza per ottenere qualunque risultato: nel film Mike diventa adulto proprio quando viene a patti con la realtà, riconosce di essere un mostro più buffo che spaventoso, e riesce a vivere con questa consapevolezza.
Pixar aveva già dimostrato con i tre Toy Story di essere in grado di sfornare seguiti dello stesso livello dell’originale, ma qui si va anche oltre. In definitiva Monsters & Co. è uno dei suoi film che ho amato meno, ho sempre pensato che non sfruttasse tutto il potenziale del tema. Cosa che invece fa Monsters university, che si rivela perciò migliore del suo modello.
Pacific Rim

Nel prossimo futuro, una breccia si apre sul fondo dell’Oceano e cominciano a uscirne enormi mostri alieni asssetati di distruzione. Per contrastarli vengono costruiti gli Jaeger, colossali robot da combattimento. I mostri però diventano sempre più forti e, mentre gli esseri umani fuggono dalle coste, gli ultimi robot si riuniscono a Hong Kong per tentare una disperata resistenza…
Per questo film esistono due possibili recensioni:
Recensione per chi vuole vedere un film di robottoni che si picchiano coi mostri spaziali:
Chiunque sia stato ragazzino negli anni ’80 stava aspettando da oltre trent’anni che arrivasse un film spettacolare e ben fatto coi robot giganti giapponesi accanto ad attori veri. Ebbene, l’attesa è finita. Guillermo Del Toro vi ha preparato un film interamente dedicato ai robottoni.
E quando dico interamente, parlo sul serio: in questo film non vi dovete sorbire insipide storie d’amore, melensi conflitti familiari, o tutta quella roba che nei film tratti dai supereroi Marvel passa per “approfondimento del personaggio” (ma in realtà è fuffa per riempire gli spazi tra un combattimento e l’altro). Qui ci sono solo combattimenti e preparazione ai combattimenti. E stop.
E i combattimenti, inutile dirlo, sono fatti benissimo. Se siete disposti a credere che il modo migliore di affrontare un mostro colossale non sia quello di bombardarlo, bensì di costruire un robot alto centinaia di metri che lo prenda a cazzotti o usi una petroliera come clava per picchiarlo, troverete le azioni estremamente realistiche, comprensibili e coinvolgenti, e i robot degni di tutta la tradizione dei mecha giapponesi.
Menzione speciale per le musiche di Ramin Djawadi, che riescono a rendere alla perfezione l’atmosfera da “colonna sonora di videogioco” senza mai risultare noiose o fastidiose.
Certo, il film qualche difetto ce l’ha. I personaggi sono quasi tutti integralmente stereotipati e, se non ci fossero i due scienziati pazzi e il contrabbandiere di “frattaglie di mostro” magistralmente interpretato da Ron Perlman a portare un po’ di divertimento, il film risulterebbe davvero greve. Inoltre, dal punto di vista della strategia militare, una puntata media di Gundam risulta più convincente di Pacific Rim, dove alcune delle cose che vengono dette non hanno senso, o sembrano supercazzole buttate lì solo per far succedere le cose. (Esempio: a un certo punto i mostri emettono qualcosa che sembra un impulso elettromagnetico, che spegne tutti gli Jaeger. Ma se possono fare una cosa del genere, perché non la rifanno poco dopo, quando sarebbe molto più utile? Ma soprattutto: uno dei robot non va fuori uso, e la spiegazione è che, mentre tutti gli altri robot sono “digitali”, questo è un vecchio modello e perciò è “analogico”. Mi spiegate perché mai un robot gigante costruito tra quarant’anni dovrebbe essere “analogico”, quaunque cosa significhi?)
Ma son piccole cose: se un film riesce a far applaudire la platea a scena aperta quando un robottone tira fuori la spada (è successo quando l’ho visto io), vuol dire che è sostanzialmente riuscito.
Recensione per chi vuol vedere un film di Guillermo del Toro, il regista di Il labirinto del fauno:
Qui cominciano le dolenti note. Se andate a vedere Pacific Rim perché siete fan di un regista che ha sempre mostrato di saper coniugare divertimento e profondità nel proprio cinema, cascate male. Perché questo film è bello da vedere, ma è decerebrato quanto quello di un qualsiasi mestierante hollywoodiano.
E sì che gli spunti non sarebbero mancati. A cominciare da questi mostri vomitati dal profondo della Terra che già nei film di Honda volevano esprimere la paura della contaminazione nucleare (e che qui invece non esprimono un bel niente).
Il problema purtroppo sono i personaggi, talmente monodimensionali che è impossible fargli dire qualcosa. Anche le migliori occasioni vanno sprecate: l’idea per cui i robot sono troppo grandi e complessi per un solo cervello umano, per cui vanno guidati da due uomini in reciproca simbiosi mentale, aveva il potenziale per generare infinite situazioni morbose, conflittuali o stranianti, ma non viene minimamente sfruttata.
In generale, la trama non presenta situazioni interessanti perché mancano avversari interessanti. Non c’è nessun vero conflitto tra gli esseri umani, e l’unico “cattivo” è un pilota che fa il bulletto senza una vera ragione. Mentre i mostri spaziali sono totalmente privi di personalità, e anche quando abbiamo l’occasione di guardare nel loro mondo e nei loro cervelli non scopriamo nulla di inquietante. Non fatemi dire che cosa avrebbe fatto Cronenberg di uno spunto del genere.
I temi politici sono poi del tutto assenti. A parte una frecciata nemmeno tanto convinta contro i politici inetti in generale, è difficile dare una qualsiasi interpretazione politica al tutto. Unica eccezione, la scena in cui la folla, avendo capito che il mostro sta cercando una persona in particolare, le fa il vuoto intorno: efficacissima, ma slegata da qualsiasi discorso.
Insomma, mi spiace deludervi, ma Del Toro ha fatto un film totalmente privo di contenuti. Certo, rispetto a Michael Bay il suo è un cinema molto più raffinato, pieno di riferimenti e citazioni, ed esteticamente molto più bello. Ma la piattezza intellettuale è quasi la stessa e, peccato mortale, non c’è nel suo film assolutamente nulla di spaventoso. È solo un giocattolo.
Concludo con alcune note:
- Se vi state chiedendo che tipo di spettatore sia io, faccio parte della seconda categoria: nonostante infinite visioni di Goldrake, Il grande Mazinga, Jeeg robot d’acciaio , Danguard, Gaiking, Daitarn 3, Gundam e simili, speravo comunque in un film del Del Toro che conoscevo.
- Non lasciate la sala prima di arrivare a metà dei titoli di coda! C’è una scena che merita.
- Non ho visto il film in 3D: ho preferito vederlo sotto casa, anche se temo di essermi perso qualcosa.