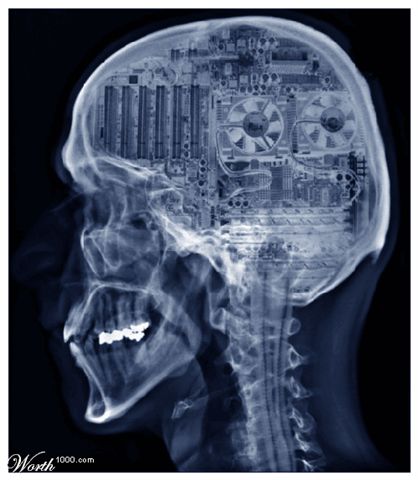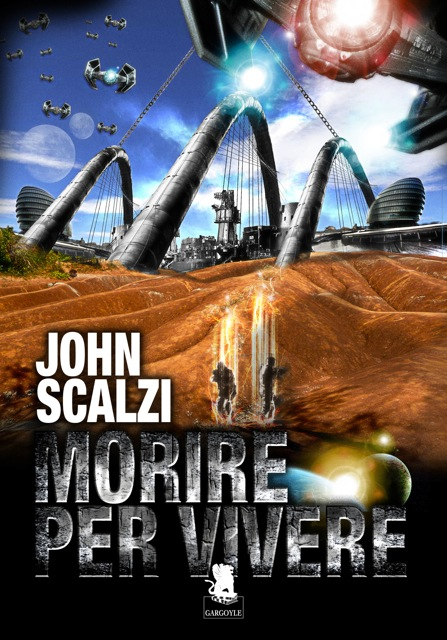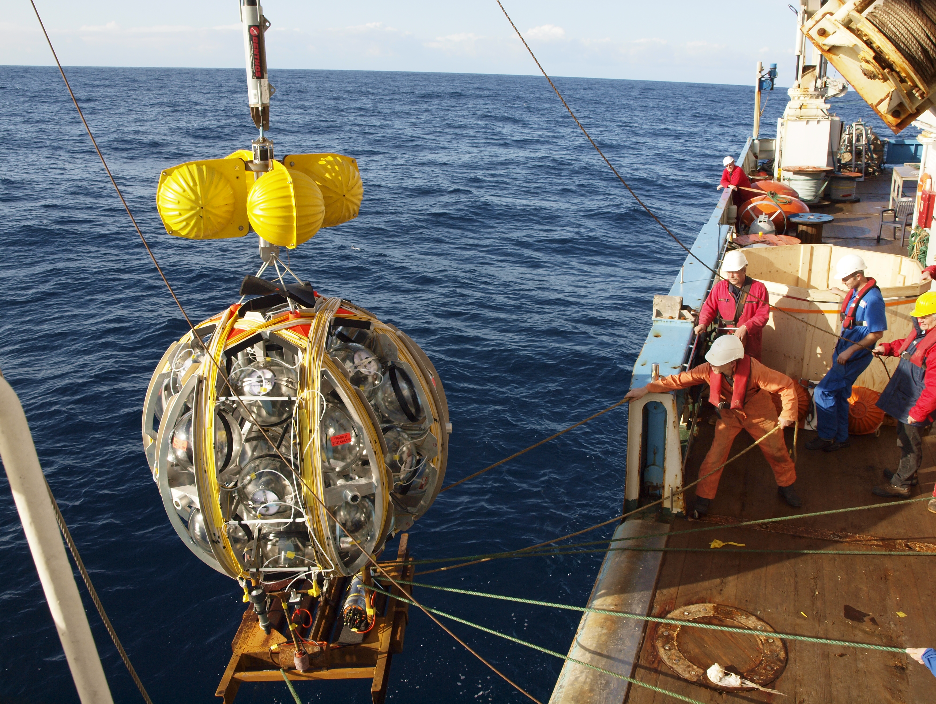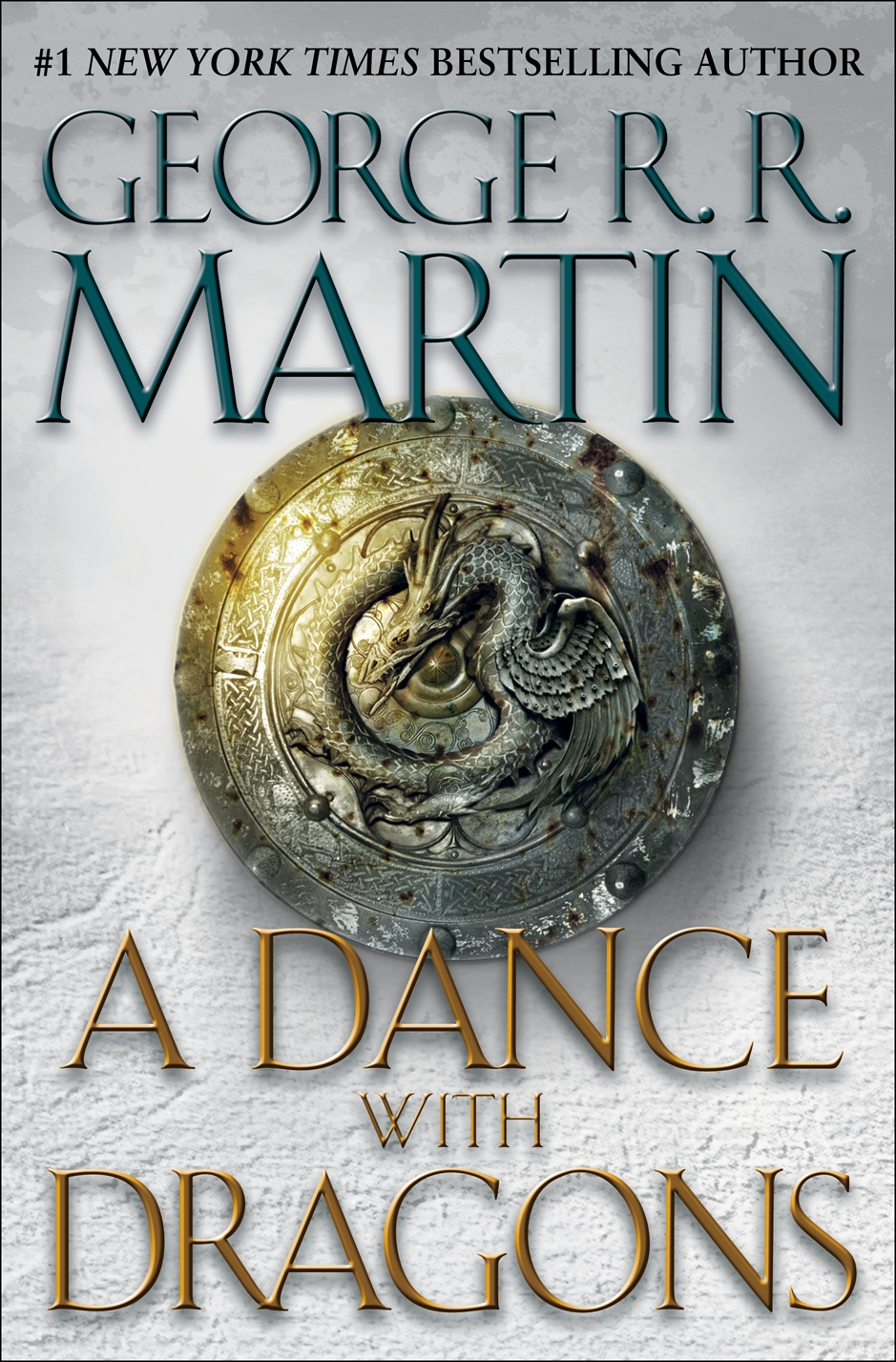Tra un quarto di secolo, gli Stati Uniti sono precipitati in una profonda decadenza. Non solo hanno completamente perso lo status di superpotenza e sono ridotti a vassalli di Stati più ricchi, non solo sono devastati da secessioni, criminalità, terrorismo e rivolte interne, ma la quasi totalità della popolazione è ormai dipendente dal flashback, una droga che consente di rivivere a piacere i propri ricordi preferiti. Proprio a causa del flashback, che usa di continuo per far rivivere il ricordo della moglie Dara, uccisa in un incidente stradale, Nick Bottom è stato cacciato dalla polizia e ha abbandonato il figlio adolescente. Quando però un ricco magnate giapponese, il cui figlio è stato assassinato sei anni prima, gli offre una forte somma per riaprire l’indagine rimasta senza colpevoli, Nick accetta di malavoglia l’incarico.
Soltanto un paio di mesi fa avevo scritto che, finché Dan Simmons avesse continuato a scrivere libri eccezionali come Drood, delle sue opinioni politiche mi sarebbe importato poco. Purtroppo però quelle opinioni hanno finito col tracimare anche nei suoi libri, e il risultato è qualcosa che definire impresentabile è ancora poco.
Ma andiamo con ordine: in primo luogo dimenticatevi le fantasmagoriche invenzioni di romanzi come Hyperion: Flashback è un thriller ambientato in un futuro molto vicino al nostro presente. La fattura è professionale, e la trama è avvincente a sufficienza da volerlo leggere fino in fondo, ma come romanzo di indagine non spicca particolarmente, anche a causa dei personaggi piuttosto stereotipati. Il protagonista è un ex-poliziotto che usa la droga per rivivere il ricordo della moglie morta, e al suo fianco c’è un giapponese tutto di un pezzo che ha giurato di fare seppuku in caso di fallimento della missione: non è roba particolarmente originale, e a volte si ha l’impressione di leggere una specie di cocktail tra Strange Days e Black Rain (del resto i riferimenti cinematografici hanno una parte importante nel romanzo). Certo, in quasi 600 pagine si trova qualche buona idea (ho apprezzato particolarmente le magliette animate da intelligenze artificiali, come pure il riferimento shakespeariano che Simmons riesce a innestare sul suo protagonista), ma certamente non al livello cui l’autore ci ha abituato.
La parte “interessante” del romanzo non dovrebbe però essere l’indagine, ma lo sfondo, l’ambientazione in una versione decaduta degli Stati Uniti. Ed è qui che nascono i problemi. Perché Simmons ci ha riversato una visione politica talmente rozza, estremista e reazionaria da far apparire tutti i candidati repubblicani alle ultime primarie come dei timidi moderati.
Il Male in Flashback è rappresentato dall’Islam, che non solo ha unificato tutto il Medio Oriente, il Nordafrica e parte dell’Asia in un unico Califfato, con triplice capitale a Teheran, Riad e Damasco (evidentemente le eterne rivalità tra sunniti e sciiti sono state miracolosamente accantonate), ma si è anche mangiato buona parte dell’Europa, avvolgendola in una cappa oscurantista. E già qui si potrebbe dire perlomeno che Simmons non è stato molto originale: tanto per fare un esempio, molti dei racconti dell’antologia italiana Sul Filo del Rasoio si svolgono in scenari simili, e sarebbe legittimo aspettarsi da uno dei massimi autori statunitensi qualcosa di più innovativo dello spauracchio che da anni viene agitato dall’ultradestra USA. Ma al di là di questo, va detto che l’Islam viene descritto da Simmons con toni che sfiorano (e forse raggiungono) il razzismo, e che sarebbero più adatti alla terra di Mordor che non a una delle principali religioni del pianeta. L’Islam di Simmons sembra perseguire l’odio e il Male al di là di qualunque logica politica. Nel romanzo il Califfato è la principale superpotenza mondiale e gli Stati Uniti ne sono diventati succubi al punto da permettere che si costruisca una moschea su Ground Zero e vi si festeggi ogni giorno l’anniversario dell’11 settembre, ma gli islamici non sono comunque soddisfatti e lanciano attentati suicidi sugli USA con cadenza praticamente giornaliera. E, nonostante Israele sia stato abbandonato dagli USA, cosa che dovrebbe averlo reso inerme o quasi di fronte alla superpotenza islamica, il Califfato ha preferito distruggerlo con 11 bombe atomiche, rendendolo inabitabile e facendo piovere radiazioni anche sui palestinesi (se questa visione non vi sembra abbastanza faziosa, aggiungo che gli israeliani, con lo spirito pacifista che li ha sempre contraddistinti, nel romanzo hanno rinunciato spontaneamente alla rappresaglia nucleare che avevano il potere di scatenare). Nessun personaggio del libro prende mai le difese dell’Islam, e persino le nazioni dell’Estremo Oriente che non hanno mai avuto attriti con la religione di Maometto pensano che si tratti di una minaccia gravissima. Per usare le parole di uno dei personaggi, l’Islam è
una barbarica religione del deserto intenzionata a dominare la Terra e a trattare le religioni conquistate come schiavi meno che umani.
Non mi metto neppure a elencare i motivi per cui affermazioni simili siano del tutto prive di basi storiche o politiche e andrebbero semplicemente rifiutate da qualunque persona sensata (d’accordo, lo dice un personaggio, non lo dice Simmons, però nulla lascia pensare che l’autore possa non condividere la sostanza di questo pensiero).
Fosse solo questo, si tratterebbe soltanto di un caso di isterismo islamofobo abbastanza comune negli USA post-11-settembre. Purtroppo c’è anche dell’altro. Simmons, sempre per bocca dei suoi personaggi e senza esporre alcun punto di vista contrario, nel corso del romanzo ci spiega perché gli USA sono caduti in decadenza e sono impotenti di fronte all’avanzata dell’Islam. E la colpa è degli intellettuali terzomondisti, che si sono stupidamente interrogati sulle colpe dell’America aprendo le porte ai nuovi Hitler; dei pacifisti, che hanno perseguito un’assurda politica di disarmo mentre il nemico si armava; degli ecologisti, che hanno reso l’America dipendente da tecnologie costose e destinate al fallimento (sì, perché nel mondo degradato descritto da Simmons ci sono migliaia di pale eoliche inutilizzate per mancanza di manutenzione, mentre le centrali nucleari, chissà perché, funzionano benissimo; il riscaldamento globale, invece, è solo una ciarlataneria priva di fondamento scientifico); dei programmi a favore delle minoranze, che hanno dato il potere a incapaci e corrotti invece che a chi lo meritava veramente; e infine di Barack Obama, che con i suoi costosi progetti di equità sociale ha portato il Paese alla bancarotta.
Contro Obama Simmons ha il dente particolarmente avvelenato: per lui le timidissime riforme dell’attuale presidente, credeteci o no, stanno trasformando gli USA in un Paese socialista. E si va ancora oltre: Simmons non spiega in modo molto chiaro cosa sia avvenuto (forse un po’ di pudore ce l’ha anche lui), ma nel mondo che descrive i Repubblicani non esistono più, e il loro pensiero si può ascoltare solo su radio clandestine. Ebbene sì: nel paese del maccartismo, per Dan Simmons è sufficiente che un presidente voglia dare l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini per evocare il partito unico e la dittatura del proletariato.
Devo aggiungere altro? Mi sembra che il quadro sia chiaro. Flashback è un fanta-thriller scritto con una buona tecnica (e per questo nella mia rubrica su XL si prenderà una risicata sufficienza), ma è anche un libro becero, razzista e, sì, anche profondamente ignorante. Come un letterato del livello di Simmons possa esprimersi politicamente in questo modo, per me resterà un mistero, ed è forse un sintomo di quell’incombente decadenza degli USA che con questo libro l’autore intenderebbe contrastare.
La cosa più triste è proprio che, come metafora, il libro funziona comunque nel rappresentare il popolo statunitense come perso in un artificiale sogno di glorie passate mentre il suo Paese va in pezzi. Simmons crede di aver descritto i propri compatrioti, ma in realtà ha descritto se stesso: un uomo che pensa che negando tutti i problemi, cercando un nemico esterno e mandandogli contro i ranger del Texas a cavallo tutto si risolverà. Esca dal sogno, mister Simmons.