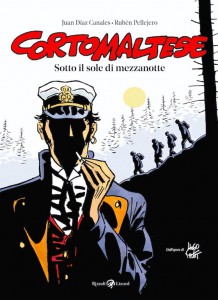 Un paio di mesi fa è stata pubblicata la prima storia di Corto Maltese non firmata da Hugo Pratt, intitolata Sotto il sole di mezzanotte. È firmata da due autori spagnoli: lo sceneggiatore Juan Díaz Canales (noto per Blacksad, un bel fumetto noir interpretato da animali antropomorfi) e Rubén Pellejero (autore di Dieter Lumpen, fumetto che già costituiva un esplicito omaggio a Pratt).
Un paio di mesi fa è stata pubblicata la prima storia di Corto Maltese non firmata da Hugo Pratt, intitolata Sotto il sole di mezzanotte. È firmata da due autori spagnoli: lo sceneggiatore Juan Díaz Canales (noto per Blacksad, un bel fumetto noir interpretato da animali antropomorfi) e Rubén Pellejero (autore di Dieter Lumpen, fumetto che già costituiva un esplicito omaggio a Pratt).
Ha senso un’operazione del genere, a vent’anni di distanza dalla morte dell’autore originale? Sicuramente non c’è nulla di sacrilego: lo stesso Pratt aveva dichiarato in tempi non sospetti di non essere contrario al fatto che altri riprendessero il suo personaggio, una volta che lui lo avesse abbandonato. Tuttavia non si trattava di un’operazione facile. Corto Maltese non è uno di quei personaggi seriali che vivono in un universo proprio sostanzialmente avulso dal mondo reale: la sua biografia è complessa e intrecciata a vari eventi storici, e non è banale ampliarla con nuove storie. Ma soprattutto, si tratta di un personaggio molto personale, vero e proprio alter ego di un autore che per più di vent’anni ne ha curato le storie. Difficile, quindi, darlo in mano a qualcun altro mantenendone intatto lo spirito.

A mio avviso c’erano due modi possibili per affrontare una rinascita di Corto Maltese. Adottare un approccio di rottura, reinventando il personaggio sia nel disegno, sia nel ritmo delle sceneggiature, marcando in modo inequivocabile la diversità rispetto alle vecchie storie. O invece cercare di essere filologici, imitando il più possibile lo stile di Pratt. Il primo metodo sarebbe stato molto più rischioso, ma anche quello potenzialmente più fertile. Il secondo, che non sorprendentemente è quello scelto dagli autori (e dagli editori), va sul sicuro nel proporre ai lettori qualcosa che già ben conoscono, ma corre il rischio di essere una mera celebrazione che poco aggiunge al personaggio.
Dal punto di vista del disegno, Sotto il sole di mezzanotte ricalca davvero da vicino lo stile di Pratt. Ammetto di non essere un esperto di sottigliezze grafiche, ma credo che se mi avessero raccontato che si trattava di un inedito di Pratt ci avrei senz’altro creduto: le differenze rispetto all’originale non mi sembrano maggiori rispetto a quelle che si riscontrano tra una storia e l’altra dello stesso Pratt. Pellejero è riuscito a rendere bene non solo l’aspetto dei personaggi, ma anche lo stile delle inquadrature e soprattutto la scansione delle vignette, con quelle sequenze di azione silenziose che costituiscono una parte importante delle atmosfere delle storie di Corto.
Il modello della sceneggiatura sembra essere Corte Sconta detta Arcana: una storia lunga che, dopo un inizio magico-onirico, si mantiene sostanzialmente ancorata alla realtà e va a includere numerosi luoghi, personaggi ed eventi storici, in un intrico di vicende in cui quella di Corto è solo una delle tante, e forse nemmeno la più importante. Non sembra invece esserci nullla in comune con l’ultimo periodo di Pratt, quello di storie bizzarre e sognanti come Mu o Le elvetiche.
Lo spunto di partenza è preso invece da La giovinezza, ed è probabilmente la scelta più ovvia: è una storia che Pratt ha ambientato molto indietro nel tempo, nel 1905, ed è seguita da uno spazio “vuoto” della biografia di Corto in cui è possibile ambientare nuove storie, mentre tutto il resto delle sue avventure, ambientate tra il 1913 e il 1924, costituisce un corpo piuttosto compatto in cui sarebbe stato difficile inserire altro.
Indubbiamente nello sceneggiare la storia Díaz Canales ha compiuto un notevole sforzo di documentazione e ideazione, riuscendo a ricreare molto bene il fascino che emanano le storie di Corto: luoghi e personaggi che sembrano inventati e invece sono storicamente esistiti, insieme ad altri del tutto immaginari ma perfettamente credibili. Ed ha anche allestito una vicenda parecchio intricata che mantiene una sua coerenza, giustificando le peregrinazioni di Corto senza sbavature.
Quello che purtroppo non mi ha convinto del tutto è proprio l’elemento centrale, e cioè la rappresentazione di Corto Maltese in persona. Quello che vediamo è un corto notevolmente più giovane rispetto a quello che abbiamo conosciuto in tutte le storie di Pratt, esclusa La giovinezza. È perciò naturale attendersi che sia un po’ più impulsivo ed irruento. Al contrario, il Corto dei due autori spagnoli mi è parso leggermente troppo distaccato. A parte un paio di scene in cui è costretto ad agire dalle circostanze, sembra fare da testimone alle varie vicende senza esserne veramente coinvolto. E mi sembra difficile, per fare un esempio, che il Corto Maltese amico dei rivoluzionari irlandesi di Concerto in O’minore per arpa e nitroglicerina avrebbe accettato con tanto fatalismo la fucilazione di un amico irlandese per mano dell’esercito canadese, come vediamo qui.
Insomma, tutti i dettagli al posto giusto, ma manca qualcosa. Questa storia mi ha dato sensazioni simili a quelle provate leggendo i fumetti di Don Rosa, il fumettista statunitense che ha ricostruito una dettagliata biografia di Paperon de Paperoni basandosi sulle storie originali di Carl Barks, scrivendo poi nuove storie perfettamente integrate con gli originali. Tanta ammirazione per la cura filologica, gran piacere nel poter immaginare nuovi dettagli della storia di personaggi amati, ma anche la sensazione che, costretti in binari così rigidi, finiscano per non avere gran che di nuovo da dire, perdendo parte di quella vitalità e follia che costituiva la loro essenza.
In conclusione: ho letto la storia con piacere, e leggerò anche la prossima, se ci sarà. Ma, come forse era scontato, il vero Corto rimane inafferrabile.

Categoria: Recensioni
L'ultima colonia
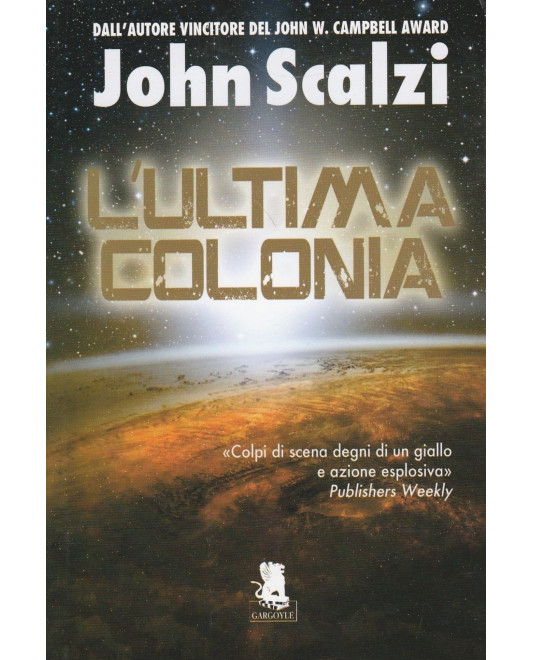
Dopo gli eventi visti in Morire per Vivere e Le Brigate Fantasma, John e Jane si sono sposati, hanno avuto nuovi corpi più adatti alla vita civile, e vivono una pacifica vita da agricoltori insieme alla figlia Zoe. Ma l’Esercito ha ancora qualcosa in serbo per loro, e li convince a guidare una spedizione per colonizzare il pianeta Roanoke. Presto si renderanno conto che le cose non stanno esattamente come gli è stato detto, e che i civili loro affidati vengono usati come pedine in una partita diplomatica dove potrebbero tranquillamente essere sacrificati…
Questo è il terzo volume della serie Old Man’s War, per ora l’ultimo pubblicato in Italia, mentre negli USA sono già usciti anche Zoe’s Tale, che racconta gli stessi eventi di questo romanzo ma dal punto di vista di Zoe, e il successivo The Human Division, e sta per uscire The End of All Things.
Recensendo i due volumi precedenti avevo espresso le mie forti riserve verso l’impostazione politica dei romanzi di Scalzi, totalmente orientata verso un acritico militarismo. Tuttavia, nel corso di un’intervista che mi aveva rilasciato per Players, lo stesso autore mi aveva ammonito a non scambiare le posizioni dei personaggi per le sue, e a prendere in considerazione l’intera serie prima di giudicare. Devo riconoscere che in questo terzo episodio l’Esercito perde la sua immagine di istituzione totalmente positiva e viene descritto come fallibile, accentratore e manipolatore. Una brusca correzione di rotta (che peraltro non inficia le mie critiche agli episodi precedenti). Questa apertura progressista non è però bastata a farmi piacere il romanzo, che a mio avviso fa fare alla serie un passo indietro.
Attenzione: parlo seguendo i miei gusti personali. Dal punto di vista tecnico, L’Ultima Colonia è scritto piuttosto bene, con una trama piena di ritmo e di colpi di scena, personaggi ben caratterizzati, e continue variazioni di atmosfera che permettono di arrivare fino in fondo senza annoiarsi. E l’intreccio politico-diplomatico-militare è ben studiato.
Tuttavia io non riesco proprio ad appassionarmi alla visione retrò della fantascienza di Scalzi. Perlomeno nei due volumi precedenti c’era una tecnologia militare interessante, originale e moderna. Ma quando si esce dall’ambito strettamente guerresco l’autore perde tutta la sua inventiva. La società che descrive non solo non è futuribile, ma nemmeno contemporanea, e sembra essere stata concepita negli anni Cinquanta. Si direbbe che l’unico motivo per cui i personaggi colonizzano pianeti è trovare nuovi territori dove piantare patate e allevare maiali, e che il principale obiettivo strategico sia quello di moltiplicare la consistenza della propria popolazione. Concezioni decisamente fuori dal tempo.
Il punto più debole di tutta l’opera è però quello che sarebbe dovuto essere il suo centro, e cioè il pianeta Roanoke. Data la sua importanza nell’economia del romanzo mi sarei aspettato un buon livello di dettaglio e di originalità. Invece, tutto quello Scalzi ci dice di Roanoke si può riassumere in due righe: ci sono roditori simili a topi con quattro occhi, predatori simili a lupi con quattro occhi, abitanti primitivi ma intelligenti che somigliano a lupi mannari, e bellissimi tramonti, ma l’atmosfera puzza di ascelle. Stop. Un fondale di cartapesta sarebbe stato più interessante.
Mi sono reso conto che una fascia importante, e forse addirittura maggioritaria del pubblico della fantascienza ama molto i romanzi avventurosi, senza eccessive complicazioni scientifiche e ispirati a opere del passato. Per costoro L’Ultima Colonia contiene tutto quello che serve, confezionato in modo professionalmente valido. A me però è sembrato affrettato e privo di vero interesse.
Distopie
 Come dicevo qualche tempo fa, ultimamente ho preso l’abitudine di leggere anche testi di narrativa autopubblicati, che in precedenza ignoravo. Questo dopo aver constatato che la crisi spinge a ricorrere all’autopubblicazione anche autori validissimi che però non trovano spazio in un mercato librario nazionale sempre più asfittico e, di conseguenza, pavido e miope.
Come dicevo qualche tempo fa, ultimamente ho preso l’abitudine di leggere anche testi di narrativa autopubblicati, che in precedenza ignoravo. Questo dopo aver constatato che la crisi spinge a ricorrere all’autopubblicazione anche autori validissimi che però non trovano spazio in un mercato librario nazionale sempre più asfittico e, di conseguenza, pavido e miope.
Tra questi autori c’è anche Stefano Massaron, scrittore pubblicato da Einaudi e dal cui ultimo libro è stato tratto anche un film, ma che ha scelto, a titolo di esperimento, di pubblicare in proprio una serie di ebook intitolata I racconti dell’Ernesto.
Confesso di non sentirmi imparziale nel giudicare la raccolta in questione. Non solo Stefano è un amico, ma è stato proprio a casa mia, durante una cena, che il comune amico Ernesto gli ha estorto la promessa di non limitarsi a scrivere romanzi, ma anche qualche racconto. Questo secondo volume della serie si intitola Distopie ed è dedicato alla fantascienza, anzi, alla particolare branca della fantascienza nota come distopia. Impossibile perciò evitare di parlarne qui (colpevolmente, a un anno dalla sua uscita).
Il pezzo forte di Distopie è il romanzo breve Lo schianto delle caramelle. Ambientato nella più classica delle distopie, uno stato di polizia con fortissime differenze sociali, parla di due sorelle clandestine che affrontano un pericoloso pellegrinaggio per consultare un oracolo, che per divinare il futuro usa uno strumento antichissimo: una copia del videogioco Candy Crush.
Sulla carta Lo schianto delle caramelle non sembra avere molti elementi che lo rendano interessante; ed ha pure l’aggravante di utilizzare come principale motore della trama i poteri mentali, un cliché che ha ancora cittadinanza nel cinema e nel fumetto, ma che dalla fantascienza scritta è quasi scomparso. E tuttavia basta iniziare a leggere per ricredersi completamente ed essere trascinati nella storia. Perché la buona fantascienza è fatta di dettagli, e qui sono tutti al posto giusto: personaggi credibili e che è impossibile non amare o odiare, tecnologie sorprendenti ma plausibili, e soprattutto una realistica ambientazione in un suk in cui si parla un bizzarro linguaggio italo turco. Alla fine spiace soltanto che l’avventura finisca troppo presto. Stefano nella postfazione promette di espanderla in un romanzo vero e proprio. Io, se fossi un editore, correrei a prenotarlo. Ma si sa, siamo in Italia.
Completano l’ebook due racconti inquietanti e dai temi fortemente simbolici. Mi è piaciuto molto Il vetro, tutto condotto sul filo della canzone di Lou Reed Magic and Loss, in cui Milano è cinta da una soffocante barriera trasparente che allude alle barriere meno tangibili, ma altrettanto difficili da valicare, tra le persone. Un po’ più convenzionale Fallen Feather, in cui Stefano accentua il suo lato più romantico contrastandolo con un’ambientazione violenta e sanguinosa.
Nel complesso, ottima fantascienza, più riuscita e originale di molta di quella che si trova in giro. La mia speranza è che Stefano continui a battere queste strade.
Interstellar

Cooper è un ex astronauta, che si è ridotto a fare l’agricoltore in un mondo messo in ginocchio da un’epidemia sconosciuta che decima i raccolti provocando tempeste di polvere. Finché non gli arriva in modo misterioso la possibilità di partecipare a una missione che andrà a cercare una possibilità di salvezza al di fuori del Sistema Solare…
Uno dei motivi che mi fanno amare il nuovo film di Christopher Nolan, Interstellar, è che è un vero film di fantascienza. Ossia: non un’avventura ambientata in uno pseudofuturo rutilante ma in fondo modellato sul passato, bensì una storia davvero incentrata sul rapporto tra l’uomo, la scienza e l’ignoto. Nell’incipit del film si respira davvero un’atmosfera da vecchia fantascienza (anche se poi la vicenda prende un taglio molto più moderno, e mi ha ricordato i romanzi di M. John Harrison).
Di Interstellar mi sono piaciute molte cose. In primo luogo la costruzione, complessa e articolata, piena di sorprese, in grado di tenere interessato lo spettatore per le quasi tre ore di durata, e che dipana con arditi parallelismi vicende lontane nello spazio e nel tempo ma destinate a intrecciarsi. Mi è piaciuto il modo in cui Nolan riesce a far capire la realtà del futuro senza entrare nei dettagli ma con poche scene efficaci (la caccia al drone, la discussione con la maestra). Ho apprezzato come ripropone in modo credibile ma innovativo topoi come l’astronave e soprattutto i robot (dall’aspetto totalmente disumano, ma simpatici, affidabili e rassicuranti: l’esatto opposto di come li vorrebbe il cliché). Ho ammirato il modo in cui è riuscito a visualizzare in modo convincente e comprensibile una realtà con più di tre dimensioni.
E mi pare che si possa dire che abbia raggiunto il suo scopo, che sembra essere quello di fare un film alla 2001: Odissea nello spazio (di cui ricalca in modo fedelissimo la struttura: messaggio da un’entità sconosciuta, lungo viaggio, incidente dovuto a contrasti sullo scopo ultimo della missione, uscita dal mondo e rinascita) rimanendo però comprensibile per lo spettatore medio.
Con tanti pregi, si può dire che è un capolavoro? Purtroppo no, a mio avviso. Perché Nolan, dopo aver messo in piedi una struttura grandiosa, per qualche motivo non riesce a mantenere il rigore di sceneggiatura che ha avuto in Memento o The Prestige (due altri suoi film che affrontano, in modi diversi, lo stesso tema: il mistero della nostra esistenza nel Tempo). Procede così a corrente alternata, con momenti entusiasmanti che convivono con dialoghi dimenticabili e scontati (la tirata sull’Amore, che banalizza un messaggio che il film sa esprimere con ben altra forza solo per immagini, oltretutto mettendola in bocca a una donna, per calcare sullo stereotipo) o carenze e incongruenze di sceneggiatura (il fatto che tutti siano convinti di aver ricevuto un aiuto da misteriosi alieni, ma nessuno si preoccupi di investigare; o il protagonista che dopo 30 anni di inattività viene immediatamente posto al comando di una missione perché nessuno è più esperto di lui, ma poi continua a fare domande come se non sapesse nulla di astrofisica). E anche con qualche aspetto scientifico poco convincente, che stona particolarmente in un film che in generale rappresenta scienza e tecnologia in modo credibile e realistico (ma su questo, per non annoiarvi, farò un post a parte).
Interstellar è un film ambizioso (persino troppo), originale, interessante, intenso. E nonostante questo un po’ irritante, perché sarebbe potuto essere anche migliore. Comunque da vedere.
La volta che Tullio Regge dialogò con Primo Levi
 Ieri è purtroppo scomparso, a 83 anni, il grande fisico italiano Tullio Regge. È stato uno scienziato di livello mondiale, i cui contributi (tra cui la teoria di Regge sulle interazioni tra particelle ad alta energia, e il metodo di calcolo di Regge per trovare soluzioni approssimate alle equazioni della relatività generale) sono stati mattoni importanti della costruzione della fisica moderna. Vorrei ricordarlo qui parlando di quello che forse è il suo libro più noto, il Dialogo scritto a quattro mani con Primo Levi.
Ieri è purtroppo scomparso, a 83 anni, il grande fisico italiano Tullio Regge. È stato uno scienziato di livello mondiale, i cui contributi (tra cui la teoria di Regge sulle interazioni tra particelle ad alta energia, e il metodo di calcolo di Regge per trovare soluzioni approssimate alle equazioni della relatività generale) sono stati mattoni importanti della costruzione della fisica moderna. Vorrei ricordarlo qui parlando di quello che forse è il suo libro più noto, il Dialogo scritto a quattro mani con Primo Levi.
Si tratta di un agile volume (un’ottantina di pagine tutto compreso) davvero insolito: non è che la trascrizione di una conversazione a ruota libera svoltasi nel giugno 1984, senza temi prefissati, tra Tullio Regge e Primo Levi (che sarebbe morto tre anni dopo). Sarebbe dovuta essere una semplice intervista per una serie in cui varie persone spiegavano in cosa consisteva il loro lavoro. Regge propose di avere come interlocutore Primo Levi, che accettò. E il risultato fu un testo (curato da Ernesto Ferrero) che trascende l’attualità, e viene ancora ripubblicato dopo trent’anni.
In Dialogo i due parlano davvero del più e del meno, ma come possono farlo due persone di eccezionale cultura: toccano perciò argomenti come la propria storia familiare, la scuola italiana, la fantascienza, la musica, l’ebraico, la teoria delle stringhe, la colonizzazione dello spazio, la morte termica dell’Universo, e così via, in un vertiginoso incrociarsi di collegamenti. E leggerlo è un po’ come entrare nell’intimità di due menti eccelse.
La scheda del libro (tuttora in catalogo presso Einaudi) dice che si tratta di “Uno dei rari momenti in cui la cultura scientifica e quella umanistica si ritrovano per dare vita a uno straordinario percorso di conoscenza”. Chi la legge potrebbe erroneamente pensare che si tratti di un confronto tra un umanista (Levi) e uno scienziato (Regge). Ma non è così. Perché Levi era prima di tutto un uomo di scienza, un chimico, e ciò ha segnato profondamente la sua narrativa, da Il sistema periodico a La chiave a stella. Mentre Regge era anche un uomo di lettere, alfiere della divulgazione scientifica, collaboratore di Le Scienze e La Stampa e anche autore di fantascienza con i racconti di Non abbiate paura. Ed è proprio questo che mi piacque tanto quando lessi Dialogo per la prima volta: il modo in cui le famose due culture, in Italia da sempre separatissime, si intrecciavano e si mescolavano senza sforzo apparente, e con risultati spettacolari. Per questo mi piacerebbe che fosse letto anche oggi: come esempio di una possibile unificazione culturale che, 30 anni dopo, non sembra essere minimamente più vicina, e semmai si è ulteriormente allontanata.
What If?
 xkcd è una delle migliori dimostrazioni del fatto che le normali regole editoriali non si applicano sul Web. Si tratta di un fumetto disegnato in modo approssimativo, senza dei personaggi veri e propri, il cui umorismo si basa in parti più o meno uguali su complesse questioni di scienza e tecnologia e sulla sottocultura nerd, e il cui titolo è un insieme di lettere privo di significato. Qualcosa vagamente nella direzione di The Big Bang Theory, ma molto, molto più di nicchia. Anche io a volte non capisco le battute e devo andare a cercare spiegazioni in giro per la Rete.
xkcd è una delle migliori dimostrazioni del fatto che le normali regole editoriali non si applicano sul Web. Si tratta di un fumetto disegnato in modo approssimativo, senza dei personaggi veri e propri, il cui umorismo si basa in parti più o meno uguali su complesse questioni di scienza e tecnologia e sulla sottocultura nerd, e il cui titolo è un insieme di lettere privo di significato. Qualcosa vagamente nella direzione di The Big Bang Theory, ma molto, molto più di nicchia. Anche io a volte non capisco le battute e devo andare a cercare spiegazioni in giro per la Rete.
Sembra la descrizione da manuale della negazione del successo, eppure è diventato uno dei fumetti più popolari del Web, al punto che il suo autore, Randall Munroe, è uno dei pochissimi fumettisti online a potersi mantenere solo con l’indotto della propria creazione (nonostante il fumetto in sé sia pubblicato gratuitamente con licenza Creative Commons, e gli introiti dei libri vengano versati in beneficienza).
Potrei parlarvi a lungo dei motivi per cui dovreste leggere (se già non lo fate) xkcd: l’umorismo paradossale, lo sperimentalismo che gli ha permesso di mettere in pratica radicali innovazioni nel linguaggio del fumetto, la spaventosa quantità di informazioni che si assorbe leggendolo, e così via. Ma non lo farò, perché oggi voglio parlarvi di un suo spin-off, che si intitola What If?.
What If? è un progetto collaterale, in cui Munroe risponde alle domande dei suoi lettori, testualmente ma con l’aiuto di illustrazioni in stile xkcd. Lo spirito dell’iniziativa è ben descritto nella definizione: “risposte scientifiche serie ad assurde domande ipotetiche”. In pratica Munroe (che ha un passato di ricercatore roboticista per la NASA) si diverte a prestare la sua competenza scientifica per soddisfare le curiosità più infantili o bizzarre. “Cosa succederebbe se lanciassi una palla da baseball a una velocità prossima a quella della luce?” “Cosa troverei se andassi indietro nel tempo di un milione di anni nel luogo dove ora si trova Times Square?” “Cosa mi succederebbe se per un microsecondo mi trovassi sulla superficie del Sole?” “Cosa accadrebbe se una persona possedesse tutto il denaro del mondo?”
What If?, come xkcd, è una lettura interessante è divertente. Ma io trovo che sia anche qualcosa di più. Penso che sia un fantastico esempio di educazione alla scienza. La maggior parte dei libri di divulgazione scientifica ha uno spirito irrimediabilmente didattico: si sforza di insegnare al lettore le nozioni che ritiene importanti, rendendole più digeribili attraverso un linguaggio semplificato o una presentazione accattivante. Munroe, invece, fa tutt’altro: nessuna delle nozioni che apprenderete dalla lettura di What If? potrà esservi utile a qualcosa, se non a soddisfare il vostro senso del bizzarro. Tuttavia, così facendo, trasmette qualcosa di molto più importante: un metodo.
Ogni sua risposta è infatti corredata anche della spiegazione di come ci sia arrivato: da quali ipotesi è partito, quali arrotondamenti ha fatto e perché, da dove ha preso i dati, e così via. In questo modo insegna come, applicando correttamente il metodo scientifico, sia possibile arrivare a soddisfare la propria curiosità. Non per qualche nobile scopo, ma semplicemente perché è divertente e dà soddisfazione. Mi pare un messaggio di una potenza straordinaria. Se fossi un professore di materie scientifiche farei di tutto per far conoscere What If? ai miei studenti.
Ora What If? è diventato anche un libro, che raccoglie il meglio delle risposte pubblicate sul Web, più molte altre di nuove. Inutile dirvi che la lettura non delude: finora ne ho letto solo un terzo, ma ho già incontrato un sacco di spunti interessanti e mi sono fatto delle gran risate. Il libro ha toccato il primo posto della classifica dei bestseller del New York Times per la saggistica (in questo momento è al terzo posto), ed sono previste edizioni tradotte in Russia, Cina, Giappone, Brasile, Corea e in quasi tutti gli Stati d’Europa, dalla Germania alla Grecia. Uno dei pochi Paesi in cui ancora non è prevista una traduzione è, guarda caso, l’Italia. Nel mondo editoriale nostrano ho captato interesse per il libro, ma misto a una buona dose di scetticismo: da noi, sembrano pensare tutti, un libro così venderebbe poco. Probabilmente hanno ragione. Ciò non toglie che è proprio in un Paese poco scientifico come l’Italia che questo tipo di letture sarebbe più necessario.

Coming Soon Enough
Abituato all’Italia, in cui la fantascienza è solitamente vittima di un totale disinteresse sia da parte degli ambienti letterari, sia di quelli scientifici, provo sempre una discreta invidia quando mi accorgo di come altrove sia invece considerata, anche in ambienti serissimi, una valida interlocutrice in grado di dirci qualcosa di importante sul futuro. Un esempio è il progetto Hieroglyph, di cui ho parlato ampiamente altrove, in cui un gruppo di noti scrittori di fantascienza ha provato a convertire in racconti le idee di vari scienziati, sotto l’egida dell’Università dell’Arizona. Oggi però voglio parlarvi invece di IEEE Spectrum, rivista organo dell’associazione internazionale degli ingegneri elettrici ed elettronici, che accanto a ponderosi articoli di microelettronica, robotica o nanotecnologia non disdegna di tanto in tanto di pubblicare articoli di futurologia che confinano con la fantascienza pura. E che, per celebrare i suoi 50 anni, non ha trovato modo migliore che pubblicare un’antologia di fantascienza.
Intitolata Coming Soon Enough (“in arrivo abbastanza presto”), l’antologia è disponibile in ebook e contiene sei racconti di autori noti e meno noti, che avevano come unico vincolo quello di inserire nelle loro storie qualche nuova tecnologia che potrebbe diventare realtà in un futuro non troppo lontano. Queste le opere inserite:
- Someone to Watch over Me di Nancy Kress parla di un futuro in cui nascondere una telecamera per spiare qualcuno è facilissimo. Il tema di una tecnologia che dà libero spazio agli sguardi altrui non è certamente nuovo nella fantascienza (basti pensare allo splendido Altri giorni, altri occhi di Bob Shaw, o all’inquietante episodio Ricordi pericolosi della recente serie televisiva britannica Black Mirror), ma il racconto di Kress propone un punto di vista psicopatologico sufficientemente insolito da essere interessante.
- A Heart of Power and Oil di Brenda Cooper è il racconto che mi è piaciuto meno. Il tema tecnologico (un drago volante realizzato attraverso la stampa 3D) era potenzialmente molto interessante, ma viene usato solo come sfondo per una prevedibile storia in cui un adulto si riscatta aiutando un ragazzino a trionfare, che avrebbe potuto svolgersi in qualunque epoca.
- Incoming di Geoffrey A. Landis affronta un altro tema sfruttatissimo della fantascienza: il Primo Contatto con gli alieni, rivisitato utilizzando i principi scientifici della moderna esoplanetologia. Tipica hard SF: più interessante per le idee che contiene che emozionante in sé.
- Grid Princess di Cheryl Rydbom è il racconto che presenta il quadro tecnologico più strutturato: è ambientato in un mondo in cui le persone vivono immerse in un flusso di informazioni continuo di cui l’Internet di oggi è solo una pallida antenata, e per alimentarlo è necessario dedicare enormi porzioni del territorio extraurbano alla raccolta di energia solare. Il tutto però è raccontato in modo intimista e poetico, lasciando la tecnologia sullo sfondo. Forse il mio preferito.
- Water over the Dam di Mary Robinette Kowal parla di tecnologie che renderanno possibile ricavare energia in modo molto più localizzato, rendendo obsolete le grandi centrali. Anche in questo caso però la tecnica resta sullo sfondo, mentre la storia di un’ingegnera costretta a lottare contro un capo maschilista avrebbe potuto svolgersi anche ai giorni nostri (anzi: speriamo vivamente che il nostro futuro sia diverso!).
- Shadow Flock, il racconto dell’autore più celebre, Greg Egan, è molto più lungo degli altri e si ricollega come tematica alla storia iniziale. Anche in questo caso si parla di privacy messa a rischio dalla tecnologia, con un’ingegnera esperta di droni costretta da una gang di ladri a usare le proprie capacità per carpire informazioni alle vittime di un furto. Egan è un fuoriclasse, e riesce come sempre a descrivere tecnologie future in modo perfettamente credibile. Come in un buon thriller, la tensione sale gradualmente, ed è un peccato che il finale aperto risulti un po’ anticlimactico e “didattico” rispetto alle potenzialità della storia.
Nel complesso, anche se, come quasi sempre accade in questo tipo di antologie tematiche, la qualità dei racconti è disuguale, il livello medio è più che soddisfacente, e tutte le storie offrono spunti interessanti sui nostri possibili futuri. E il prezzo è davvero basso: se sapete l’inglese, potete scaricarla per soli 1,99 $ in versione Kindle o iTunes.
Heaven & Earth
 Ebbene sì: con 46 anni di carriera alle spalle, gli Yes hanno prodotto un nuovo album in studio (il ventunesimo, più o meno, a seconda di come li vogliamo contare). E io sono qui a recensirlo per voi, o perlomeno per quei pochi cui l’evento può ancora interessare. Nel frattempo la band ha cambiato ancora una volta formazione: il cantante Benoît David, da poco subentrato alla voce storica del gruppo, Jon Anderson, è stato costretto ad abbandonare per problemi di salute. Al suo posto è entrato Jon Davison, già cantante dei Glass Hammer.
Ebbene sì: con 46 anni di carriera alle spalle, gli Yes hanno prodotto un nuovo album in studio (il ventunesimo, più o meno, a seconda di come li vogliamo contare). E io sono qui a recensirlo per voi, o perlomeno per quei pochi cui l’evento può ancora interessare. Nel frattempo la band ha cambiato ancora una volta formazione: il cantante Benoît David, da poco subentrato alla voce storica del gruppo, Jon Anderson, è stato costretto ad abbandonare per problemi di salute. Al suo posto è entrato Jon Davison, già cantante dei Glass Hammer.
Ho avuto la possibilità di vedere questa formazione in concerto lo scorso 18 maggio, al Teatro della Luna di Milano, e l’impressione è stata ottima. Si è trattato di un’esibizione totalmente retrospettiva, con l’esecuzione filologica e per intero di tre album storici: The Yes Album (1971), Close to the Edge (1972) e Going for the One (1977). Forse non l’occasione migliore per poter giudicare la tenuta della band, che con questi capolavori giocava sul sicuro. Tuttavia i quattro “vecchi” (che hanno tutti passato da tempo i 60 anni) mi sono sembrati in gran forma, mentre Davison (che ha la stessa età di The Yes Album!), pur non avendo la voce inimitabile di Jon Anderson, mi è sembrato sicuro e perfettamente a suo agio, molto più di quanto non fosse David. Perciò, quando ho saputo che un nuovo album stava per arrivare, mi sono messo ad attenderlo con curiosità. Anche perché il predecessore Fly from here non mi era affatto dispiaciuto.
I primi dubbi mi sono venuti quando ho ascoltato le anteprime del disco diffuse online. “Sembra un disco degli Asia”, mi sono detto. Il che non dovrebbe poi sorprendere, dato che due membri della formazione originaria degli Asia fanno parte anche degli Yes attuali. Tuttavia, fatta eccezione per il primo disco, ho sempre trovato gli album degli Asia soporiferi, rock AOR all’americana vagamente truccato da prog, roba di livello inferiore anche agli Yes meno ispirati.
Dopodiché hanno cominciato a piovere le recensioni online: una stroncatura senza appello dietro l’altra. Tanto che, quando finalmente il CD mi è arrivato a casa, mi aspettavo talmente poco da sperare che forse mi avrebbe riservato qualche sorpresa in positivo. Purtroppo così non è stato: Heaven & Earth è proprio un disco deludente.
Il primo problema sta nella produzione: il suono di questo disco è molto povero. Basso e batteria sono quasi sempre relegati sullo sfondo, e il mix generale è decisamente troppo “tastieroso” (e se lo dico io che sono un fanatico delle tastiere, potete credermi!). Ci sono a volte momenti di “vuoto”, in cui uno strumento, pur non facendo nulla di virtuosistico o particolamente interessante, rimane da solo o quasi. Tutto il contrario del sound sinfonico degli Yes. È stato probabilmente un errore affidarsi a Roy Thomas Baker, una vecchia gloria (fu il produttore di tanti album dei Queen) che conosce bene la band (lavorò con gli Yes durante le sessioni parigine del 1979 mai portate a a termine) ma che non è esattamente all’avanguardia. Mi chiedo perché non abbiano pensato a Steven Wilson, che sta facendo un lavoro eccellente nel remixare in quadrifonia il catalogo degli Yes.
Ma la colpa non è certamente solo del produttore. Anche la band non sembra all’altezza della sua fama, poco incisiva anche in quello che è sempre stato il suo massimo punto di forza, cioè la qualità degli interventi strumentali (principali colpevoli: Howe e White, svogliati e privi di nerbo). Soprattutto, le composizioni sono deludenti, e soffrono fortemente dei problemi che già cominciavano ad emergere in Fly from here: lunghezza eccessiva, con brani che si prolungano oltre i sei minuti senza contenere idee adeguate a giustificarlo; scarsa omogeneità, con transizioni faticose tra sezioni che sembrano avere poco in comune tra loro; e infine mancanza di grinta, il problema più grave di Heaven & Earth, quasi completamente adagiato su tempi lenti e soporiferi.
Analizzando i singoli brani:
- Believe Again è composta da Davison e Howe, e porta decisamente il marchio stilistico di quest’ultimo. Comincia molto bene con una bella melodia e un bell’arrangiamento, ma dura troppo, e finisce col perdersi senza un colpo d’ala che le doni nuova energia.
- The Game, scritta da Davison, Squire e da un collaboratore abituale di quest’ultimo, Gerard Johnson, ha una bella melodia pop, però tira il lungo per quasi sette minuti senza costrutto e significative variazioni. La chitarra di Howe appare davvero poco ispirata.
- Step Beyond è un altro brano scritto da Howe con Davison, caratterizzato da un semplice e ripetitivo riff di sintetizzatore. Molti l’hanno odiato, ma io lo considero uno dei pezzi migliori del disco: molto pop, lontano dal sound Yes (ricorda semmai i brani scritti da Howe per gli Asia, come One Step Closer, somigliante anche nel titolo), ma perlomeno equilibrato e con un po’ di originalità.
- To Ascend. Il batterista Alan White collabora raramente alla composizione dei brani della band. Questo zuccherosa ballata scritta con Davison purtroppo non rivela doti nascoste: è uno dei pezzi più insignificanti del disco.
- In a World of Our Own è uno strano pezzo di Squire/Davison con un ritmo cadenzato e atmosfera retrò da primi anni Settanta. Il momento WTF dell’album: cosa c’entra con tutto il resto?
- Light of the Ages è composta dal solo Davison, che sembra voler impersonare in tutto e per tutto lo stile di Jon Anderson. Questo tipo di pezzo sdolcinato, però, risultava spesso un po’ stridente anche in passato. La copia sbiadita proposta da Davison non vale l’ascolto.
- It Was All We Knew ripropone il mistero già incontrato nell’album precedente: perché Steve Howe, che pure nei suoi dischi solisti si dimostra ancora molto creativo, per gli Yes sfodera queste canzoni gradevoli ma in fondo mediocri? Belle armonie vocali, ma non decolla mai.
- Subway Walls, scritta da Downes e Davison, sembra un tentativo di salvataggio in corner. È il brano più lungo dell’album e l’unico che in qualche modo richiami il vero sound degli Yes. Basso e batteria sono finalmente presenti, e in alcune parti il pezzo funziona molto bene. Ci sono però alcuni momenti confusi che fanno scadere un po’ il tutto. Downes si concede due assoli di tastiere; il primo però utilizza un suono di archi sintetici veramente superato (sembra Revolutions di Jean-Michel Jarre, ma senza le percussioni elettroniche che gli davano un senso), mentre il secondo è un assolo di organo che lascia freddi se paragonato alle prodezze di un Wakeman.
In definitiva, non si capisce bene che cosa avessero in mente gli Yes con questo disco. La sensazione è quella di un gruppo privo di direzione, arrivato in studio senza un’idea precisa e assemblando a casaccio le idee portate dai singoli membri. Che non è quello che ci si si può aspettare da una band con più di 40 anni di storia. Forse l’assenza di Jon Anderson, più che per la voce, pesa per la sua capacità di dare un senso unitario ai contributi dei singoli membri.
Personalmente non ho mai condiviso la posizione, molto diffusa, secondo cui una band dovrebbe sciogliersi dopo che il suo periodo di maggiore creatività è passato, o quando viene a mancare un membro chiave. Nel corso dei decenni ho sempre apprezzato la possibilità di ascoltare nuova musica con lo stile degli Yes: anche se non era all’altezza di Close to the Edge, anche se non tutti i nuovi membri erano bravi quanto i vecchi, valeva la pena di ascoltare il risultato. In questo disco però rischia di non esserci nemmeno un brano degno di essere riascoltato nel tempo. In questi giorni la funzione random dell’autoradio mi ha riproposto un brano tratto da Open Your Eyes, che avevo sempre considerato il disco Yes meno riuscito in assoluto, e mi sono detto: “Rispetto a Heaven & Earth è decisamente meglio, almeno ha più grinta”.
Cari Yes, lasciatevelo dire da un fan che vi segue da decenni: se questo è il massimo che sapete fare oggi, meglio chiuderla qui.
L'uomo a un grado Kelvin
2060. Dopo essersi assentato misteriosamente, il professor De Ruiters, direttore di un importante centro di ricerca europeo, viene ritrovato congelato a bassissima temperatura all’interno di un macchinario, durante un esperimento pubblico di teletrasporto al Palazzo delle Stelline di Milano. Contemporaneamente, altri tre suoi colleghi si rendono irreperibili. Il detective Dick Watson della Polizia Europea viene inviato a indagare sul caso, scontrandosi subito con la Polizia Lombarda che preferirebbe non averlo tra i piedi. Il caso si rivelerà molto più complicato del previsto, coinvolgendo spie, criminali, hacker, e i segretissimi computer quantistici nel sottosuolo di Parigi…
Da molti anni ormai collaboro alle selezioni per il premio Urania. Di solito evito di parlarne pubblicamente, sapendo come il premio sia una macchina generatrice di polemiche per cui meno si dice e meglio è. Quest’anno però sono molto più coinvolto del solito: non solo la prima lettura dell’opera vincitrice è stata assegnata a me, ma mi sono occupato anche dell’editing e ho realizzato l’intervista all’autore inclusa in appendice. Non riesco perciò a trattenermi dall’esprimere un giudizio, ovviamente del tutto parziale, visto che questo romanzo lo sento anche un po’ “mio”.
E allora vi dico che questo libro, senza nulla togliere ai suoi predecessori, mi è piaciuto in modo particolare. Per tanti motivi. Per esempio:
- È un ottimo giallo: ha una trama intricatissima e solida, che procede in modo consequenziale senza affidarsi a coincidenze e colpi di fortuna. Niente a che vedere con certi libri in cui la trama investigativa è solo un pretesto per parlar d’altro.
- Tuttavia gli appassionati di fantascienza non devono storcere il naso: non si tratta di un giallo tradizionale cucinato in salsa futuribile. Tutt’altro: l’ambientazione fantascientifica è originale, coerente e saldamente ancorata alla trama investigativa.
- Ma il motivo per cui L’uomo a un grado Kelvin mi ha colpito particolarmente è un altro: la competenza scientifica con cui è scritto. Oserei dire che questo è il singolo libro di fantascienza italiana in cui il lato scientifico è trattato meglio, senza alcuna pedanteria ma con mano sicura e senza rifarsi a modelli anglosassoni.
Insomma, senza voler esagerare con gli elogi, è il tipo di romanzo di fantascienza italiana che mi piacerebbe leggere molto più spesso: avvincente, professionale, interessante senza rinunciare a essere divertente. Fatemi sapere se siete d’accordo con me.
Dodici
Un’epidemia ha trasformato in zombie quasi tutti gli abitanti di Rebibbia. Mentre i pochi superstiti si organizzano per tentare la fuga, Calcare è stato misteriosamente ridotto in fin di vita. Tocca ai suoi amici, Secco e Cinghiale, e a Katja, una ragazza rimasta bloccata con loro nel quartiere, trovare il modo di portarlo via prima che sia troppo tardi.
Non sono potuto andare alla presentazione milanese di Dodici, ma probabilmente è stata una fortuna: pare che fossero necessarie ore di coda per poterne ottenere una copia. Nel giro di un paio d’anni Zerocalcare (pseudonimo di Michele Rech) è passato da figura di culto a fumettista più ricercato di Italia, con spazi fissi su Internazionale e Wired e i suoi libri che si vendono come il pane. Tanto di cappello: per una volta il successo tocca a qualcuno che se lo merita.
Se già in Un polpo alla gola Zerocalcare si era allontanato in parte dallo stile delle storie che pubblica sul proprio blog, proponendo una trama articolata che prevale sulle pur numerose gag, qui fa un passo ulteriore mettendo in disparte il proprio alter ego e lasciando la scena ai comprimari Secco e Cinghiale e alla nuova arrivata Katja. Questi diventano protagonisti di una trama fantastica che sembra quasi un crossover con Safe Inside, il fumetto incompiuto di zombie che aveva realizzato per la DC Comics.
Mi riesce un po’ difficile dare un giudizio netto sul risultato. Da un lato, è evidente che l’autore non si è seduto sugli allori ed è in continua evoluzione: dal punto di vista grafico questa è una delle sue storie migliori. Riesce ad avere il ritmo di un fumetto d’azione senza perdere per strada il consueto umorismo, ed è particolarmente azzeccato il modo in cui le varie linee narrative sono rese con stili differenti e riconoscibili.
Sulla storia, però, sono più dubbioso: pur essendoci gag esilaranti e trovate geniali, e pur avendo apprezzato molto il personaggio di Katja (spero che in futuro riappaia!), trovo che in qualche punto il respiro sia un po’ affannoso, e che gli spunti proposti non siano sempre approfonditi come meriterebbero. Soprattutto, mi pare che la struttura narrativa completamente frammentata sia un virtuosismo un po’ fine a se stesso, che finisce per rendere la trama difficoltosa da seguire invece che moltiplicare la tensione.
Tirando le somme, non è probabilmente la miglior storia di Zerocalcare, come mi aspettavo che fosse. Ma restano comunque soldi ottimamente spesi.
