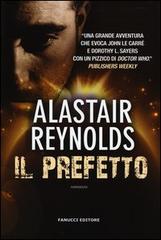
Quando uno dei più piccoli habitat viene distrutto con tutti i suoi 960 abitanti, e la colpa sembra ricadere sugli Ultra, la comunità di cyborg che si occupa dei viaggi interstellari, il prefetto supremo Aumonier decide di affidare l’indagine, politicamente delicatissima, al suo protetto Dreyfus. I due sono legati dall’aver subito entrambi delle ferite durante la lotta contro l’intelligenza artificiale assassina nota come l’Orologiaio. Dreyfus ha perso la moglie, mentre Aumonier si ritrova tuttora con un artefatto piantato nel collo, che da 11 anni le impedisce di dormire e minaccia di ucciderla se chiunque si avvicinerà a meno di sette metri da lei.
Ma nessuno dei due sa che dai risultati dell’indagine dipenderà la sopravvivenza dell’intera Fascia Splendente…
Lo dico subito: erano anni che un romanzo di fantascienza non mi conquistava quanto Il prefetto. Mi ha avvinto fin dalle prime pagine e mi ha tenuto fino alla fine senza un momento di noia e insoddisfazione.
Ritengo che nel romanzo di genere moderno il problema più importante che un autore deve affrontare sia la somministrazione dell’informazione: come e quando si passano dati al lettore. Da questo punto di vista, Il prefetto è semplicemente da manuale: gestisce alla perfezione la trama apparente che vivono i protagonisti, la trama nascosta che devono scoprire, e la trama del passato che sembra messa lì solo per fare background, e invece diventa sempre più importante col procedere della storia. Il tutto senza mai dare informazioni fuori contesto, senza che le azioni dei personaggi perdano una logica, e soprattutto senza mai far calare la tensione, procedendo con un grosso colpo di scena a capitolo per 700 pagine, senza mai far calare il ritmo, con un mix perfettamente equilibrato tra azione, mistero, politica e introspezione. Da applauso.
Non si tratta di un romanzo costruito intorno a concetti scientifici, come potrebbe essere uno di Greg Egan o di Ted Chiang: la struttura della trama è quella di una tradizionale investigazione, la cui posta in gioco è un’umanissima lotta per il potere. Nondimeno, si tratta di un’opera profondamente fantascientifica, nel cui contesto vengono trattati (senza fare lezioncine e senza pretesa di volerli esaurire o risolvere) temi interessanti come lo status di umanità delle intelligenze artificiali, i sistemi elettorali per una democrazia diretta in rete e molti altri, e vengono descritte varie tecnologie insolite e bizzarre. Il background di Reynolds, astrofisico prima di diventare scrittore, si vede nel modo in cui lascia correre la fantasia senza mai cadere nell’implausibile.
(Per vostra informazione: il romanzo è il quinto di una serie, detta Revelation Space dal nome dell’opera iniziale, anche se cronologicamente dovrebbe porsi prima di tutti gli altri. Non ho incontrato però alcuna difficoltà a seguirlo, e credo che ogni opera del ciclo sia leggibile a sé.)
Se dovessi fare un paragone, direi che questo romanzo mi ha dato le stesse sensazioni del capolavoro di Dan Simmons, Hyperion: ci ho trovato la stessa vertigine di complessità che gradatamente si ricompone in un’immagine coerente, e la stessa solidità nel rappresentare una società futura completamente diversa dalla nostra eppure profondamente umana. Nel confronto Simmons vince probabilmente ai punti per avere osato ispirarsi alla struttura dei Racconti di Canterbury, mentre il meno ardito Reynolds prende spunto, semmai, da Il silenzio degli innocenti.
Ciò non toglie che Il prefetto sia di gran lunga tra i migliori è più avvincenti romanzi letti negli ultimi anni. A questo punto non vedo l’ora di leggere qualcos’altro di Alastair Reynolds. Mi giunge voce che molto probabilmente Urania pubblicherà il prossimo anno un altro suo romanzo. Sarebbe bello che arrivassero in Italia prima o poi tutti gli altri dodici che ha scritto…
Categoria: Recensioni
Elysium
La Terra è ormai un pianeta in decadenza, la cui popolazione è sfruttata e vessata: povertà, polizia opprimente, lavori insicuri, sanità insufficiente. Solo i superricchi se la passano bene, nella stazione orbitante di Elysium, dove vivono in grandi ville e hanno a disposizione macchine che guariscono qualunque malattia.
Max, scontata una condanna per furto d’auto, non cerca più di arricchirsi per pagarsi il viaggio verso Elysium, e vorrebbe solo condurre una vita tranquilla. Ma quando un incidente sul lavoro gli lascia solo pochi giorni da vivere, per lui raggiungere la stazione diventa letteralmente una questione di vita o di morte.
Esordire con un film originale e significativo come District 9 è probabilmente il sogno di ogni regista. Ma comporta anche il problema che, qualunque film farai dopo, ci si aspetterà che sia all’altezza del tuo folgorante debutto. Se Elysium fosse stato realizzato da un esordiente, senza attori famosi e con qualche soldo in meno, saremmo qui a parlare di un promettente talento. Invece è firmato Neill Blomkamp, e dall’autore di District 9 ci aspettiamo non che faccia promesse, ma che le mantenga. Cosa che non gli è riuscita del tutto.
L’idea alla base del film non è delle più originali: il tema dei ricchi che si costruiscono un rifugio paradisiaco mentre il resto del mondo precipita verso la barbarie è stato declinato dalla letteratura e del cinema in svariate versioni: (la prima che mi viene in mente: il film Zardoz di John Boorman; ma sappiate che anche la trama del romanzo Più che umani di Paolo Lo Giudice, finalista più di una volta al Premio Urania ma purtroppo mai arrivato alla pubblicazione, ha diversi punti di contatto con quella di Elysium). Ma si può fare un buon film anche partendo da dei clichè. E nella prima parte di Elysium Blomkamp fa un ottimo lavoro nel descrivere una società in cui sovrappopolazione, scarsità di risorse, inquinamento, capitalismo sfrenato e uno stato di polizia dagli onnipresenti controlli informatici collaborano per rendere difficile la vita delle persone.
Il mondo dei ricchi è rappresentato in modo meno dettagliato, ed è una delle pecche del film. Va detto però che il design della stazione spaziale è veramente spettacolare: rivisita il modello a ruota di 2001: Odissea nello Spazio, ma in modo più ardito (è senza soffitto, dato che l’atmosfera è tenuta al suo posto dalla gravità artificiale¹), e desta nello spettatore (perlomeno quello sensibile al fascino dei viaggi spaziali) una meraviglia che è raro incontrare nei film di oggi.
Fino a metà il film è di qualità superiore: un ritmo invidiabile, un’atmosfera fantascientifica ben costruita, e anche un divertente cattivo un po’ fuori dagli schemi (interpretato dal protagonista di District 9, Sharlto Copley), e culmina con una lunga scena di combattimento davvero ben diretta ed efficace.
Nella seconda parte, però, il film si ammoscia completamente. In gran parte a causa di una sceneggiatura pasticciata, che tratta le questioni informatiche con un semplicismo e un’approssimazione non giustificabili nell’era di Internet. Per esempio, perché salvare un file nel cervello di una persona e non su una comune memoria? (D’accordo, lo facevano in Johnny Mnemonic, ma era per mantenere la segretezza, qui sembra una cosa scontata.) Perché ci si sorprende che un file segreto sia criptato? Perché da un certo punto in poi il file risulta leggibile, nonostante nessuno lo abbia decrittato? A che serve una protezione che uccide chi trasporta il file, ma lo lascia leggibile? Ma soprattutto: possibile che basti hackerare un computer per consegnare permanentemente il potere a qualcuno?
Tra tanta confusione, il film si sbarazza in fretta e furia del personaggio di Jodie Foster senza dargli una possibilità di svilupparsi, abbandona i temi politici, e si trasforma in un action movie risolto con il più banale inseguimento con scazzottata finale. Va aggiunto che la vicenda è racchiusa in una cornice ambientata quando il protagonista era ancora un bambino, che vorrebbe dare profondità al personaggio e fornire un appiglio per giustificare la sua redenzione finale, ma risulta sdolcinata e superflua.
In definitiva, il film resta vedibile, grazie all’ottima regia di Blomkamp che ne fa comunque un’altra cosa rispetto ai tanti e malriusciti film di fantascienza di medio budget che abbiamo visto in questi anni (Looper, Codice 46, Il mondo dei replicanti… e così via). Ma è comunque ben lontano dall’essere memorabile.
¹A onor del vero ho qualche dubbio che un sistema del genere non lascerebbe sfuggire presto tutta l’aria, ma sorvoliamo.
Monsters University
Come è cominciata l’amicizia tra Mike e Sulley, i due mostri protagonisti di Monsters & Co.? A quanto pare, già all’università, dove Mike si reca entusiasta, pronto a impegnarsi al massimo per realizzare il suo sogno di diventare uno spaventatore di professione. Il suo primo incontro con il futuro amico non è dei più felici, dal momento che il giovane Sulley è un fannullone che pensa di non aver bisogno di studiare, dato che la sua famiglia e il suo aspetto gli apriranno comunque tutte le porte. Dovranno succedere parecchie cose perché l’amicizia tra i due nasca davvero…
Monsters University è stato accolto dai più come un film divertente ma poco interessante, un altro segno della “normalizzazione” di Pixar che, dopo aver prodotto una quantità notevole di capolavori, avrebbe tirato i remi in barca in occasione della fusione con Disney, sacrificando la creatività a favore degli incassi. Maldisposto dalla visione del pasticciato e deludente Brave stavo quasi per prendere per buono questo giudizio e non andare neppure a vederlo. Ma avrei fatto male, perché invece si tratta di un film davvero molto riuscito, che nel curriculum della grande casa d’animazione non sfigura affatto.
Intendiamoci, Monsters University non è un Up o un Wall-E, e forse nemmeno un Ratatouille: non è un film che tenta di essere in qualche modo innovativo. Però non sta scritto da nessuna parte che un film per essere bello debba per forza essere innovativo. E Monsters University è un bel film proprio perché riesce a essere efficace pur muovendosi in un territorio collaudato.
La grafica è splendida. Pixar ci ha abituato così bene che non ci meravigliamo più, ma questo film mi pare aver segnato un ulteriore progresso, con enormi ambienti occupati da masse di personaggi in movimento tutti diversi tra loro, perfettamente illuminati. Anche gli esseri umani sono animati in modo perfettamente credibile (abissale la distanza coi bambolotti del primo Toy Story). Ma soprattutto, è eccezionale la cura e la fantasia con cui è stato animato ogni mostro: ce ne sono decine, e anche i personaggi assolutamente minori hanno una personalità e un aspetto caratteristico che si ricorda. E Sulley manifesta talmente tante espressioni ed emozioni nel film che bisognerebbe dargli l’Oscar.
Più che nel film originale, in questo caso la regia è riuscita a inserire nel film qualche tocco horror, più che opportuno, visto che in fondo è di mostri che si parla. Non solo il personaggio dell’Orrendo Rettore Tritamarmo è genuinamente inquietante, ma anche le scene ambientate nel mondo degli umani fanno paura. In particolare, uno dei momenti più alti del film è la scena in cui Mike si trova intrappolato in una stanza piena di bambini che non hanno paura di lui, con un rovesciamento di ruoli da capogiro tra mostro e vittime. (Ultimamente Pixar, da Brave a Toy Story 3, sta dimostrando un’abilità nelle scene horror che sarebbe bellissimo vedere applicata a un intero film, ma temo sia chiedere troppo.)
Quello che mi ha però conquistato è la sceneggiatura, che oserei definire perfetta. Il film non ha mai un attimo di stanca, e riesce non solo a essere divertente dal principio alla fine, ma anche ad avvincere con una storia non banale e che nel finale riserva parecchi colpi di scena. Paradossalmente Monsters University è una commedia studentesca molto migliore di quelle che vorrebbe parodiare, e ha il considerevole pregio di offrire anche una morale molto più realistica di quella offerta in modo martellante da tutto il cinema hollywoodiano. Non è vero che basta impegnarsi a sufficienza per ottenere qualunque risultato: nel film Mike diventa adulto proprio quando viene a patti con la realtà, riconosce di essere un mostro più buffo che spaventoso, e riesce a vivere con questa consapevolezza.
Pixar aveva già dimostrato con i tre Toy Story di essere in grado di sfornare seguiti dello stesso livello dell’originale, ma qui si va anche oltre. In definitiva Monsters & Co. è uno dei suoi film che ho amato meno, ho sempre pensato che non sfruttasse tutto il potenziale del tema. Cosa che invece fa Monsters university, che si rivela perciò migliore del suo modello.
Pacific Rim

Nel prossimo futuro, una breccia si apre sul fondo dell’Oceano e cominciano a uscirne enormi mostri alieni asssetati di distruzione. Per contrastarli vengono costruiti gli Jaeger, colossali robot da combattimento. I mostri però diventano sempre più forti e, mentre gli esseri umani fuggono dalle coste, gli ultimi robot si riuniscono a Hong Kong per tentare una disperata resistenza…
Per questo film esistono due possibili recensioni:
Recensione per chi vuole vedere un film di robottoni che si picchiano coi mostri spaziali:
Chiunque sia stato ragazzino negli anni ’80 stava aspettando da oltre trent’anni che arrivasse un film spettacolare e ben fatto coi robot giganti giapponesi accanto ad attori veri. Ebbene, l’attesa è finita. Guillermo Del Toro vi ha preparato un film interamente dedicato ai robottoni.
E quando dico interamente, parlo sul serio: in questo film non vi dovete sorbire insipide storie d’amore, melensi conflitti familiari, o tutta quella roba che nei film tratti dai supereroi Marvel passa per “approfondimento del personaggio” (ma in realtà è fuffa per riempire gli spazi tra un combattimento e l’altro). Qui ci sono solo combattimenti e preparazione ai combattimenti. E stop.
E i combattimenti, inutile dirlo, sono fatti benissimo. Se siete disposti a credere che il modo migliore di affrontare un mostro colossale non sia quello di bombardarlo, bensì di costruire un robot alto centinaia di metri che lo prenda a cazzotti o usi una petroliera come clava per picchiarlo, troverete le azioni estremamente realistiche, comprensibili e coinvolgenti, e i robot degni di tutta la tradizione dei mecha giapponesi.
Menzione speciale per le musiche di Ramin Djawadi, che riescono a rendere alla perfezione l’atmosfera da “colonna sonora di videogioco” senza mai risultare noiose o fastidiose.
Certo, il film qualche difetto ce l’ha. I personaggi sono quasi tutti integralmente stereotipati e, se non ci fossero i due scienziati pazzi e il contrabbandiere di “frattaglie di mostro” magistralmente interpretato da Ron Perlman a portare un po’ di divertimento, il film risulterebbe davvero greve. Inoltre, dal punto di vista della strategia militare, una puntata media di Gundam risulta più convincente di Pacific Rim, dove alcune delle cose che vengono dette non hanno senso, o sembrano supercazzole buttate lì solo per far succedere le cose. (Esempio: a un certo punto i mostri emettono qualcosa che sembra un impulso elettromagnetico, che spegne tutti gli Jaeger. Ma se possono fare una cosa del genere, perché non la rifanno poco dopo, quando sarebbe molto più utile? Ma soprattutto: uno dei robot non va fuori uso, e la spiegazione è che, mentre tutti gli altri robot sono “digitali”, questo è un vecchio modello e perciò è “analogico”. Mi spiegate perché mai un robot gigante costruito tra quarant’anni dovrebbe essere “analogico”, quaunque cosa significhi?)
Ma son piccole cose: se un film riesce a far applaudire la platea a scena aperta quando un robottone tira fuori la spada (è successo quando l’ho visto io), vuol dire che è sostanzialmente riuscito.
Recensione per chi vuol vedere un film di Guillermo del Toro, il regista di Il labirinto del fauno:
Qui cominciano le dolenti note. Se andate a vedere Pacific Rim perché siete fan di un regista che ha sempre mostrato di saper coniugare divertimento e profondità nel proprio cinema, cascate male. Perché questo film è bello da vedere, ma è decerebrato quanto quello di un qualsiasi mestierante hollywoodiano.
E sì che gli spunti non sarebbero mancati. A cominciare da questi mostri vomitati dal profondo della Terra che già nei film di Honda volevano esprimere la paura della contaminazione nucleare (e che qui invece non esprimono un bel niente).
Il problema purtroppo sono i personaggi, talmente monodimensionali che è impossible fargli dire qualcosa. Anche le migliori occasioni vanno sprecate: l’idea per cui i robot sono troppo grandi e complessi per un solo cervello umano, per cui vanno guidati da due uomini in reciproca simbiosi mentale, aveva il potenziale per generare infinite situazioni morbose, conflittuali o stranianti, ma non viene minimamente sfruttata.
In generale, la trama non presenta situazioni interessanti perché mancano avversari interessanti. Non c’è nessun vero conflitto tra gli esseri umani, e l’unico “cattivo” è un pilota che fa il bulletto senza una vera ragione. Mentre i mostri spaziali sono totalmente privi di personalità, e anche quando abbiamo l’occasione di guardare nel loro mondo e nei loro cervelli non scopriamo nulla di inquietante. Non fatemi dire che cosa avrebbe fatto Cronenberg di uno spunto del genere.
I temi politici sono poi del tutto assenti. A parte una frecciata nemmeno tanto convinta contro i politici inetti in generale, è difficile dare una qualsiasi interpretazione politica al tutto. Unica eccezione, la scena in cui la folla, avendo capito che il mostro sta cercando una persona in particolare, le fa il vuoto intorno: efficacissima, ma slegata da qualsiasi discorso.
Insomma, mi spiace deludervi, ma Del Toro ha fatto un film totalmente privo di contenuti. Certo, rispetto a Michael Bay il suo è un cinema molto più raffinato, pieno di riferimenti e citazioni, ed esteticamente molto più bello. Ma la piattezza intellettuale è quasi la stessa e, peccato mortale, non c’è nel suo film assolutamente nulla di spaventoso. È solo un giocattolo.
Concludo con alcune note:
- Se vi state chiedendo che tipo di spettatore sia io, faccio parte della seconda categoria: nonostante infinite visioni di Goldrake, Il grande Mazinga, Jeeg robot d’acciaio , Danguard, Gaiking, Daitarn 3, Gundam e simili, speravo comunque in un film del Del Toro che conoscevo.
- Non lasciate la sala prima di arrivare a metà dei titoli di coda! C’è una scena che merita.
- Non ho visto il film in 3D: ho preferito vederlo sotto casa, anche se temo di essermi perso qualcosa.
L'ambasciatore di Marte alla corte della Regina Vittoria
Sulla Terra sono sbarcati gli alieni del pianeta Marte, che però si sono dimostrati pacifici e disposti a condividere con noi la loro tecnologia. L’amicizia con Marte, però viene incrinata dal misterioso assassinio dell’ambasciatore marziano sulla Terra. A indagare viene chiamato l’abile investigatore Thomas Blackwood, le cui ricerche vanno a incrociarsi con quelle di Lady Sophia Harrington, un’esperta di paranormale che vuole scoprire l’identità del misterioso criminale noto come Jack il Saltatore…
Lo steampunk, il sottogenere della fantascienza che ambienta le sue storie nel passato (di solito nel XIX secolo), però rivisitandolo con l’introduzione di tecnologie differenti da quelle storiche, è di solito piuttosto divertente. Perché però risulti davvero interessante, è necessario a mio avviso che le tecnologie retrofuturistiche non si limitino a essere bizzarre, ma siano un’occasione per riflettere sulla storia della Scienza o su quella del nostro immaginario.
Questto romanzo, il primo di una serie che vede protagonisti gli investigatori Harrington e Blackwood, non è molto rigoroso dal punto di vista tecnologico. Se per alcune cose l’autore, Alan K. Baker, si sforza di inventare tecnologie compatibili con il pensiero ottocentesco, in altri prende delle scorciatoie. Per esempio, i suoi personaggi utilizzano computer che sfruttano spiriti folletti per recuperare informazioni: una trovata divertente, ma più parente del fantasy che di qualunque scienza alternativa.
Il punto di forza di L’ambasciatore di Marte è semmai quello stilistico. L’autore riesce a ricreare piuttosto bene uno stile narrativo ottocentesco, introducendovi però tutta una serie di elementi che provengono da scrittori posteriori, come per esempio Lovecraft. Ed è lo straniamento provocato dal vedere eroi del passato alle prese con avventure moderne a rendere il tutto interessante.
L’autore infarcisce il romanzo di trovate ironiche molto divertenti. Per esempio, il palazzo del Governo marziano che corrisponde al famoso volto osservato dalla sonda Viking I. Oppure il celebre esperimento di Michelson e Morley, che in questo universo, ovviamente, ha confermato l’esistenza dell’etere invece che dimostrare la sua inesistenza.
Il libro indubbiamente si legge di un fiato. Tuttavia l’autore non sfrutta fino in fondo le potenzialità parodistiche dell’universo che ha creato. A differenza di autori come Paul Di Filippo, che scrive steampunk proprio per prendere di mira la mentalità ottocentesca che ancora alberga in alcuni aspetti della nostra società, Baker finisce con l’adagiarsi negli stilemi dell’epoca invece che scardinarli, conducendo il suo romanzo verso un lieto fine un po’ insipido e prevedibile.
In definitiva, intrattenimento di qualità, scritto con arguzia e mestiere, ma di poca sostanza.
Viva la libertà
Il leader del principale partito italiano di centrosinistra, sfiduciato e contestato da più parti, decide di scomparire e si nasconde a Parigi a casa di una ex-fidanzata. Per evitare lo scandalo, il portaborse e la moglie lo sostituiscono con il fratello, un professore di filosofia sotto cure psichiatriche, che gli somiglia come una goccia d’acqua. Dovrebbe essere solo per qualche giorno, ma…
È impossibile non chiedersi cosa sarebbe successo se questo film fosse uscito con un anno di anticipo. La voce del pessimismo dice: probabilmente nulla. Però Viva la libertà fotografa con disarmante semplicità la crisi del PD che ha portato alla sua ennesima “non-vittoria”: il suo perdere contatto con i problemi e gli ideali dei propri elettori, confinandosi in schemi apparentemente realistici, ma in realtà autoreferenziali e perdenti.
L’idea della persona “normale” che sostituisce il potente e si rivela migliore di lui non è certo nuova (si veda per esempio I vestiti nuovi dell’imperatore), ma qui trova una declinazione migliore e a mio avviso più interessante. Il film, infatti, non cerca di sostenere che il buonsenso della persona comune o l’iconoclastia del folle possano ottenere risultati migliori dell’opera di un politico (tesi che sarebbe intrisa di falsa retorica, dello stesso tipo che ha portato al successo il M5S). Al contrario, il professore è una persona colta e preparata almeno quanto il politico che va a sostituire, e la sua follia si manifesta solo come totale mancanza di paura; quella paura che, viene detto esplicitamente, paralizza il politico e lo rende incapace di agire.
Il professore e il politico, quindi, non rappresentano due opposti. Al contrario, sono due varianti della stessa persona, le cui somiglianze vanno accentuandosi nel corso del film (i due, scopriamo, soffrono di disturbi simili, hanno amato e amano le stesse donne) fino al punto in cui non riusciamo più a distinguerli l’uno dall’altro. Ed è questo il messaggio più significativo del film: per riuscire non è richiesto un cambiamento radicale, basterebbe smettere di aver paura e di disprezzare le proprie radici.
Il film deve la sua riuscita innanzitutto a Toni Servillo, eccezionale nel suo recitare due personaggi identici mantenendoli chiaramente distinguibili con le sole espressioni facciali (e smettiamola di dire che è “il solito Toni Servillo”, che altri attori con la sua versatilità ce li sogniamo!). Ma anche Valerio Mastandrea funziona bene nella parte del portaborse che organizza il trucco per disperazione e finisce per rimanerne conquistato. Mi ha fatto poi un grande piacere ritrovare un novantatreenne ma ancora efficacissimo Gianrico Tedeschi, mentre purtroppo ho trovato la nota stonata nella monocorde Valeria Bruni Tedeschi.
Il regista Roberto Andò, autore anche del romanzo Il trono vuoto da cui è stato tratto il film, ha il merito di non pigiare inutilmente sul pedale del farsesco, e di mantenersi nei binari di una commedia garbata, con qualche puntata nel grottesco come il tango balllato di nascosto con la cancelliera tedesca. Anche i riferimenti alla politica “vera” sono sfumati e non giocano troppo sui facili riferimenti all’attualità (sebbene non sia difficile capire chi si nasconda dietro ai baffetti e agli occhialini dell’intrigante DeBellis).
Certo, qualche difetto il film ce l’ha. In particolare, molti personaggi sono poco approfonditi, e lasciano allo spettatore il compito di immaginare le ragioni che si nascondono dietro le loro azioni (facendosi sospettare che, se esplicitate, apparirebbero poco giustificate). Ma resta comunque una piacevole sorpresa: di film italiani così, con un’idea solida alla base, sceneggiatura e dialoghi solidi, e un buon cast internazionale, divertenti e accessibili ma senza essere vacui, vorrei vederne molti di più.
La luce del sole
Una bambina si risveglia, senza alcuna memoria di ciò che le è successo, in mezzo a uno scenario di distruzione. Tutto ciò che sa è che la luce del sole la respinge e che ha una terribile sete. Di sangue…
La luce del Sole (Fledgling) è l’ultimo romanzo scritto da Octavia E. Butler prima di morire, che Fanucci pubblica a otto anni dall’uscita negli USA.
Confesso di non aver mai letto nulla della Butler prima d’ora (una grossa lacuna, lo so, ma non si può leggere tutto!), e perciò mi sono accostato alla lettura con molta curiosità, data l’ottima fama che circonda questa autrice. Purtroppo però sono rimasto deluso: non posso dire se a non essere nelle mie corde sia la Butler o questo romanzo in particolare, però non lo trovo molto riuscito.
Per spiegarvi il perché sarò costretto a fare dei grossi “spoiler” , quindi se non volete che vi guasti qualche sorpresa non leggete oltre (allora però evitate anche di leggere la quarta di copertina, che spiattella molti segreti che invece il lettore dovrebbe apprendere solo gradualmente).
La cosa che mi ha convinto meno del romanzo è proprio la sua idea di base, e cioè che esista una razza, quella degli Ina, il cui comportamento è molto simile a quello dei tradizionali vampiri, ma che non ha nulla di soprannaturale.
Gli Ina per sopravvivere hanno bisogno di bere sangue, preferibilmente umano. La loro saliva contiene delle sostanze che rendono gli esseri umani docili, dipendenti e manipolabili a piacimento. Inoltre la luce diretta del sole provoca loro gravi ustioni, e di giorno cadono in un sonno profondo.
Tuttavia gli Ina non hanno nulla di soprannaturale. Non sono morti viventi, e si riproducono normalmente facendo sesso tra loro (anche se non disdegnano affatto il sesso con gli umani): non è possibile diventare Ina attraverso un morso. Si riflettono negli specchi, non temono i crocifissi, possono essere uccisi dalle pallottole (anche se hanno grandi capacità di rigenerazione). Inoltre tendono a non uccidere gli umani col morso , ma a crearsi un harem di “simbionti” che si lasciano mordere volontariamente per il piacere che ne ricavano.
A me sembra che questa versione dei vampiri tolga praticamente tutto il fascino e il mistero che normalmente si associa con la loro figura. Il morto che ritorna tra i vivi, l’umano che si trasforma in mostro, il soprannaturale, l’intrinseca malvagità, l’essere costretti a uccidere per sopravvivere: tutto quello che ha fatto la fortuna della narrativa vampiresca va perso. E senza guadagnarci nulla in realismo, poiché l’esistenza degli Ina mi pare tanto inspiegabile quanto quella della loro controparte soprannaturale. Sono, parlando francamente, la versione noiosa dei vampiri.
A questo si aggiunge il fatto che il romanzo imbocca tante direzioni senza seguirne alcuna fino in fondo. La parte iniziale è quella che regge meglio: la protagonista ha perso la memoria, sa di essere sopravvissuta a un eccidio, e cerca di capire quale sia la propria natura, che cosa le sia successo e come fare a rimanere in vita. Trovo discutibile il fatto che la protagonista possa ricordare facilmente come si usa un computer, ma abbia dimenticato totalmente tutto ciò che riguarda gli Ina (razza cui appartiene fin dalla nascita). Tuttavia questa parte ha se non altro una discreta suspence, e gira piuttosto bene.
A un quarto di romanzo, però, la protagonista si ricongiunge alla propria razza, dopodiché è tutto un susseguirsi di complicate spiegazioni sui costumi e la cultura Ina. Ho trovato questa soluzione molto pesante: avrei preferito di gran lunga apprendere le loro abitudini vedendole in diretta, piuttosto che attraverso una persona che ha perso la memoria e necessita di spiegazioni per ogni cosa.
Inoltre a questo punto il romanzo prende due direzioni: da un lato la scoperta e la punizione di coloro che hanno commesso l’eccidio, che avvengono molto lentamente ma senza alcun rivolgimento o autentico colpo di scena. Dall’altro c’è il tentativo della protagonista di crearsi la propria comunità poliamorosa di simbionti, un tema potenzialmente molto interessante, ma anche qui a mio avviso non sufficientemente sviluppato: la Butler è piuttosto brava a gestire le psicologie e le reazioni dei personaggi, ma tutto risulta un po’ troppo breve e schematico. Del resto, per descrivere bene un rapporto amoroso che coinvolge una mezza dozzina di persone sarebbe stato necessario dedicargli l’intero libro.
Aggiungo che ho trovato lo stile della Butler a volte prolisso e pedante, con dialoghi e descrizioni che si prolungano oltre il necessario descrivendo minuzie.
Riassumendo, La luce del sole mi è parso interessante soprattutto per le sue tematiche sociali, con una descrizione del funzionamento di una comunità di “vampiri” sicuramente ingegnosa. Nel suo insieme, però, la struttura del romanzo convince poco; si lascia leggere, ma incorre in lungaggini ed inutili complicazioni, e non porta fino in fondo nessuna delle idee che propone.
Looper
Nel futuro uccidere qualcuno e farla franca è diventato quasi impossibile, perciò per eliminare le persone scomode la malavita usa il viaggio nel tempo: le spedisce nel passato, dove troveranno un killer pronto a farle fuori. Questi killer vengono chiamati looper, perché la loro esistenza è un circolo chiuso: sanno che, per eliminare ogni prova, prima o poi si troveranno a uccidere una versione più anziana di se stessi.
Essendo Looper un thriller fantascientifico basato sui viaggi nel tempo, per giunta con un discreto successo di critica, mi aspettavo grandi cose. Invece ne sono rimasto piuttosto deluso. Non si può dire che il film sia privo di doti, ma mi è risultato impossibile entrare nella storia a causa delle continue incongruenze. Credo sia praticamente impossibile scrivere una storia di viaggi del tempo che non abbia delle falle logiche da qualche parte. Credo anche, però, che i film di questo genere si dividano in due categorie: quelli in cui le falle logiche vengono in mente solo dopo i titoli di coda, e quelli in cui sono talmente evidenti che le si vede in ogni scena. Purtroppo Looper appartiene alla seconda categoria.
Già la premessa principale appare piuttosto traballante. Perché, esattamente, è conveniente spedire le persone indietro nel tempo prima di ucciderle? Al riguardo il film è molto vago, si limita a dire che nel futuro le persone hanno addosso dei chip, ma non è chiaro cosa facciano questi chip per rendere impraticabile l’omicidio, o perché, se il problema è quello di nascondere le prove, non ci si limiti a spedire indietro nel tempo cadaveri, invece che persone vive.
Peraltro il film provvede presto a rendere il tutto ancora meno sensato, mostrandoci una scena in cui dei criminali rapiscono una persona allo scopo di spedirla nel passato dove sarà uccisa, e nel farlo non si fanno alcun problema a freddare un testimone lasciandone a terra il corpo. Dov’è la logica?
Poi ci sono le scene in cui, per comunicare con la versione futura di se stesse, le persone si incidono dolorosamente messaggi sul corpo, che si traducono in cicatrici sul corpo dell’alter ego. Molto suggestivo, però a me sembra che, se in passato mi sono inflitto delle cicatrici, dovrei ricordarmi di averle sempre avute, non dovrebbero apparirmi sul corpo dal nulla trent’anni dopo.
E poi ancora mi chiedo:
- Perché un looper deve eliminare se stesso? Non sarebbe molto più sensato che a uccidere la sua versione anziana fosse un altro looper?
- Premesso che la telecinesi e i poteri mentali sono roba da anni Cinquanta e non li vorrei vedere mai più in un film, non vi sembra un po’ cheap che nel futuro all’improvviso tutti abbiano poteri mentali, così, senza uno straccio di spiegazione?
- Perché nella prima metà del film si sono presi tanta briga di creare un’ambientazione futuribile, e poi la seconda metà è ambientata in un posto che sembra la fattoria di Nonna Papera?
- Non vi pare contraddittorio che Joe faccia il panegirico della moglie che con la forza del suo amore lo ha salvato dalla sua triste vita di criminale assassino, e subito dopo per salvarla non trovi di meglio che progettare una strage di bambini innocenti senza batter ciglio?
- Visto che tutta la seconda parte del film ruota intorno al tentativo di impedire l’ascesa del criminale noto come lo Sciamano, non trovate sia una carenza notevole della sceneggiatura il fatto che questo personaggio non venga mai mostrato e non si sappia nulla di lui e delle sue azioni?
- Non vi sembra un po’ eccessivo che Joe riesca a vincere uno scontro in cui è solo, legato, disarmato e bendato contro una dozzina di criminali armati fino ai denti? (Non sto esagerando.)
- Visto che Abe viene dal futuro e conosce tutto quello che succederà, perché non sa che Joe lo ammazzerà? E perché non arriva qualcun altro dal futuro a impedirlo?
Dulcis in fundo, faccio notare che, la prima volta che si vede Joe il vecchio che tramortisce Joe il giovane, quest’ultimo si risveglia e si ritrova accanto un biglietto. Successivamente la scena si ripete, e vediamo Joe il vecchio che tramortisce Joe il giovane e si allontana a grandi passi nei campi, senza lasciare alcun biglietto. Ovvero, come utilizzare uno dei topoi più classici del cinema sui viaggi nel tempo, la scena ripetuta più volte da diversi punti di vista, e sbagliarlo di brutto.
Ora, dopo aver letto tutto questo, potreste pensare che Looper sia un film totalmente inguardabile. Quello che fa incazzare è che non è così, e che in realtà ha parecchi buoni momenti. Bruce Willis e Joseph Gordon-Levitt riescono piuttosto bene a interpetare la stessa persona con trent’anni di differenza. Pierce Gagnon riesce a essere un bambino decisamente inquietante. Alcune scene di montaggio alternato tra i due alter ego sono da applauso, e in generale tutte le scene d’azione funzionano molto bene. E il finale è un gran bel finale. Insomma, con una sceneggiatura un po’ più curata, sarebbe potuto essere molto migliore.
Se siete il tipo di spettatore che non si cura più di tanto delle incongruenze logiche, e bada sopratutto alla spettacolarità, credo che Looper potrebbe piacervi molto. Se però, come me, di un film del genere amate il meccanismo ben oliato e la coerenza dei dettagli, allora temo che vedrete in questo film soprattutto una grande occasione perduta.
Le Brigate Fantasma
Le cosiddette Brigate Fantasma sono formate da soldati artificiali, che dal primo giorno di vita sono pronti a combattere e a obbedire agli ordini. Ma può considerarsi umano chi ha una personalità modellata prima della nascita?
Le Brigate Fantasma è il seguito di Morire per Vivere, nel senso che ha la stessa ambientazione ed è ambientato qualche anno dopo. Tuttavia le vicende dei due romanzi hanno in comune solo alcuni personaggi secondari, e non è quindi necessario leggerli in sequenza.
Recensendo Morire per Vivere, ho scritto di avere due riserve. La prima è che trovo poco credibile che una guerra interplanetaria si combatta con soldati di fanteria, sia pure potenziati. La seconda è che ho trovato troppo fastidiosamente militarista il sottinteso del romanzo, e cioè che l’espansionismo imperialista sia un dato comune a qualunque razza intelligente, e che l’unico modo per sopravvivere sia praticarlo meglio degli altri. Tesi, questa, che trovo criticabile non solo da un punto di vista ideologico ma anche semplicemente logico: l’Universo è straordinariamente vasto, e non si capisce bene per quali risorse dovremmo entrare in concorrenza con altre razze, specie considerato che esseri capaci di raggiungere altre stelle dovrebbero essere anche in grado di tenere sotto controllo la propria popolazione.
Queste riserve rimangono sostanzialmente invariate anche per questo secondo romanzo della serie (sebbene qui esistano degli accenni sul fatto che l’espansionismo terrestre potrebbe essere ingiusto e non necessario, che probabilmente verranno sviluppati negli episodi successivi, ancora inediti in Italia).
Al di là di questo, però, Scalzi si conferma un autore molto dotato, uno dei pochi in grado di scrivere romanzi avvincenti e divertenti, che non richiedono due lauree per essere compresi, ma che comunque pongono interrogativi interessanti.
Dal punto di vista della trama, Le Brigate Fantasma è per certi versi anche più interessante del predecessore. I dilemmi etici che i vari personaggi devono risolvere sono di non facile soluzione, e le svolte della trama arrivano spesso del tutto imprevedibili. Ho letto il romanzo volentieri e praticamente d’un fiato.
Volendogli fare delle critiche specifiche, ho trovato un po’ noiosa la parte dell’addestramento militare del protagonista, dato che non differisce molto da quella vista in Morire per Vivere. Inoltre l’umorismo nero visto nel romanzo precedente qui è un po’ più sottotono.
Ho poi seri dubbi scientifico-filosofici su un aspetto del romanzo, e cioè la possibilità di costruire esseri intelligenti ma privi di coscienza.
Questo tipo di dualismo (quello che Gilbert Ryle chiamava “the ghost in the machine“) è già stato confutato numerose volte (la confutazione più divertente mi sembra quella di Raymond M. Smullyan). Io credo che abbia ragione Daniel C. Dennett quando sostiene che non è possibile avere intelligenza vera senza coscienza.
Del resto lo stesso Scalzi cade in contraddizione quando dice che questi esseri si sentono incompleti e desiderano una coscienza: come può un essere privo di coscienza desiderare qualcosa?
Comunque sia, al di là dei miei molti dubbi, trovo Scalzi un autore interessante e una lettura molto piacevole. Consiglio quindi l’acquisto (anche perché stavolta la traduzione mi è sembrata esente da problemi vistosi).
Lo Hobbit – un viaggio inaspettato
Bilbo Baggins è uno hobbit, che vive felice e tranquillo nella sua casa nella Contea. La sua vita viene sconvolta quando un suo conoscente, lo stregone Gandalf, lo obbliga a ospitare tredici nani vagabondi, che progettano di invadere la tana di un drago per recuperare il tesoro dei loro antenati. Non si sa bene come, Bilbo finisce per aggregarsi alla compagnia in qualità di scassinatore. E lì cominciano i suoi guai…
Chiunque abbia letto Lo Hobbit di J. R. R. Tolkien si è probabilmente chiesto come sia possibile che un agile romanzetto destinato principalmente ai bambini si sia trasformato, nelle mani di Peter Jackson, in un trilogia di film di almeno nove ore complessive di durata. La risposta è che Peter e le sue sceneggiatrici non si sono limitati a tradurre in film la trama del romanzo, ma ci hanno inserito anche altre trame che provengono invece dalle appendici del Signore degli Anelli, dal Silmarillion e da altri scritti di Tolkien, in modo da ricollegarsi alla precedente trilogia cinematografica e spiegare in dettaglio tutti gli eventi accaduti in precedenza.
Motivo? “Operazione commerciale”, sento dire qualcuno, e indubbiamente questo è in parte vero. Tuttavia, prima di buttare la croce addosso a Jackson, va detto che Lo hobbit è un romanzo che narrativamente ha molto poco senso. Tolkien lo scrisse perché il suo editore gli aveva chiesto di scrivere un libro per bambini, e lui eseguì prendendo una fetta della colossale mitologia che stava concependo, e tagliando via tutti i passaggi troppo complicati. Il risultato è molto divertente e appassionante, ma anche piuttosto confuso. Per esempio, a un certo punto del libro Gandalf ha un impegno e scompare, per poi riapparire molto più avanti senza spiegare il motivo della sua assenza (gli esperti sanno che è stato a Dol Guldur, dove ha scoperto la vera identità del Negromante, ha parlato con Thrain prigioniero e ha scoperto l’esistenza dell’Anello del Potere, ma questo nel libro non c’è). Bilbo incontra Gollum e gli ruba l’Anello, ma non viene spiegato chi sia, e tantomeno quale sia l’origine dell’oggetto. Il “cattivo” del romanzo viene ucciso da un tizio mai visto prima. E così via. Insomma, non è stata poi una cattiva idea aggiungere un po’ di roba per ricavarne una storia un po’ più sensata.
Va anche detto che, mentre in Il signore degli anelli c’era pochissimo spazio per l’invenzione, data l’enorme quantità di materiale di cui tenere conto, qui Jackson, Walsh e Boyens (con Guillermo Del Toro, che sarebbe dovuto essere il regista) hanno potuto aggiungere del loro, con ottimi risultati. Sono riusciti a caratterizzare molto bene i nani, che hanno tutti personalità differenti e riconoscibili nonostante siano in tredici (in definitiva meglio che nel romanzo di Tolkien, dove sono una massa un po’ indifferenziata). E hanno trasferito con successo nel film un po’ di quell’estetica del gioco di ruolo che ha preso spunto da Tolkien per diventare un mondo a sé stante. Guardate per esempio il nano Dwalin, col cranio tatuato e la doppia ascia: sembra uscito direttamente da Warhammer, e proviene perciò non dall’immaginario tolkieniano, ma da quello degli innumerevoli fan che sui romanzi di Tolkien hanno ricamato, facendoli propri. Cosa che a me non dispiace affatto.
Soprattutto, gli autori si sono presi la libertà di mettere sotto i riflettori Radagast il bruno, personaggio molto minore del Signore degli anelli che era stato escluso dalla trilogia precedente, e al quale invece viene affidato qui un ruolo piuttosto importante. A partire dai pochi cenni dati da Tolkien, gli autori hanno creato qui un personaggio molto ben caratterizzato. Anche questo può essere visto come una concessione all’estetica del gioco di ruolo, in cui spesso sono proprio i personaggi minori a poter essere riplasmati per nuove avventure. Non so se Tolkien avrebbe apprezzato il Radagast di Jackson che viaggia per i boschi su una slitta trainata da enormi conigli, ma a me è piaciuto.
Per il resto, i pregi e i difetti del film sono sostanzialmente gli stessi della trilogia precedente. Tra i pregi metto la capacità di gestire il complicato universo tolkieniano rimanendogli fedele, e soprattutto il casting. Credo che la scelta di mettere Martin Freeman nella parte di Bilbo sia stata geniale, dato che mette in luce le affinità con il personaggio del dottor Watson che interpreta nella serie televisiva Sherlock: ambedue sono persone coraggiose ma tranquille, che sono messe a dura prova dal confronto con dei compagni completamente fuori di testa. (Nei prossimi film arriverà anche Benedict Cumberbatch, alias Sherlock Holmes, nella doppia parte del Negromante e del drago Smaug).
Tra i difetti metto, anche qui come nella serie precedente, un’enfasi un po’ eccessiva sulle scene di combattimento rispetto al resto, e poi alcuni particolari cambiati senza motivo e in modo peggiorativo, che risaltano molto proprio perché il contesto generale è quello di una grande fedeltà. Ho trovato sensato che l’orco Azog e suo figlio Bolg siano stati unificati in un unico personaggio, ma mi ha infastidito tantissimo che sia stato cambiato l’episodio dei tre troll Guglielmo, Berto e Maso. È la mia scena preferita del romanzo, si faceva riferimento ad essa anche nella trilogia precedente, e non vedevo l’ora di vederla (*). Arrivati al dunque, vedo che i nani, invece che essere catturati con l’astuzia uno ad uno, mettono in piedi una battaglia, e poi si arrendono quando i troll minacciano di uccidere Bilbo. È vero che non è molto logico che i nani si lascino ingannare dagli stupidissimi troll, come avviene nel libro, però che si arrendano (con la prospettiva di finire arrostiti subito dopo) ha ancora meno senso. Inoltre il trucco con cui il gruppo riessce a salvarsi, invece che essere portato avanti da Gandalf, diventa in gran parte opera di Bilbo. Questo può avere senso in quanto gli autori volevano mostrare Bilbo che gradatamente conquista la fiducia dei nani, però rimango ugualmente insoddisfatto: volevo vedere Gandalf che imita le voci dei troll!
Dal punto di vista visivo, non posso unirmi alle tante critiche verso l’uso della tecnologia a 48 fps: non ho notato particolari irregolarità nei movimenti, mentre ho trovato il film molto più luminoso rispetto a quanto siamo abituati. È la prima volta che guardo un film in 3D senza avere una sensazione di oscurità.
Semmai, l’uso del 3D fa sì che, a parte le scene d’azione appositamente concepite, il film appaia parecchio più statico dei precedenti, per la difficoltà di muovere la macchina.
In ogni caso, il giudizio finale è che guardando il film mi sono divertito non poco. Jackson è riuscito a mettere insieme il consueto mix di umorismo, azione ed epicità, e se avete apprezzato la trilogia precedente, se avete amato il romanzo o se vi piacciono i giochi di ruolo, non rimarrete delusi. Non è nulla di nuovo rispetto al Signore degli Anelli, ma nemmeno lo fa rimpiangere. E mi sono piaciute le libertà che Jackson si è preso nel manipolare l’universo tolkieniano. Direi che può bastare.
(*) In realtà ero convinto di ricordare alla perfezione questa scena, ma nei commenti mi hanno fatto notare che non era così. Ho quindi corretto il post.










